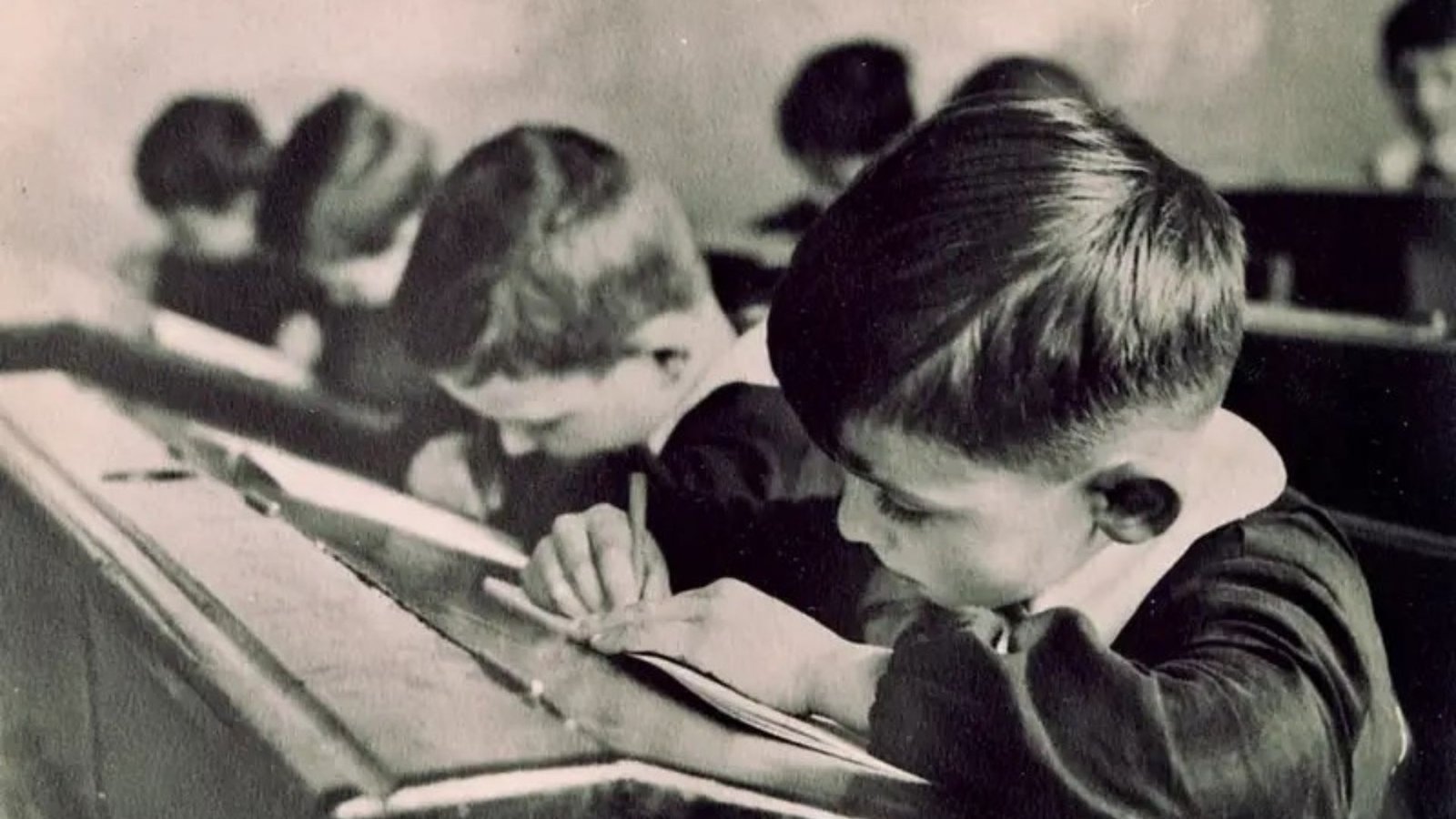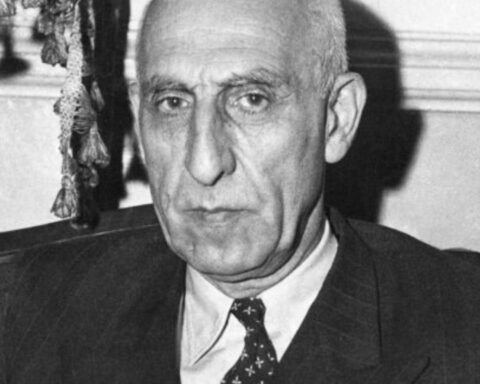Abolire il classicismo
Prima che si parli di una didattica della storia, ci si consenta una digressione: negli ultimi tempi si è molto discusso su quello che per alcuni sarebbe un passaggio concreto e simbolico per lo sviluppo della scuola italiana, ossia l’abolizione del classico. Quel che forse non tutti comprendono, però, è che il principio sotteso a questa aspirazione poco ha a che fare col classico inteso come indirizzo liceale e molto di più invece si riferisce a quello che, altrimenti, sarebbe chiamato classicismo. Ovvero, non si tratta di mettere in discussione la materia classica, ma la sua rappresentazione. Classicismo è, in altre parole, non lo studio della classicità in sé, ma una costruzione sociale e culturale, una sintesi di simboli che modellano la percezione del passato e, soprattutto, dell’attuale. Per capirsi attraverso un precedente: nell’Ottocento a essere messo in discussione non era tanto il canone policleteo o la scultura di Prassitele, ma l’uso che l’ambiente accademico ne aveva fatto per riprodurre, in una cultura moderna e di origine tardo-medievale, una rappresentazione e un’appropriazione dell’antico che con l’antico non aveva nulla a che fare. Era, in fondo, un esercizio anacronistico che non aveva più valore, ma che plasmava ancora le percezioni e i valori di una certa parte della società: ecco la differenza tra classicismo e classico.
Nel tema della didattica della storia il ruolo del canone è influente, poiché esso si fonda, a differenza che in altre materie, su una cultura e un sedimento secolari e condivisi. Da ciò consegue che un superamento del classicismo – e non del classico, perché a essere messa in discussione è la rappresentazione, non il contenuto – sia, in Italia, un passaggio cruciale e quasi obbligato se si vuole parlare di una riforma. Ma la messa in discussione del canone e dell’impalcatura ideale e metodologica che esso sorregge diviene tanto più complessa quando si distinguono, in essa, due criticità: una che riguarda un assunto ereditato che vuole abbinare alla progressione cronologica della materia storica la progressiva acquisizione degli strumenti di chi la studia. Dunque, una specie di evoluzione che, similmente a quella cognitiva del discente, si compie nello svolgimento delle epoche dal semplice al complesso. La seconda criticità si intravede nel già attuale e parziale tentativo di superare il canone senza metterlo davvero in discussione, convertendo tempo e risorse alla storia contemporanea in una crasi difficoltosa tra memoria ed educazione civica.
Leggi anche:
Il “secolo dell’umiliazione” europeo?
Primordio dell’individuo e primordio della storia
Si ripeta quel che è già noto: come molti sapranno e come si sente dire svariate volte, la scuola italiana è proiezione di una visione hegeliana di cui lo storicismo è il perno fondamentale. La formazione della coscienza dell’individuo, dunque, corre parallela alla materia che studia. Il bimbo è fanciullo, a uno stadio precoce ed embrionale della vita, e ad esso è demandato lo studio dell’origine dell’umanità, poiché, nella visione storicista, all’origine viene erroneamente abbinato il fondamento o il presupposto, mentre nello sviluppo si trova il compimento. Questa è un’ontologia fallace, ma non sono io che dovrei dirlo. Infatti, qui non voglio criticare tanto l’impostazione gentiliana e la sua supposta teleologia, bensì, piuttosto, l’effetto generalizzato che essa ha avuto nella percezione comune della materia storica e della causalità. Occorre, in questo senso, ripensare alle epoche storiche come “consustanziali” ed eliminare la dicotomia causa-origine. Ciò che viene prima non costituisce una forma embrionale o “precedente” di quel che viene dopo solo perché così appare cronologicamente. Entrambe le “fasi”, piuttosto, sono costituite da una pari complessità e, soprattutto, particolarità. Da questo deriva il fatto che le epoche vanno comprese ciascuna con una capacità di discernimento che la scuola primaria o secondaria di primo grado non possono permettersi sia per questione di risorse (il tempo non è infinito) che per le capacità richieste di chi apprende e di chi insegna.
La somma di tali criticità la si nota nello studio delle civiltà antiche che, per i primi anni, assomiglia più a una carrellata di popolazioni interscambiabili e ripetitive. Tutte, in fondo, hanno economie agricole, sistemi politici verticistici, culti pagani e arti belliche similari. Perciò, oltre una qualche differenza di sapore, il contenuto principale resta quello di lasciare intendere a chi studia che quello si tratta dello “stadio” originario della civiltà, dove cioè si trovavano già in nuce i rudimenti, le componenti embrionali, dei sistemi economici, sociali, politici e spirituali che osserviamo nella modernità. L’approccio cumulativo o progressivo sottinteso tende ad accomunare i principi dello studio storico con le basi di una materia come quella matematica. Alla scuola primaria si imparano le proprietà delle operazioni e l’aritmetica col pensiero di dover, un giorno, affrontare un’algebra complessa. Il punto è che lo stesso pensiero non può applicarsi alla storia, perché i principi della cronologia non corrispondono alle “basi” della comprensione della materia storica. L’assunto è così radicato nella nostra percezione che sin dai primi anni di scuola primaria la materia storica si basa sul tempo e la sua misurazione, quando in realtà essa necessita di strumenti spaziali e materiali, oltre che concettuali.
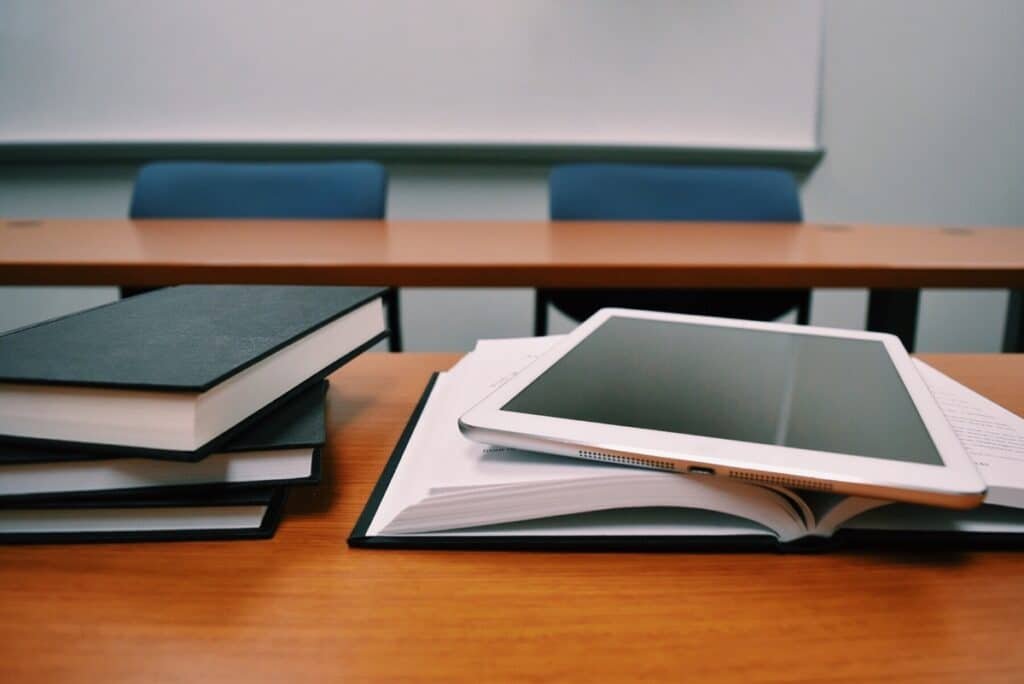
Leggi anche:
Non aprite quella box: se il Ministero non sceglie un metodo per la storia
La precedenza cronologica non presume semplicità. È vero, piuttosto, il contrario: la lontananza temporale del contesto è spesso accompagnata da una complessità che viene spesso sorvolata. Si richiede al discente uno sforzo di estraniazione dalla propria epoca e dal mondo direttamente osservabile che nella scuola porta, come è naturale, a un’approssimazione generica e priva di valore per le reali competenze o conoscenze dell’individuo. È naturale che in una società urbanizzata, industrializzata e moderna sia complessa la comprensione strutturale di società agricole, ritualizzate, comandate da sistemi di caste e aristocrazie guerriere, radicate in realtà cultuali ben diverse. In un sistema d’istruzione in cui le risorse sono limitate è necessario comprendere, dunque, come queste vadano allocate. Se dallo studio storico si vuole ottenere una profittevole coscienza critica e contestualizzata, e non un canone di fatti e detti memorabili, si dovrebbe ricostruire l’impalcatura della materia storica attorno alle epoche e alle coscienze contemporanee. Questo per due motivi: il primo è, come già detto, che la comprensione di epoche lontane e perdutesi nei meandri del passato richiedono, per fornire davvero una proficua conoscenza e contestualizzazione, uno studio specialistico che si raggiunge solo nella professione della ricerca. Questo non per dire che all’individuo dovrebbe esser preclusa la conoscenza di nozioni come le antiche civiltà mediterranee (anche perché questo è ciò che già avviene, di fatto, per il XX secolo). Si tratta, bensì, di modificare strutturalmente la loro importanza e ricalibrare attorno cosa orbiti la materia storica. Il secondo motivo è che, a fronte di mezzi e risorse limitati, al discente e all’insegnante dovrebbero essere richiesti, nello studio curriculare e obbligatorio della storia (nulla vieta poi percorsi aggiuntivi di approfondimento nei campi d’interesse), strumenti di comprensione che essi potrebbero già avere a portata di mano: il concetto moderno di stato e lo studio annesso della geografia, il pensiero e la visione del mondo di società paragonabili alla nostra, le questioni sociali ed economiche di un’epoca storica tecnica.
Studiare la storia contemporanea: i problemi della “memoria” e dell’educazione civica
Riconvertire il centro dello studio storico alla modernità e alla contemporaneità, dunque alla società da noi osservabile, non è compito semplice, poiché richiede, oltre che uno sforzo scientifico, uno sforzo politico. Finché la materia d’insegnamento si ferma a fatti che nella nostra realtà non hanno più valore politico, o almeno non in modo manifesto, come le conquiste di Ciro il Grande, questo problema non sorge. Quando si iniziano ad approcciare, invece, i fatti della contemporaneità, essi stessi vivi nella società, si rischia di incombere nella parzialità o in faziosi proseliti che del metodo storico poco hanno a che fare.
Come conseguenza, per riservare allo studio della contemporaneità uno spazio aggiuntivo, pur senza imbattersi nello spinoso problema politico di una riforma strutturale, si è spesso ricorso a occasioni eccezionali e alla cosiddetta educazione civica. Tra le occasioni abbiamo ricorrenze in cui lo studio del programma viene temporaneamente sospeso e in cui viene dedicato un lasso di tempo all’approfondimento di certe questioni: un giorno per i crimini nazifascisti, un giorno per la repubblica, un giorno per la lotta alla mafia. Il fine, dichiarato o meno, sarebbe quello di discernere l’attuale da un programma “ordinario” di storia, di modo che venga sottolineata l’eccezionalità, dove vengono sospesi per un momento gli strumenti abituali dello studio storico per imbracciarne alcuni più moralmente partecipi. Il problema, in questo caso, è che, pur rivestendo un ruolo fondamentale all’interno della comunità e della sua cultura politica (intesa nel senso di convivenza comune), la memoria non è la storia. Non tanto perché alla memoria debba essere imputata parzialità o addirittura la menzogna: la memoria si poggia sulla verità storica ed è da essa avallata. Piuttosto, memoria e storia svolgono all’interno della società funzioni diverse, poiché la memoria è un momento di comunità e di differente interiorizzazione, mentre la storia è una disciplina.
Leggi anche:
Ottanta (e più) modi per dire Liberazione
Isolare il contemporaneo e le sue tematiche a un’attenzione eccezionale nell’ambito della memoria e dell’educazione civica, oltre che essere una raffazzonata foglia di fico sopra le lacune dell’insegnamento, provoca l’effetto opposto a quello auspicato: anziché circoscriverne l’importanza e il sentimento comune che dovremmo nutrirvi, sottolinea ancor più fortemente la loro separazione da quello che è il “vero” programma di storia, ossia quello su cui insegnanti e studenti ripongono, durante l’anno, le maggiori attenzioni. L’educazione civica e la memoria, in questo caso, diventano ostacoli, momenti gregari e di seconda importanza in cui lo studio e l’insegnamento vengono trasportati in un’ambiente di sospensione dalla normale didattica. A tutti questi tentativi rientrano, ad esempio, le raffazzonate lezioni di diritto sulla costituzione repubblicana in cui, per soddisfare almeno quell’impulso che si ha generalmente nella nostra società di dover abbinare il concetto di disciplina e senso civico alla conoscenza di quel testo, gli studenti potrebbero essere portati a spendere minori energie che non su le verifiche di matematica o, appunto, storia, materie ordinarie e per questo percepite come più pressanti.
Diventa chiaro allora, soprattutto a coloro che delle scuole hanno un fresco ricordo in mente, che la materia storica debba passare attraverso una rivoluzione copernicana che sappia mettere al centro un vero studio del contemporaneo, e non una rivisitazione cumulativa e progressiva che porta con sé, ogni volta in modo sempre più precario e sovraccarico, la stessa struttura canonica.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!