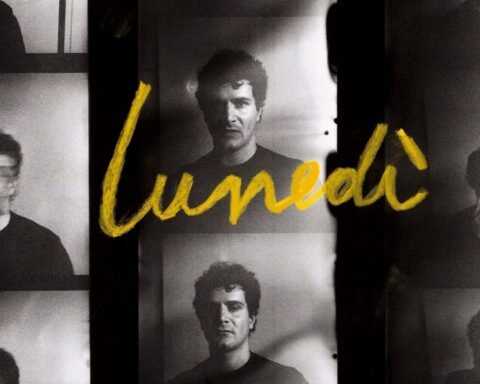Ci sono circa sette minuti, nel nuovo album LUX di Rosalía, che da soli valgono l’intero progetto. Non sono un semplice passaggio tra due tracce consecutive, ma un varco: un salto quasi brutale tra Mio Cristo Piange Diamanti e Berghain, rispettivamente traccia cinque e sei dell’album, in cui si compie una trasformazione musicale e concettuale così netta da riassumere la poetica dell’album. Sette minuti e ventisette secondi, per essere precisi, in cui il sacro si incrina, la luce precipita nell’ombra e la voce – prima sola e pura, poi moltiplicata e oscura – si fa rito.
Del nuovo album di Rosalía ne stanno parlando tutti: c’è chi ne analizza la svolta mistica, chi la dimensione orchestrale, chi l’audacia linguistica – canta in ben 13 lingue – chi la radicalità del progetto, chi ha giustamente posto l’accento sulla struttura: 18 brani (nella versione LP) divisi in 4 Movimenti, chiaro riferimento agli schemi della musica classica. Noi, invece, scegliamo un’altra strada. Ci concentriamo su due tracce soltanto perché, almeno per chi scrive, è qui che LUX si rivela con maggiore chiarezza. È qui che si condensa il suo enigma, la sua tensione, la sua ambizione. Ed è qui che il disco segna una prima cesura precisa, che ci dice Rosalía stessa: la fine del Movimento I e l’inizio del Movimento II. Una cesura che può essere letta almeno in due modi: come facciamo noi che scriviamo, insieme, come un unico racconto di trasformazione, oppure come il compimento di qualcosa che si chiude e la nascita di qualcosa che comincia. Funziona, perché LUX si lascia ascoltare in entrambi i sensi: è sia un flusso sia un rito di passaggio.
«LUX», il nuovo album
Rosalía, artista spagnola classe 1992, arriva a questo snodo con la maturità di chi ha già reinventato se stessa più volte. Dopo il fortunato Motomami e il suo vocabolario pop destrutturato, LUX si presenta come un movimento opposto: un album che cerca verticalità, profondità e densità. È un lavoro che guarda alla grande tradizione – quella dell’aria, del canto liturgico, della polifonia, dell’orchestrazione – per poi romperla dall’interno, trasformandola in qualcosa di nuovo, di ambiguo, di affascinante. Il tutto mantenendo vivi i richiami al flamenco e alle sonorità tipiche della musica catalana che hanno sempre contraddistinto la sua musica. L’accoglienza della critica, unanime e quasi devota, sottolinea proprio questo: LUX è un album mistico che non rinuncia alla contemporaneità, un album che non teme la complessità, che pretende ascolto e concentrazione.
Leggi anche:
La notte di Halloween è offerta dal nuovo album dei Florence + The Machine: «Everybody Scream»
La preghiera di una voce sola
È proprio nel cuore dell’album, tra sola voce e un coro oscuro, che si gioca una delle partite più interessanti dell’intero album. Mio Cristo Piange Diamanti, traccia numero 5 dell’album interamente cantata in italiano (imperfetto, come hanno fatto notare alcuni), è un brano verticale. La voce di Rosalía emerge limpida, nitida, sospesa. Non è solo l’italiano a creare questa atmosfera: è il suo uso come lingua della tradizione operistica, come erede del canto sacro e delle arie che hanno segnato secoli di musica europea. L’italiano qui non è solo la lingua più funzionale, è la lingua più filologica, custode di un passato operistico a cui la cantante tende (ed è lei stessa a dichiarare in diverse interviste che il suo obiettivo era realizzare “una moderna aria”). Porta con sé un’eco culturale che si percepisce anche senza comprenderlo: un timbro di solennità, di elevazione, di intimità sacra.
La voce, sola, diventa strumento di radicale espressione emotiva: l’artista la usa con rispetto, portandoci direttamente nell’atmosfera del palcoscenico senza tempo, da quell’operistico ai più recenti musical. Gli archi la sostengono con discrezione: non accompagnano, amplificano. Mio Cristo Piange Diamanti è una liturgia intima che richiama la dimensione sacrale e la figura di Cristo, evocata attraverso quei gesti d’amore che nei Testi Sacri incarnano la sua bontà: «Quanti pugni ti hanno dato / che avrebbero dovuto essere abbracci? E quanti abbracci hai dato / che avrebbero potuto essere pugni?».
L’artista, come raccontato in un’intervista al noto giornalista e critico musicale Zane Lowe, per il testo sembrerebbe anche essersi ispirata al legame tra San Francesco e Santa Chiara, simbolo di un amore puro e contemplativo. Un riferimento che amplifica la delicatezza del brano, in cui l’italiano – con la sua dolcezza e solennità – rende ancora più potente la carica emotiva. Il tutto si raccoglie in quel «Ti porto, ti porto sempre», quasi una carezza rivolta ai santi e alla loro capacità di custodire e amare.
La caduta nella notte
Poi, all’improvviso, tutto cambia. Berghain, che oltre ad essere la traccia che segue è il singolo che anticipa l’album, entra con prepotenza. Non solo perché introduce elettronica, percussioni, orchestrazione densa – realizzata con la London Symphony Orchestra – ma perché presenta un’altra lingua: il tedesco. Qui il cambio non è solo fonetico, timbrico ed emotivo. È culturale. E storico. La transizione dall’italiano, erede del latino, al tedesco sembra ripercorrere una frattura secolare: quella tra cattolicesimo e protestantesimo. Da una parte la lingua “alta”, verticale, riservata ai pochi, evocatrice di un mistero custodito; dall’altra la lingua della Riforma, quella che, con Lutero, spezza il monopolio del latino, porta la parola sacra tra il popolo e la democratizza. L’italiano di Mio Cristo Piange Diamanti evoca una liturgia chiusa, destinata agli iniziati, costruita sulla distanza tra il divino e l’umano. Il testo di Berghain al contrario infrange questa distanza: è accesso, comprensione, orizzontalità. È profondamente figlio del nostro tempo pur restando, in qualche modo, fuori dal tempo. Non sorprende quindi che il brano risuoni nelle radio di mezzo mondo e compaia ovunque sui social: la sua stranezza, così radicale, contrasta con tutto ciò a cui siamo abituati – ed è proprio questo a renderlo irresistibile.
Leggi anche:
I nostri pensieri in «Una lunghissima ombra» di Andrea Laszlo De Simone
Rispetto al pezzo che lo anticipa, in Berghain la voce ora è moltiplicata, stratificata, profonda. Dove c’era elevazione, ora c’è caduta. Questo passaggio è un gesto estetico potentissimo: Rosalía non si limita a cambiare lingua, ma cambia paradigma. Sposta l’ascoltatore da una cattedrale barocca a una navata sotterranea, da un momento di adorazione solitaria a un rito collettivo, oscuro e pulsante.
Musicalmente, Berghain è costruita come un labirinto. L’orchestra non accompagna più; ingloba. Il ritmo non sostiene; trascina. Il brano, cantato in tre lingue – tedesco, spagnolo e inglese – si muove come una creatura viva, fluida. Il tedesco, lingua emotivamente dominante del brano, diventa una corrente che attraversa il pezzo e ne cambia la temperatura. La voce non sale più verso l’alto, ma scende nelle profondità, si confonde con la massa sonora, si moltiplica in echi, cori e controcanti che creano un senso di vertigine. Uno smarrimento che anche il videoclip riesce a rappresentare con grande efficacia. Con Mio Cristo Piange Diamanti, però condivide la velleità della sonorità ed dell’impostazione operistica, almeno nella porzione cantata dall’artista in tedesco.
La celebrazione dell’abisso è resa anche dalle parole del testo: «Seine Wut ist meine Wut” / «La sua rabbia è la mia rabbia»; «Sé que me funde el calor / Sé desaparecer / Cuando tú vienes es cuando me voy» / «So che il calore mi scioglie / So come scomparire / Quando tu arrivi, è allora che io me ne vado». Berghain diventa così una metafora, un luogo non fisico ma spirituale, dove si consuma un rito: lì si intrecciano pulsioni primordiali e desiderio di trasformazione, come nel club berlinese da cui prende il nome, ma trasfigurato in esperienza interiore, quasi mistica.
L’estasi e la ferita
E nel finale, quando la struttura si ripete come un breve canone, la sensazione è che la musica abbia preso vita propria. La ripetizione sonora assume una forza ipnotica, quasi ossessiva, e trova nella voce di Björk il suo veicolo ideale: un timbro inconfondibile, che attraversa con naturalezza registri più ruvidi. La cantante islandese usa il respiro come elemento ritmico, quasi un’eco, modella la pronuncia come materia plastica e trasforma il suono in un gesto espressivo, creando una tessitura vocale che è insieme fisica, emotiva, profondamente sperimentale e – ancora – spirituale («L’unico modo in cui sarò salvata è grazie a un intervento divino», ci dice). Il brano sembra chiudersi su se stesso come un anello, quando una voce (maschile, per la prima volta), appartenente al musicista statunitense Yves Tumor, pronuncia in loop un’unica sola frase finale che ha la durezza di un verdetto: «I’ll fu** you till you love me». Non è un finale conciliante, bensì il ritorno alla materia dopo l’estasi del rito. Un’antipurezza dove la parola dominante è volgare e spaesante ed evoca secoli di supremazia dell’uomo sulla donna, espressa – anche – tramite la fisicità.
Il ritorno degli archi non è casuale: è l’elemento caratterizzante della prima parte del brano. Proprio come nel principio della forma-sonata (l’organizzazione del materiale musicale all’interno di un singolo movimento), il richiamo di un materiale già ascoltato attiva nel nostro cervello un naturale meccanismo di riconoscimento. La musica, infatti, vive sull’equilibrio tra ciò che ci è familiare e ciò che ci destabilizza: l’esposizione introduce i temi, lo sviluppo li mette alla prova e la ripresa li riporta “a casa”. Così, anche qui, il finale – pur muovendosi verso territori più instabili – non rinuncia a recuperare un elemento che riconduce l’ascoltatore all’inizio del brano: gli archi protagonisti, a cui si aggiungono con enfasi le percussioni. Una scelta che crea continuità formale e rafforza la coerenza interna del pezzo, proprio come fanno i grandi esempi della tradizione sonatistica.
Il rito e la rivelazione
Questi sette minuti condensano la tensione di LUX: una musica che abita il confine tra sacro e profano, tra tradizione e sperimentazione, tra esclusione e accessibilità. Rosalía non costruisce un semplice contrasto, ma un dialogo tra opposti che si illuminano a vicenda. Mio Cristo Piange Diamanti e Berghain sono poli, ma non distanti. Una è invocazione; l’altra è incarnazione. La bellezza di queste due tracce non sta solo nel salto, ma nella necessità del salto: Rosalía mostra come la spiritualità non sia un’unica voce, bensì un coro di contraddizioni. In un mondo che chiede chiarezza immediata, questi sette minuti, esattamente come l’intero album, offrono complessità. E quando finiscono, lasciano un desiderio irresistibile: tornare indietro, riascoltare, cercare di capire come due brani così diversi possano essere così inseparabili eppure così distanti. E invece parte La Perla, traccia più orecchiabile e pop che racconta di una rottura amorosa. Un moderno valzer dal sapore nostalgico che gioca sulla struttura musicale a cerchio tipico dei tempi ternari. Bellissimo. Ma questa è un’altra storia.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!