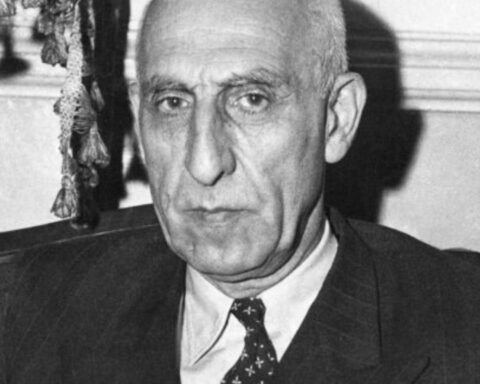Nell’epoca della valuta digitale, degli acquisti online, delle carte di credito, abbiamo meno occasioni di osservare e maneggiare le monete, alle quali sicuramente – salvo tra i collezionisti – non si fa più grande attenzione. Ma soprattutto nell’epoca di internet, dei social, dei giornali, delle televisioni, le monete non rappresentano più un mezzo di propaganda politica e di affermazione personale o collettiva. Le monete del passato, però, rappresentano per noi un’inesauribile miniera d’informazioni.
Usate, grazie alla loro diffusione capillare, come strumento di propaganda e di affermazione del potere, le monete ci forniscono un’enciclopedia di simboli, di abbreviazioni, di immagini, di fatti storici da interpretare. In questa sede, restringendo il campo all’ambito medievale – periodo complesso e affascinante – proveremo a comprendere la diffusione e l’impiego di una particolare moneta: quella d’oro. Quella in oro era una valuta preziosa, non disponibile sempre e ovunque. Battuta in condizioni di particolare benessere e stabilità (specie quella in oro purissimo) è segno di prosperità e stabilità politica.
In periodi di magra, in condizioni militari o gestionali precarie, in assenza di giacimenti a disposizione, le monete battute erano quelle in rame, in bronzo, al massimo in argento, mal che andasse in qualche lega di scarsissimo valore intrinseco. La scelta storiografica di seguire l’oro, dunque, ci consente di focalizzare l’attenzione su particolari fasi storiche del Medioevo, che hanno consentito a città, stati, re o imperatori di battere moneta di altissimo valore, garanzia economica di affidabilità e consistenza delle risorse pubbliche.
Dall’aureo romano al solido bizantino: l’oro nell’Impero d’Oriente
La moneta d’oro medievale discendeva da quella romana. Cerniera tra la valuta antica e quella medievale è stato, non a caso, l’Impero bizantino. L’oro romano era l’aureus (l’aureo), dal valore di 25 monete d’argento. Sebbene vi siano diversi esempi di aureo romano precedenti al I secolo a.C., proprio con Cesare si fissa la coniazione regolare e più importante di moneta d’oro a Roma. Prime forme di aureo italico risalgono almeno al 250 a.C., forse in Campania. La consistente coniazione in oro del I secolo a.C. fu quella battuta a nome del Prefetto dell’Urbe Aulo Irzio, per celebrare i trionfi di Cesare. La moneta in oro, perno dell’economia romana, fu poi battuta in età imperiale, soprattutto da Augusto.
Erede diretta della moneta d’oro di età cesariana, fu il solidus (solido) emesso da Diocleziano tra il III e il IV secolo d.C. Moneta centrale nell’economia bizantina – anche come segno di stabilità e garanzia – il solido (da cui derivano i termini “soldato”, “assoldare”, “al soldo”) fu nuovamente coniato, dall’imperatore Costantino I. Era una moneta dal peso di 4,5 grammi. Questa moneta, della quale furono coniati anche sottomultipli (il tremisse di 1/3, e il semisse 1/2) era ritenuta molto stabile e fu il cardine dell’economia bizantina, ma anche di molti paesi che gravitavano intorno all’Impero o che con esso erano in rapporti.
Il solido rimase pressoché invariato in valore fino al IX-X secolo, cioè finché il potere bizantino non subì particolari scossoni. Era, insomma, la moneta di un impero fiorente e stabile, simboleggiava sicurezza, ricchezza, influenza politica e militare degli imperatori di Costantinopoli. Se in età romana vi comparivano sopra i simboli pagani (la dea Venere nel caso della moneta di Cesare), sugli aurei bizantini, da Costantino in poi, iniziarono ad essere presenti simbologie cristiane (Costantino approfittò di questo strumento di propaganda per affermare la propria cristianità). Simbolo più usato, oltre alla croce, il Chrismon, formato dalle lettere “X” e “P”, da Χριστός, cioè Khristòs.
Nell’Alto Medioevo nacque a Bisanzio una nuova moneta d’oro, il nomisma. Questa valuta prese il posto del solidus, sebbene col passare del tempo subì svalutazioni e talvolta perdita di peso e di purezza della materia prima. Tuttavia, il nomisma rimase moneta di scambio fondamentale fino a oltre il XIII secolo, accompagnando di fatto la vita dell’Impero di Bisanzio. Abbiamo esempi importanti dell’evoluzione del nomisma, ad esempio sotto l’imperatore Alessio I Comneno. L’imperatore Alessio, negli ultimi decenni dell’XI secolo, durante lo scontro con il normanno Roberto Guiscardo, coniò un nomisma. Questa moneta presentava sul fronte il busto di Cristo, sul retro San Demetrio in piedi di fronte ad Alessio Comneno.
L’oro dei barbari e la scomparsa con la monetazione carolingia
Soprattutto per l’Alto Medioevo al di fuori del contesto bizantino l’impiego dell’oro – se si escludono gli Arabi, di cui parleremo più avanti – non ebbe largo impiego, soprattutto per il suo elevato valore e per la mancanza di disponibilità consistenti, ma forse anche per praticità. Goti, Longobardi, Franchi e Visigoti coniarono alcuni esemplari in oro, talvolta anche per affermarsi rispetto al dominante potere bizantino degli imperatori, con i quali, come sappiamo, alcuni sovrani dei regni barbarici tentarono di competere, anche imitando i modelli orientali.
In particolare presso alcuni popoli barbarici ebbe diffusione il tremisse, che abbiamo detto essere stato un terzo del solido aureo, pesante circa 1,5 grammi. Si consideri che presso alcuni popolo barbarici, specialmente quelli di tradizione nomade, battere moneta fu un’assoluta novità. Inizialmente le loro embrionali organizzazioni statali ebbero difficoltà anche a cogliere il senso dell’utilizzo della valuta, che iniziarono a battere ma scambiandola poi a peso (dato il valore intrinseco) senza badare invece al valore nominale.
Sotto l’impero di Carlo Magno, unica organizzazione occidentale che per certi versi poteva aspirare a concorrere in qualche modo con l’impero di Bisanzio, la monetazione aurea tuttavia sparì. All’oro si preferì battere moneta in argento. Nacque con Carlo Magno, difatti, la moneta più diffusa nel Medioevo, il “denier“, cioè il denaro argenteo, nome derivato dall’antico denarius romano. Il peso di questa moneta era di poco più di un grammo. Nonostante la forza militare e una discreta stabilità, l’impero carolingio non riuscì a battere e sostenere una monetazione aurea, anche perché privo delle disponibilità di cui era in possesso Bisanzio.
L’oro degli Arabi, la coniazione in Sicilia e il caso dei Normanni
A disporre, invece, di ingenti quantità d’oro e a battere regolarmente moneta aurea furono gli Arabi. Ricordiamo dai manuali scolastici di storia di quella imponente espansione araba che ebbe inizio dal VII secolo d.C. in tutto il Mediterraneo. Partiti dal vicino oriente, gli Arabi conquistarono a poco a poco tutta l’area dell’Africa settentrionale, sbarcando poi in Sicilia e in Spagna. La moneta cardine del sistema arabo, fu il dinar, che continuò ad esistere addirittura fino al crollo dell’Impero ottomano. Moneta in oro a 22 carati, pesava circa 4,25 grammi, poco meno del solido bizantino.
La monetazione araba, ovviamente, mancava di raffigurazioni, sempre presenti sulle antiche monete romane e su quelle bizantine (tranne nel caso dell’iconoclastia). Il motivo è religioso. Sappiamo che il culto delle immagini è vietato dalla religione islamica, così come lo fu, solo per certi periodi, nel mondo bizantino. Pertanto sul dinar arabo erano esclusivamente presenti scritte in arabo, ma senza simboli o immagini. Il dinar si diffuse rapidamente nella Sicilia musulmana, non solo fino all’avvento dei Normanni, ma per un certo periodo anche dopo.
I Normanni, infatti, non conoscendo ancora bene il sistema monetario, decisero di lasciare invariata la monetazione araba che trovarono in Sicilia, continuando ad usare il dinar, ma anche il tarì, il sottomultiplo del dinar, sempre in oro, pesante circa 1 grammo. Queste monete di riferimento diedero una grande stabilità al sistema economico arabo, così come il solido aureo fu moneta di riferimento del sistema bizantino.
Avere tra le varie valute – oltre a quelle in bronzo, rame o argento – una moneta aurea di riferimento, significava potere politico, sicurezza economica, garanzia negli scambi. Il potere d’acquisto e di commercio dei bizantini e degli arabi, che battevano monete d’oro, era certamente maggiore rispetto a quello di popoli – principalmente barbarici – che battevano solo in argento o addirittura esclusivamente in rame e bronzo.
Tornando ai Normanni, il regno di Sicilia basò col tempo il proprio sistema economico su monete d’oro simili a quelle arabe, imitando di fatto il dinar e il tarì, modificando però la simbologia e l’aspetto delle monete. Dati i rapporti tra Normanni e Papato, infatti, era inconcepibile che essi continuassero ad autorizzare in Sicilia e nel sud Italia la circolazione di monete con scritte in arabo, riferite alla religione musulmana.
Anche perché i Normanni presenteranno la loro conquista della Sicilia quasi come una crociata, di liberazione di una terra cristiana, preludendo anche a quelle che da lì a poco avrebbero avuto luogo in Terrasanta. Ecco, dunque, che sulle monete normanne iniziarono allora a comparire croci, madonne, scritte latine e riferimenti al Cristianesimo.
Il ritorno all’antico: l’ambizioso Augustale di Federico II
Seguendo la linea dell’oro, quindi il potere economico e politico nel bel mezzo del Medioevo, la rassegna ci conduce al XIII secolo e all’impero di Federico II di Svevia, che ebbe il cuore proprio a Palermo, in quella che era stata la corte normanna, dalla quale Federico discendeva da parte materna. Il sovrano illuminato, amante della cultura e della multiculturalità; colui che trattò col sultano Al Malik Al Kamil. Ebbene, proprio sotto Federico, dal 1229, fu battuta una nuova e importante moneta d’oro, che suggestivamente l’imperatore volle chiamare Augustale, ispirandosi all’antica Roma, della quale si sentiva erede politico.
L’Augustale, nonostante la breve durata, fu moneta stabile e di grande valore, battuta principalmente dalle zecche imperiali di Napoli, Brindisi, Messina. La moneta pesava ben 5,33 grammi, in oro a 20,5 carati. L’esemplare, oltre a rappresentare concretamente il potere e di Federico II e del regno di Sicilia, rievocava l’antichità romana alla quale il Sacro Romano Impero di Federico guardava, dato che sulla moneta l’imperatore si fece rappresentare in toga e corona d’alloro, come gli antichi, mentre sul retro fece incidere un’aquila imperiale tipica della tradizione romana.
L’oro delle città italiane: fiorino, ducato e genovino
Abbiamo sottolineato, fin qui, come battere moneta d’oro significasse solidità per le casse statali, potere politico, potere militare e di risorse, influenza sul mondo. Un privilegio quasi sempre degli imperatori e dei re. Persino i popoli barbari, spesso intenti a realizzare monete di rame, bronzo, al massimo argento, evitavano di inserirvi raffigurazioni troppo personalizzate o con attributi troppo simili a quelli imperiali bizantini, perché ciò avrebbe rappresentato una sfida all’Impero più potente del mondo, il cui capo – l’imperatore – avrebbe potuto intenderla come invito a una prova di forza o come un tentativo di scavalcamento.
A un certo punto, però, dal Basso Medioevo in poi, nuove realtà si affacciavano sul panorama mondiale e Mediterraneo: le città. In particolar modo le grandi e ricche città italiane, quelle dei mercanti e quelle dei navigatori. Tra tutte Venezia, Genova e Firenze. Quest’ultima molto nota per i banchieri e per i mercanti, mentre Venezia e Genova estendevano i propri domini sul mare; tanto che, a un certo punto, Venezia entrò in competizione e scontro diretto con la stessa Bisanzio.
Queste potenti realtà cittadine iniziarono a battere una moneta loro e, per la prima volta, assistiamo (siamo a inizio XIII secolo) a valute d’oro coniate dalle città, non dai re, non dagli imperatori. A Firenze dal 1252 apparve il fiorino d’oro (2,5 grammi, puro a 24 carati), a Genova il genovino d’oro (simile al fiorino), mentre Venezia emise il ducato d’oro (anche detto zecchino), a partire dal 1284, anch’esso in oro puro. L’oro ha rappresentato, insomma, non soltanto un prezioso di intrinseco ed enorme valore, ma anche la stabilità di stati, imperi, città, intere economie, nonché il prestigio, la forza e la ricchezza dei grandi poteri politici.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!
RIFERIMENTI ESSENZIALI:
- Renata Cantilena, La moneta in Grecia e a Roma
- Daniele Castrizio, Manuale di numismatica medievale
- Daniele Castrizio, Manuale di numismatica bizantina e medievale
- Alessio Fiore, Alma Poloni, L’economia medievale. Un profilo storico (secoli V-XV)
- Warren Treadgold, Storia di Bisanzio
- Averil Cameron, I bizantini
- Leonardo Capezzone, Medioevo arabo. Una storia dell’Islam medievale (VII-XV secolo)