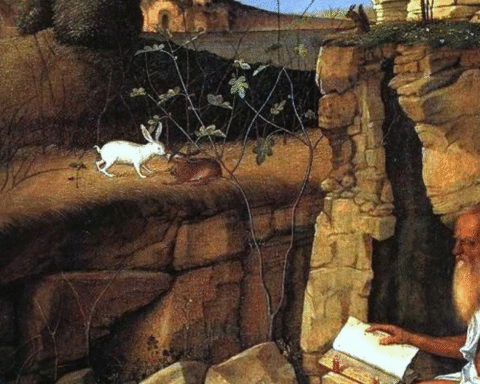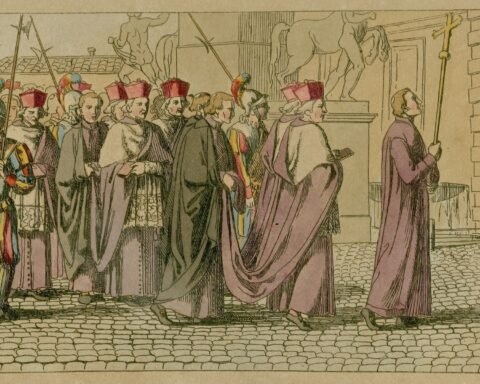Sul treno in ritardo al mattino, pigiato in piedi contro altri corpi nervosi e circondato da volti rassegnati che scrutano i reel di Instagram, fuggono tra pagine di libri o guardano all’illusione di libertà fuori dai finestrini tra campi e città gelidi, il pendolare in cerca di distrazione si chiede: «Ma come siamo arrivati qui?».
Per definizione il pendolarismo è il fenomeno consistente nel duplice spostamento quotidiano di masse di lavoratori e studenti da casa al posto di lavoro, e viceversa (Treccani), che a prima vista potrebbe sembrare così generica da potersi applicare a qualsiasi periodo storico. Perché gli umani hanno sempre lavorato. Ma quanto possiamo effettivamente andare indietro alla ricerca di un fenomeno simile nel corso della nostra storia? È davvero una parte ineluttabile del destino umano? O altrimenti, quando possiamo collocare l’inizio delle disgrazie del pendolare?
Non si tratta di una banale ricerca sullo spostamento dal punto A al punto B al mattino e sul tragitto inverso alla sera; in tal caso si tratterebbe solo di una rassegna di orari dei treni, mezzi di trasporto e percentuali, dell’appagamento dei sensi su cui i feticisti delle statistiche non corrono il rischio di leggere storie di sacrifici, di sveglie prima dell’alba e di avventure poco gratificanti a caccia dell’unico treno che non sia in ritardo quel giorno. Un’analisi davvero esaustiva in questo ambito richiede di ragionare anche soprattutto su come siano cambiati due fattori nelle vite degli esseri umani: il lavoro e le città, e su quanto siano legati contrariamente a quanto abitualmente si pensi.