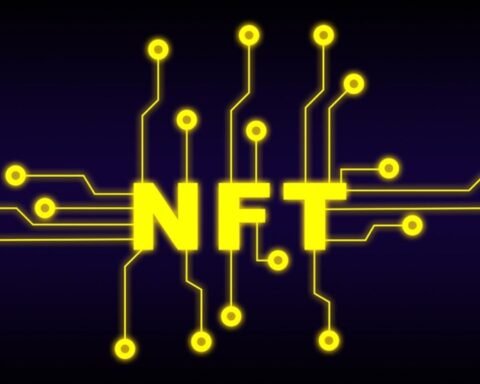Éric Rohmer (1920-2010) amava sostenere che i buoni dialoghi sono quelli composti in fretta, senza troppo riflettere. Forse, al vecchio cineasta simbolo “timido” della Nouvelle Vague, avrebbe fatto piacere un omaggio scritto alla stregua delle sue sceneggiature: seguendo cioè una certa piega del cuore, andando incontro alla rinfusa alle cose che contano davvero, attraversando le tracce segrete lasciate un po’ per caso sul percorso. Sono i modi di raccontare le esistenze – in questo caso un’esistenza, la sua – seguendo l’arte del guardare alla vita: il cinema non dice la realtà, non spiega la natura, ma riassume, secondo un modo di pensare caro allo stesso Éric Rohmer, il senso di tutta un’esistenza. La telecamera è un oggetto tecnico che permette di captare la bellezza che, in fondo, altro non è che «la bellezza della vita».
Come riassumere il ricco percorso di un regista che è stato al contempo sceneggiatore, critico cinematografico, letterato, romanziere, professore di letteratura, insegnante universitario e molto, molto altro ancora?
Al pari dei suoi colleghi appartenenti al movimento della Nouvelle Vague, Éric Rohmer ha iniziato scrivendo di critica per diverse testate, a partire da Les Temps Modernes, rivista letteraria e filosofica fondata da Jean-Paul Sartre e da Simone de Beauvoir nel 1945. Nel 1950 creò lui stesso un giornale, La Gazette du cinéma, sul quale scrisse alternando la collaborazione con La Revue du cinéma, per approdare infine ai beneamati Cahiers du Cinéma dove sarà capo redattore dal 1957 al 1963. Questi ultimi erano stati fondati da André Bazin, sommo critico e intellettuale che resterà per Rohmer e per i vari François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol e Jacques Rivette, un grande maestro a cui ispirarsi per costruire la propria idea di cinema.
Éric Rohmer nella vita avrebbe voluto fare molte cose. Già dai tempi del liceo avvertiva una grande predisposizione per la letteratura, che lo porterà, una volta ottenuto il diploma, a tentare per ben due anni consecutivi l’accesso alla prestigiosa École Normale Supérieure (un istituto superiore comparabile alla nostrana Scuola Normale di Pisa). Fallirà – questa sarà soltanto una delle prime anomalie della sua vita – e seguendo i genitori trasferitisi per motivi lavorativi a Clermont-Ferrand, si iscriverà alla Facoltà di Lettere Classiche. Tenterà in seguito, una volta terminati gli studi, di passare il difficile concorso dell’Agrégation, che permette ancora oggi ai giovani laureati di diventare professori nelle scuole superiori, ma anche qui, senza successo. Ripiegherà per il più modesto Capes – insegnamento alle scuole medie – che gli garantirà uno stipendio sicuro per poter coltivare a lato le sue grandi passioni: letteratura e cinema. Dopo circa sei cortometraggi realizzati con pochi mezzi, seguendo una linea amatoriale, Rohmer si cimenterà nel suo primo vero film: Le signe du lion (Il segno del leone, 1962) ma anche in questo caso il successo tarderà ad arrivare.
Più anziano rispetto ai colleghi della Nouvelle Vague, Rohmer porterà avanti per tutta la vita un cinema atipico e povero, lontano dai movimenti cinematografici proposti in Francia e più in generale in Europa tra gli anni ’60 e ’90. Nel corso della sua lunga carriera realizzerà ventitré lungometraggi, suddivisi quasi interamente in tre grandi gruppi: Les six contes moraux (I sei racconti morali, realizzati tra il 1963 e il 1972), Comédies et Proverbes (Commedie e proverbi, 1980-1990) e Les contes des quatre saisons (I racconti delle quattro stagioni, 1990-1998). A questi si aggiungono altri titoli che si collocano al di là dei cicli proposti e che sono basati su materiale scritto direttamente da Rohmer. È il caso di Quatre aventures de Reinette et Mirabelle (Quattro avventure di Reinette e Mirabelle, 1986), L’Arbre, le maire et la médiathèque (L’albero, il sindaco e la mediateca, 1993) o Les rendez-vous de Paris (I rendez-vous di Parigi, 1995) dove il regista si cimenta nelle tematiche a lui più care, sviluppando l’arte del film ad episodi e riscoprendo così un nuovo modo di valorizzare il cortometraggio. La particolarità di queste pellicole sta nella leggerezza con cui vengono raccontate dinamiche semplici e quotidiane: i personaggi, perlopiù femminili, sono letti per quello che rappresentano, la loro professione, le insoddisfazioni e i desideri inespressi. Sovente attraverso il dialogo – non è da dimenticare che il cinema di Éric Rohmer è anzitutto un cinema «della parola» – si citano opere filosofiche o letterarie e sebbene la trama appaia spesso inconsistente, questi film risultano ricchi e complessi proprio per la vasta quantità di riferimenti. Al contrario di ciò che si può pensare, la cultura rohmeriana non è mai appesantita da un intellettualismo dogmatico: i concetti e i diversi rimandi sono soltanto accennati, come fossero un vezzo, una curiosità da osservare in silenzio.
Éric Rohmer, che amava scrivere e che si è sempre ritenuto un “ibrido” a cavallo tra due grandi arti, accordava un’immensa importanza alla parola e alla letteratura. Per questo motivo, i rari film che non sono tratti da racconti scritti in prima giovinezza o da abbozzi di romanzo, sono ispirati alle grandi opere letterarie del passato: è il caso di La Marquise d’O (La marchesa von…) (1976), Perceval le Gallois (Il fuorilegge) (1978) o ancora, per citare la sua ultima fatica cinematografica, Les Amours d’Astrée et de Céladon (Gli Amori di Astrea e Céladon) (2007).
Quando Gilles Deleuze cercò di trovare una chiave di lettura alla monumentale opera del regista, azzardò l’idea che se I sei racconti morali potevano assomigliare a «una collezione archeologica degli anni ‘60», il ciclo delle Commedie e Proverbi si cimentava invece in una sorta di «punto della situazione attorno agli anni ‘80». Rohmer non può essere compreso visionando un solo film: per entrare nella sua poetica è necessario abbandonare l’idea che una singola pellicola possa esaurire il racconto, espletandone lo stile, come un’opera conchiusa. Come amava sostenere nel corso di alcune conferenze che concederà solo alla fine della sua lunga vita – il cineasta aveva un carattere schivo e riservato, tanto che non ritirò mai nessun premio, se non il Leone d’Oro alla carriera nel 2001 – la sua opera è comprensibile soltanto attraverso la lettura di un percorso lungo che intende il film in maniera fluida e osmotica. Le sue pellicole comunicano l’un l’altra, se non per i personaggi, quantomeno per vicinanza di tematiche: «non ho mai fatto un film, ma soltanto un insieme di film».
Attraverso un principio di leggerezza e seguendo le difficilissime leggi della bellezza – misteriosa, silente, visibile soltanto a pochi – il regista costruisce attorno ai suoi personaggi il supporto stesso di un’interrogazione sociale ed etica che pone l’uomo al centro di tutto. Così l’amore, le difficili relazioni sentimentali che mutano seguendo il ciclo dei tempi e delle stagioni, o ancora la casualità – le hasard – divengono i temi attraverso cui i personaggi si scoprono, in un turbinio di parole che fondano la partitura sonora delle sue pellicole. Sì, perché nei film di Rohmer non accade niente, ma quel niente è già un tutto. I personaggi si incontrano, discutono, forse per un attimo si perdono, smarriscono la strada, ma solo a parole. Alla fine si ricompone tutto o magari ci si lascia, si prendono altre vie, la telecamera si fissa su un dettaglio e d’un tratto si è già ai titoli di coda. Il resto è la vita. A differenza dei colleghi, in particolare Godard, che inseriscono spesso nelle loro pellicole il tema politico in quanto cuore pulsante del mondo contemporaneo, per Rohmer di politico v’è soltanto l’amore, qui inteso come riconoscimento del sé e come dinamica fondante dei rapporti con l’altro nelle società di oggi.
Nell’attenta ricerca di uno stile moderno che potesse parlare alla collettività seguendo un linguaggio semplice eppure profondo, Rohmer non abbandonerà mai la sua povertà di mezzi, né la sua telecamera a mano Beaulieu, con la quale realizzò la maggior parte dei suoi film girandoli in 16mm. È facile, al giorno d’oggi, cedere alla seduzione della comodità, e certamente la ricchezza dei mezzi unita ad un grande consenso di pubblico permette di avere successo, di essere ricordati, passando alla storia. Eppure, ciò che alla fine rende liberi, è proprio l’essere slegati dall’economia delle grandi masse, dall’attesa del consenso, dall’odiosa dipendenza che lega a certe case di produzione che, dopo le iniziali lusinghe, impongono una linea di condotta sempre più orientata ai gusti del pubblico.
Per questo Éric Rohmer, scelse «l’aleatorietà», accostandosi sempre, dal primo all’ultimo film, ad una forma di amatorialità che prevedeva l’assenza di musica («che farne della musica quando copre i suoni della natura e della vita, imponendo allo spettatore un sentimento che altrimenti non proverebbe?»), la mancanza di comparse – tutti i suoi personaggi sono inseriti in contesti reali – e la già citata povertà di mezzi tecnici, unita ad un’ équipe di lavoro estremamente ridotta. Seguendo l’imperativo di Arthur Rimbaud, «bisogna essere assolutamente moderni», Rohmer il timido, Rohmer lo schivo, ha costruito un’opera coerente e unica. Povera forse per quelle immagini che oggi arrivano sbiadite sui nostri schermi, ma che conserva la ricchezza di visioni aeree e gentili. Non dovrà stupirsi lo spettatore odierno se d’improvviso, al centro di qualche inquadratura, diverrà predominante il suono del vento, il muoversi di ampie frasche o ancora il canto degli uccelli – è una casualità felice, direbbe il regista – perché i film, se non sono la vita, ne seguono le tracce, scorgendone l’imprevedibilità. I ricordi sfumano con il passare degli anni e ciò che resta sono soltanto lembi di conversazioni, immagini soffuse e brani di memoria strappati ad un tempo che non tornerà più.
Il film della settimana:
L’ami de mon amie (L’amico della mia amica, 1987)
Per l’ultima pellicola del ciclo Commedie e Proverbi, Rohmer sceglie come ambientazione una città di recente costruzione a circa trenta chilometri da Parigi, Cergy-Pointose, cancellando gli stereotipi che leggono nella banlieu un luogo difficile, affamato dalla malavita. La vicenda, costruita attorno al detto «Gli amici dei miei amici sono miei amici», analizza i rapporti amical-sentimentali di una coppia di amiche, Blanche (Emmanuelle Chaulet) e Léa (Sophie Renoir). La prima è una timida single, un po’ solitaria e alla ricerca di un possibile amore, la seconda, più spregiudicata e versatile, fa coppia fissa con Fabien (Éric Viellard) di cui si dice innamorata soltanto a metà. Durante una gita in piscina, Blanche incontrerà Alexandre (François-Éric Gendron), vecchia conoscenza di Léa, ma, intimidita dal carisma del ragazzo, non riuscirà a proferir parola. Tra equivoci, lunghi bagni nel lago, passeggiate nella natura e conversazioni consumate ai caffè di questa nuova periferia borghese, le amiche finiranno per scambiarsi i rispettivi innamorati, giungendo così a una pacifica serenità.
Il film esplica, nell’apparente povertà delle dinamiche, l’importanza della vita affettiva di ogni personaggio che è sottolineata dal paesaggio, vero protagonista della pellicola. I riferimenti al color verde (la natura, gli alberi che circondano la periferia di Cergy, gli abiti di Alexandre) si mescolano al blu (il tailleur di Blanche, il cielo estivo, la tonalità cupa del lago) con un chiaro riferimento alla personalità ambigua e sfuggente di Yves Klein, l’artista nizzardo che seppe dipingere – al pari della cinepresa rohmeriana – uno spazio-colore infinito, un «mondo di colore puro», dove le tonalità pittoriche divengono materializzazione della sensibilità individuale di ciascuno. Ciò che non viene detto dai protagonisti è qui parlato dal paesaggio: non ci sono comparse, solo passanti autentici che solcano le grandi piazze di Cergy, sempre più simili a certi paesaggi urbani proposti da Mario Sironi. L’imprevisto diviene la traccia da seguire, materia di nuova poesia. Lo si legge nelle imperfezioni segnate da una luce poco adatta a mettere in risalto il viso, nella brezza dispettosa che scompiglia i capelli, o ancora nel cielo che s’annuvola d’un tratto incupendo i corpi dei giovani protagonisti. Questo è Rohmer: la dolcezza dell’attendere, lo stupore, il gusto di un’infinita bellezza.
di Ilaria Moretti
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!