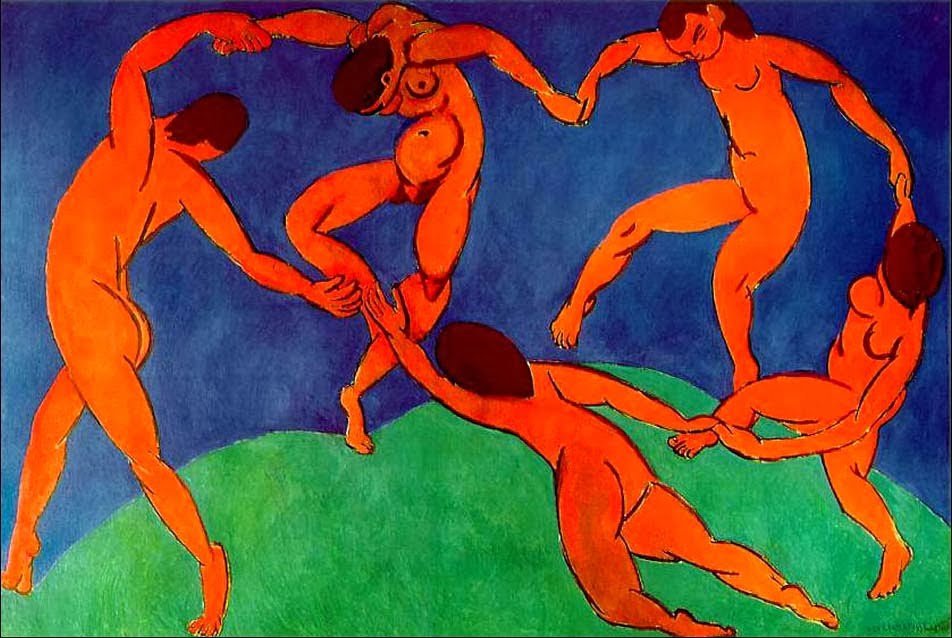Il problema che noi tutti abbiamo con quanto si è soliti chiamare felicità è che il nome felicità non si riferisce ad alcun oggetto determinato. Qui il meccanismo della designazione fallisce, e noi ci ritroviamo tra le mani niente più che una fila di otto letterine, dietro le quali si nasconde ben poca cosa. Così, per questo motivo, ognuno è più o meno legittimato a dire la sua, o meglio, ognuno è legittimato a cercare la sua – di felicità -, e a trovare con ciò il corrispondente perfetto al quale le otto letterine sembrano non poterci assicurare. Non trovando il referente, costruiamo l’oggetto cercato, in maniera più coerente e stabile possibile. La filosofia l’ha fatto, o forse non ha fatto altro che questo, da Aristotele a Kant, e oltre. Proviamo a farlo, seppur rapidamente e senza alcuna pretesa di riuscita, anche noi, legando la parola felicità al concetto di potenzialità.
Un uomo seduto al bar
Spieghiamoci. Cominciamo col prendere in considerazione un esempio estratto dalla quotidianità. Un uomo sta bevendo un caffè. Lo vediamo, è lì, seduto; allunga il polso verso la tazzina sollevando leggermente il gomito, disposto a novanta gradi sul tavolo di legno. Avvicina la mano, stringe la tazza per il manico, tenendolo tra indice e pollice; porta la tazzina alla bocca, reclinando leggermente la testa in direzione del bordo. Sporge le labbra, aspira il liquido, il caffè, con un lieve scroscio, rilassa i muscoli del collo, lo ritrae posando contemporaneamente la tazzina sul piattino dal quale l’aveva sollevata.
Niente di speciale, fin qua. Immaginiamo ora di scomporre all’infinito questo semplicissimo gesto. Anatomizziamolo. Cosa otteniamo? Gesti, altri gesti, infine ancora gesti. L’azione si configura come un susseguirsi ininterrotto di gestualità realizzate, che oscillano tra un obiettivo (voglio bere il caffè) e l’effettualità dell’obbiettivo compiuto (ho bevuto il caffè).
Effettuare potenzialità
Bene. Ora, riavvolgiamo il nastro, premiamo rewind e torniamo al punto di partenza: l’uomo seduto davanti alla tazzina di caffè posata sul piattino a sua volta posato sul tavolo di legno. Proiettiamo in avanti quello che già sappiamo: una serie di gesti pronti ad essere realizzati. Cosa notiamo? Notiamo che, banalmente (e forse sì, la cosa è davvero banale) ogni gesto altro non è che il compimento di una potenzialità. Ogni gesto, nel suo attuarsi, apre ad una configurazione infinita di altri gesti, di altre potenzialità realizzabili. Esempio. L’uomo invece di allungare la mano destra per afferrare la tazzina, come ha fatto, può usare la sinistra; può avvicinare la bocca un centimetro in più o uno in meno; ma può intervenire, anche, sull’ambiente esterno: aspettare che il caffè si raffreddi; portare con sé il giornale per leggerlo; gettare lo sguardo fuori dalla finestra e riposare gli occhi sulla gente che passa.
Questo per dire che ogni situazione (un uomo seduto al bar che prende il caffè) si rivela essere, se guardata attentamente, una serie infinita di potenzialità rese effettuali, portate in atto, dal soggetto della situazione suddetta. Ogni gesto attualizzato è il fuoco entro il quale converge ed insieme diverge una potenzialità futura. Ed è qui che entra in gioco la faccenda, spinosa, della felicità, che ora dovremo osservare non dal lato dei fini, ma da quello della prassi intesa quale potenza di un’azione portata ad effettualità.
Gerarchia di potenzialità
Il punto cruciale è che esiste una gerarchia delle potenzialità. Ci sono cose che ci fanno stare meglio e cose che ci fanno stare peggio. Molti amano passeggiare, molti altri girare in bicicletta. Se costringiamo i passeggiatori, con la forza, a farsi biciclettari, realizziamo per essi una potenzialità che arrecherà loro più dolore che piacere. L’uomo sul quale, molto indiscretamente, stiamo puntando i riflettori da qualche minuto a questa parte, sa – o meglio, è possibile che sappia – in che misura la realizzazione delle potenzialità che, messe in fila e consegnate alla continuità di un’azione, gli arrecheranno piacere o dispiacere. Quest’idea è del tutto spinoziana. Talune potenzialità, ossia eventi, situazioni, configurazioni spazio temporali da portare a compimento, aumentano la nostra gioia – ovvero, quella che Spinoza chiamava potenza d’esistere. Noi, esistendo, realizziamo di volta in volta potenzialità aumentando o diminuendo, a seconda dei casi, la nostra potenza d’esistere, cioè provochiamo in noi alternativamente gioia o dolore. Una potenzialità realizzata nel migliore dei modi possibili, coincide con il massimo grado di felicità che possiamo trarre dalla contingenza di una situazione. E viceversa.
Se estendiamo questo modello all’intera nostra vita, ci accorgiamo che ragionare in termini di potenzialità aiuta. Noi siamo come costantemente disposti all’azione (lo notavano Aristotele e poi Heidegger), e nello scarto che divide la potenzialità dall’azione compiuta, si gioca la partita della felicità. Attivare la potenzialità che più si confà al nostro essere, alla nostra esigenza, è catturare la felicità. In termini di lunga durata, ovviamente. In quest’ottica capiamo anche perché un uomo come Spinoza, che tanto aveva sofferto in vita, si rifiutava di pensare alla filosofia come opera di meditazione della morte. La filosofia, diceva, pensa la vita, pensa il conatus che noi siamo nell’esistere. E questa potenza è di volta in volta potenzialità realizzata.
Per usare un’immagine cinematografica, si tratta di guardare all’intera vita come una bobina che scorre sul rullo, e il frammento che ora proiettiamo, che ora passa sul riflettore, altro non è che una potenzialità resa attuale a discapito di infinite altre. La conseguenza primaria che ne deduciamo è che, se la felicità è una potenzialità realizzata nella miglior maniera possibile, allora, il soggetto che rende attiva tale potenzialità deve, perlomeno, conoscere in che modo essa sia per lui favorevole o dannosa. Deve, cioè, conoscersi, e conoscendosi far uso delle potenzialità, riferendole costantemente alla sua esistenza. Noi dobbiamo sapere quale potenzialità realizzata agisce su di noi provocando gioia, come dobbiamo sapere quale di esse provoca in noi dolore, perseguendo le prime, svicolando dalle seconde.
Porsi in rapporto vitale con il mondo
Guardare alla vita nei termini di un susseguirsi costante di potenzialità, ci richiama alla responsabilità di una meditata riflessione intorno a noi stessi. Senza di essa, nessuna felicità è possibile. Rimarrebbe comunque da sviluppare il naturale proseguo del discorso. In quale misura le potenzialità che di volta in volta attualizziamo privano gli altri, ciascun altro, delle proprie potenzialità, e ne diminuiscono la forza, e cioè sottraggono ad essi felicità? La questione è enorme. Ci accontentiamo, per ora, delle parole di John Cheever, che in un bellissimo passo del suo diario, scriveva così:
«Sembra che spesso quello che scambiamo per dolore o dispiacere sia la nostra incapacità di porci in un rapporto vitale con il mondo, con questo paradiso quasi perduto. Certe volte ne vediamo i motivi e certe volte no. Certe volte ci svegliamo e ci accorgiamo che la lente che ingrandisce l’eccellenza del mondo e della sua gente si è rotta».