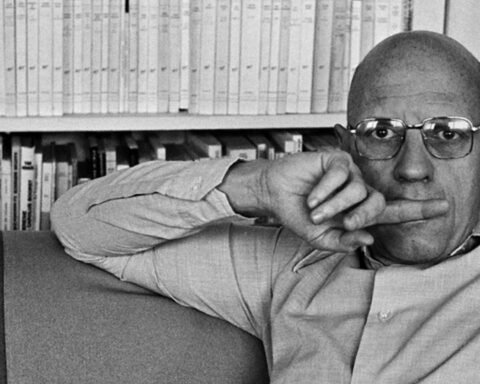Un filosofo molto intelligente che si chiamava Ludwig Wittgenstein, una volta disse che i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. Noi, cioè, non possiamo che pensare attraverso le parole che possediamo, parole che la nostra cultura, il nostro ambiente, i nostri genitori, insomma, la nostra storia ci hanno messo in dotazione al momento della nascita. Siamo cioè strutturalmente costruiti per pensare attraverso il vocabolario che costituisce la nostra lingua. Letteralmente,è possibile tracciare una geografia del pensiero. La gente parla, e cioè pensa, a seconda dell’uso che le parole gli concedono di fare. Ci sono popoli che hanno qualcosa come 90 modi di dire il rosso, e ciò significa che, di fatto, vedono 90 tonalità di rosso. I nostri concetti sono cioè forgiati sul nostro linguaggio. Tantissima parte della filosofia del Novecento, e odierna, non ha fatto che sviluppare le implicazioni che discendono da questa verità.
Ora, la cosa si fa interessante quando incontriamo (nei libri,in aereo, in tv, altrove) qualcuno che parla una lingua diversa dalla nostra, che cioè ha plasmato il suo mondo concettuale non sul calcestruzzo, ma con un tipo di impasto estraneo al nostro modo di fabbricare mattoni. Già nel dialetto si esperisce a fondo questa differenza. Immaginante ora di proiettarvi dall’altra parte del mondo, in Giappone, in Cina – stereotipizziamo: in Oriente, e vi ritroverete a pensare, e cioè a vivere, in maniera radicalmente altra rispetto al nostro modo di vivere.
Essere o vivere

Questa cosa la mostra benissimo il libro di Francois Jullien Essere o vivere. Cosa fa Jullien? Semplice, prende una manciata (venti) parole della lingua francese (perché Jullien è francese, ma poi l’esperimento è valido per tutti noi occidentali, giacché le parole che Jullien utilizza non a casa sono quelle che fondano il nostro – occidentale – modo di vedere, e cioè pensare, il mondo) – dicevamo, prende una manciata di parole della lingua francese e le affianca ad altrettanti lemmi provenienti, invece, dalla lingua cinese. Ciò che ne risulta è un esperimento interessante, perché non solo ci si presenta sotto gli occhi la radicale differenza che passa tra il nostro modo di pensare e il loro modo di pensare, ma anche ci rendiamo conto che, talvolta, anzi, spesso,pensare come pensano loro ci aiuta a vivere un po’ meglio. Vediamo.
Causalità vs propensione

Noi pensiamo che ad ogni causa segua un effetto, anzi, diciamo pur con tranquillità che la categoria della causalità mette in ordine una buona fetta della nostra esistenza. Noi, per così dire, viaggiamo sui binari della causalità. Ce lo insegnano a scuola, sui banchi della prima elementare: la storia funziona così, c’è una causa a cui segue un effetto, e distinguere le cause dagli effetti con cognizione (di causa) significa maturare un primo sguardo consapevole sul mondo. L’idea della causalità (è implicito in essa) stacca ogni causa dal suo effetto, e considera i due lati del rapporto come mattoncini separati. È qui che nasce l’eterna tiritera filosofica sul: siamo liberi di agire oppure no? Ovvero, ogni nostro atto è il frutto di una causa che lo precede o siamo noi stessi la causa dell’atto? Ecco, non funziona ovunque così. Al termine causalità, Jullien oppone quello di propensione. Il termine propensione elimina la staticità che è insita nella causalità (perché staccare la causa dall’effetto significa irrigidire sia la causa che l’effetto) inquadrando l’azione in un’ottica dinamica. Le cose non hanno cause ed effetti, le cose propendono, cioè si inseriscono all’interno di un flusso, di un divenire, di un processo che le implica:
«L’aspetto interessante di questo concetto è che ci fa uscire dal regime della causalità e dunque dell’”esplicazione” [se ogni effetto segue da una causa, spiegare l’effetto significa ricondurlo alla causa, ossia esplicarne, cioè srotolarne la ragione intrinseca. La filosofia è stata, in parte, se non solo, il tentativo di fare questa cosa qui], il regime che ha dominato il sapere europeo, per introdurci in una costante implicazione»
ossia di cause non distinti dai loro effetti, ma come ricondotti entrambi nel flusso processuale che si chiama vita. O, secondo i cinesi, Tao. La cosa si rende più perspicua se guardata dalla prospettiva di un’altra opposizione concettuale, quella cioè tra Potenziale di situazione e Iniziativa del soggetto.
Potenziale di situazione vs Iniziativa del soggetto
Riprendiamo il filo. All’idea della causalità e associata quella del soggetto, ossia del punto di partenza della catena delle cause e degli effetti.Questa cosa, che Pirandello credeva non esistere, noi la chiamiamo Io. Noi pensiamo a noi stessi come Io-soggetti, cioè esseri autosufficienti, capaci di pensare, cioè di agire nel mondo, e provocare su di esso effetti a partire da cause. Ritorniamo al problema solo brevemente esposto prima, quello della libertà. Il soggetto cosa fa? Sceglie, e sceglie perché può inserirsi fra cause ed effetti tramite un’iniziativa (è sulla bocca di tutti, oggi questa cosa dell’iniziativa personale) per (altra parola abusata, dai banchi di scuola al mondo del lavoro) realizzarsi. L’idea tutta occidentale del self-made man deriva da qui, come, secondo alcuni sociologi, derivano da qui alcune patologie tipicamente occidentali (si veda La fatica di essere se stessi, di Alain Ehrenberg)
Ora, se forti del concetto di propensione, sostituiamo all’idea di soggetto quella di potenziale di situazione, acquistiamo sulle cose una visione che può piacerci. Non c’è effetto staccato dalla causa, ma c’è un flusso, divenire, processo; ogni brano del processo è un potenziale di situazione, ossia un’apertura sul suo futuro prossimo, come un’onda che ora s’innalza, ora sta per rompersi, ora si rompe, realizzandosi come potenzialità intrinseca. Cosa può il soggetto difronte a questo spettacolo? Nulla, perché, banalmente, il soggetto non c’è (dov’è? L’onda? Il mare? L’onda infranta? No, c’è, di nuovo, flusso, processo). Eccola qui l’intuizione: l’azione si configura non come iniziativa, ma come strategia la quale «non è altro che trarre vantaggio da una situazione; una situazione che si deve saper progressivamente inclinare secondo una pendenza, sviluppandone la propensione favorevole in modo tale che gli effetti ne conseguono spontaneamente, senza dover più forzare alcunché»
Detto ancora più chiaramente
«La situazione si rivela dunque non più solo un quadro, cioè un contesto, ma un potenziale attivo; perciò il rapporto di quest’ultima rispetto a un “soggetto” viene riconfigurato. Lo stratega non sarà più colui che redige un piano in funzione dei suoi obiettivi e lo proietta sulla situazione appellandosi prima al suo intelletto, per concepire il dover essere, e poi alla sua volontà per farlo collimare coi fatti. […] Il vero stratega sarà piuttosto colui che – nella situazione in cui si trova implicato,non in una situazione riconfigurata in modo ideale nella sua mente – sa discernere, ovvero sa contemporaneamente sondare e liberare i fattori favorevoli, i cosiddetti fattori “portanti” »

Strategia
Lo stratega (e sulla strategia, è noto, si fonda L’arte della guerra) guadagnerà in propensione. Lo stratega vede le possibilità limitate che gli derivano ragionando secondo il concetto di iniziativa. Lo stratega, detto ciò, sfrutta, come cavalcando un’onda, il potenziale che la situazione in cui è da sempre inserito gli presenta. In questo modo, egli avrà già vinto prima di iniziare la battaglia. Il tutto può avvenire se sarà in grado di dimettere causa ed effetti, lasciando che sia il potenziale di situazione a indicargli come muoversi.
Non dobbiamo però pretendere che concetti così lontani dai nostri ci siano immediatamente comprensibili. D’altronde si sa, tradurre (ossia quello che sta facendo Jullien) è sempre tradire. Me forse è proprio nella loro allusività, nella loro sfuggevolezza, che si nasconde un tipo di efficacia sconosciuta a noi occidentali, o meglio, un efficacia fraintesa, che ha generato peraltro una sorta di karma occidentale, tentativo di forzatura inutile di nozioni che ci saranno sempre e comunque lontane.
Semplicità
La questione, per dirla con parole care ai buddisti, è imparare a vedere le cose come sono, ossia raggiungere una semplicità di sguardo che è spesso irrigidita dal modo in cui normalmente pensiamo. Lo si nota confrontando le poche parole che abbiamo tentato di analizzare. L’Oriente ci aiuta in questo, perché ci fornisce un vocabolario concettuale, seppur intraducibile per intero, che ha come fine quello di guardare al mondo in maniera più semplice, come da un’ottica di dismissione della complessità. Come una freccia che attraversa il cielo, come l’acqua che scorre verso il basso, si tratta non di intervenire nel mondo ma trovare il posto assegnatoci, ossia, come diceva Alan Watts, conoscere se stessi. Cosa che, in fondo, accade quando smettiamo di sforzarci a farla accadere. Altrimenti rimaniamo allo stato di una bocca che cerca di mangiare se stessa, un coltello che cerca di tagliare se stesso, un fuoco che cerca di bruciare se stesso.
Certo, non possiamo segare il ramo sul quale siamo seduti. Nonostante ciò, gettare sulle cose una luce diversa da quella che siamo abituati a gettarvi, ci aiuta, e non poco.