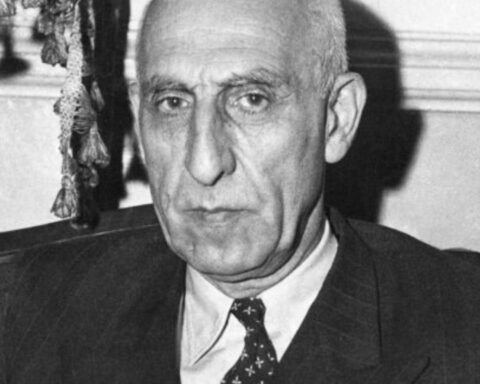Nell’Antichità e nel Medioevo, l’amore non era soltanto un sentimento travolgente, ma una vera e propria malattia. I medici lo diagnosticavano, i poeti lo descrivevano con sintomi precisi, e i teologi lo temevano come una forza capace di allontanare dalla virtù. In un mondo dove il corpo e l’anima erano indissolubilmente legati, innamorarsi poteva significare ammalarsi — di desiderio, di malinconia, perfino di morte. In questo viaggio tra manuali medici, trattati morali e romanzi cortesi, scopriremo come il cuore medievale batteva al ritmo inquieto di una passione… patologica.
Curarlo senza indugi: i consigli di Ovidio
Il celebre poeta latino Publio Ovidio Nasone (43 a.C.-18 d.C.) conosceva bene l’amore e come maestro aveva scritto un’opera dedicata proprio all’Arte di amare. Non solo, da grande intenditore della materia aveva deciso di scriverne anche un’altra in cui consigliava come curare l’innamoramento e i sintomi del mal d’amore. Nelle pagine de Remedia amoris, Ovidio fornì consigli e strategie per guarire dalla passione amorosa, in particolare quella non ricambiata.
Leggi anche:
Sedurre in 10 mosse: i consigli dell’«Ars amatoria» di Ovidio
L’autore fu ben attento a distinguere i diversi tipi di innamoramento, da quello che è come una forza leggera e passeggera, quindi innoquo, a quello invece che si radica nell’animo umano e finisce per tormentarlo. È proprio da questa ultima categoria che bisogna ben guardarsi e nel caso cercare subito una cura. Il rischio è che i mala semina morbi, ovvero i cattivi semi della malattia, non possano più venire estirpati. Infatti sostiene nella sua opera:
Di che natura sia il tuo amore, rapidamente osserva
e sottrai a quel giogo rovinoso il collo.
Dall’inizio combattilo: l’arte medica arriva tardi quando
tra lunghi indugi il male accresce la sua forza.
E tu non ti fidare delle ore che verranno, ma abbi fretta:
meno pronto domani sarà chi non lo è oggi.
Ogni amore di noi si fa gioco, l’indugio lo incrementa,
per la rivalsa il giorno migliore è il più vicino
Ovidio, Remedia Amoris, vv. 89-96
Il poeta sa che l’impresa per guarire dal mal d’amore è una faccenda complicata, ma è necessario contrastarla fin da subito, scegliendo il momento opportuno poiché «la medicina, in fondo, è arte del tempo». Il tempismo risulta fondamentale: per Ovidio bisogna contrastarlo prima che raggiunga l’apice della sua passione e disperazione, oppure dopo questo culmine. Cercarlo di curarlo quando l’amante è nel pieno della sua sofferenza risulterebbe non solo inutile, ma anche dannoso. Quindi sarà opportuno attendere quando l’innamorato sembrerà più disposto ad ascoltare i consigli e si potranno presentare i dovuti insegnamenti.
Tra questi insegnamenti, secondo Ovidio, la medicina migliore è quella di frasi trovare pronti nel momento privilegiato in cui Cupido può colpire con le sue frecce, ovvero nell’ozio. Chi deve curarsi dal morbo dell’amore è auspicabile che riempia la sua giornata di attività, tenendo la mente occupata. Il poeta infatti consiglia «ci sono i tribunali, le leggi, la tutela degli amici: frequenta a Roma i luoghi splendidi della pace o la tua giovinezza presta agli uffici spietati di guerra, e avverrà che il piacere ti volga ormai le spalle». Una vita piena di impegni pubblici, dedicata alla politica o alla guerra, senza mai lasciarsi abbandonare alle tentazioni dell’ozio: ecco il segreto secondo Ovidio.
Un eccesso di bile nera: la teoria di Costantino Africano
Già gli studiosi Greci avevano identificato l’amore come una forma di malattia e in particolare il medico Galeno si occupò di descrivere alcuni dei sintomi dei suoi pazienti, come il deperimento fisico e il battito cardiaco accellerato. Tuttavia, il mal d’amore per i Greci non venne identificato come una patologia. Bisogna attendere gli studiosi tardo-antichi perchè si cominci a considerarla come una malattia mentale, legata alla mania e alla melanconia.
Fu il monaco Costantino l’Africano (1020-1087) a parlare di questa patologia medica al’interno di due sue opere, il De Malinconia e il Viaticum. E’ in questa seconda opera che collega la malinconia alla patologia del mal d’amore. Attribuisce a questa forma anche una definizione clinica, ovvero di «amore ereos». Questo termine rimanda a due campi semantici, quello dell’eros, della passione, e quello heroes, ovvero dell’eroe, finendo per dargli un’accezzione specifica ovvero come amore eroico. La letteratura farà proprio questo legame tra amore malinconico vissuto da personaggi fuori dal comune.
Rimandendo nell’ambito medico, per Costantino l’Africano l’amore eroico era determinato da una commistione tra l’origine psicologica e quella fisiologica. Per quanto riguarda la prima, sarebbe scaturita a partire dall’ossessione del pensiero amoroso; invece quella di natura fisiologica da un eccesso di bile nera, o atrabile, uno dei quattro umori fondamentali della medicina antica. Infatti, per molto tempo si è creduto che un eccesso o una deficienza di uno qualsiasi dei quattro fluidi corporei presenti in una persona, noti come umori, avessero un influsso diretto sul suo temperamento e sulla sua salute.
Il medico arabo Avicenna considerava l’amore eroico come una forma di degenerazione patologica che portava a forme di malinconia, ma se protratte conduceva alla morte. Con questa teoria concordò anche un altro medico dell’epoca, Bernard de Gordon. Questo studioso sostenne che questo sconvolgimento era causato da un’immagine rimasta impressa nella mente dell’innamorato e che ne aveva sconvolto i sensi.
L’amore eroico e la giovinezza
I medici medievali studiando a fondo l’amore eroico, cominciarono ad individuare una ricorrenza maggiore nell’età giovanile. Erano i giovani uomini e donne quelli colpiti maggiormente dalla malattia in questa forma, presi da un torpore che scaldava il cuore, ma finiva per annebbiare anche il cervello. Questi vapori nocivi provocavano errori nelle facoltà di giudizio, annullando le capacità valutative. I sintomi di questa malattia erano svariati. Nel suo saggio Ammalarsi e curarsi nel Medioevo (Carrocci editore, 2025), lo studioso Tommaso Duranti riporta alcuni sintomi, in particolare: «spaziavano da tristezza all’ossessività, dalla perdita dell’appetito all’insonnia, dal pallore all’eccessiva magrezza. Timore, paura, facilità allo scatto d’ira, alternanza tra pianto e riso connotavano il comportamento del malato d’amore».
Lo studio della sintomatologia era accompagnato anche da consigli per curare i malati: era necessario spezzare la catena dell’ossessione per l’oggetto amoroso impossibile da raggiungere. Per questo veniva consigliato di distrarsi: attraverso il sesso, oppure i piaceri dello spirito, cercando compagnie piacevoli, oppure attraverso l’impegno nel lavoro. In alcuni casi si poteva anche a ricorrere allo shock per scuotere l’amato dalla sua illusione d’amore, per esempio mostrando l’immagine di una donna anziana. Questa immagine assolutamente indesiderabile, vestita con panni sporchi doveva accompagnare il pensiero dell’innamorato. Associarne l’immagine a quella dell’amata avrebbe aiutato a spegnare l’illusione d’amore.
Sofferenza e mal d’amore: una questione letteraria
Nel Medioevo, l’indagine sull’amore e sulla sua trasformazione in malattia trovò largo spazio anche all’interno della letteratura. Infatti, furono molti gli intellettuali infatti che approcciarono a questo problema, declinando la loro personale esperienza in opere letterarie. Tra il Duecento e il Trecento, questa tendenza venne raccolta da alcuni dei letterati più importanti, ma la voce che spiccò maggiormente fu quella di Guido Cavalcanti.
Tra le voci dei poeti dello Stilnovismo, Guido Cavalcanti (1258-1300) è stato il poeta che ha posto di più l’accento sulle questioni riguardanti la sofferenza provocata dall’amore nella propria poesia. La donna, nella sua forma angelicata per quanto portatrice di beautitudine, resta una figura irraggiungibile e per lui questo sentimento è fonte di grande sofferenza. In particolare nel testo Voi che per li occhi mi passaste il core, il poeta sottolinea come l’immagine dell’amata, raggiungendo il suo cuore ne abbia risvegliato la mente che dormiva, ma che in seguito a tale avvenimento ne sarebbe stata sconvolta per il dolore.
In un’altra canzone, Donna me pregha, per ch’eo voglio dire, Cavalcanti amplia la questione. Per il poeta l’amore è un accidente, inoltre l’amore non viene dalla perfezione razionale, ma da quella sensitiva e per questo rende inefficace la ragione, poichè il desiderio si sostituisce all’intelletto alle scelte. La conseguenza di questo è la perdita del dominio di sé stesso per l’uomo, portando come conseguenza alla morte dello spirito. Inoltre l’amore non permette il riposo, perchè è accompagnato da un continuo rimurginare sull’oggetto dell’amore. In più spesso può essere accompagnato da scatti d’ira in quanto è imperfetto per sua natura e infine può portare al dolore.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!
Per approfondire
- T. Duranti, Ammalarsi e curarsi nel Medioevo. Una storia sociale, Carrocci Editore, 2025
- G. Cavalcanti, a cura di M. Ciccuto, Rime, Bur Rizzoli, 1978
- P. Ovidio, Remedia Amoris