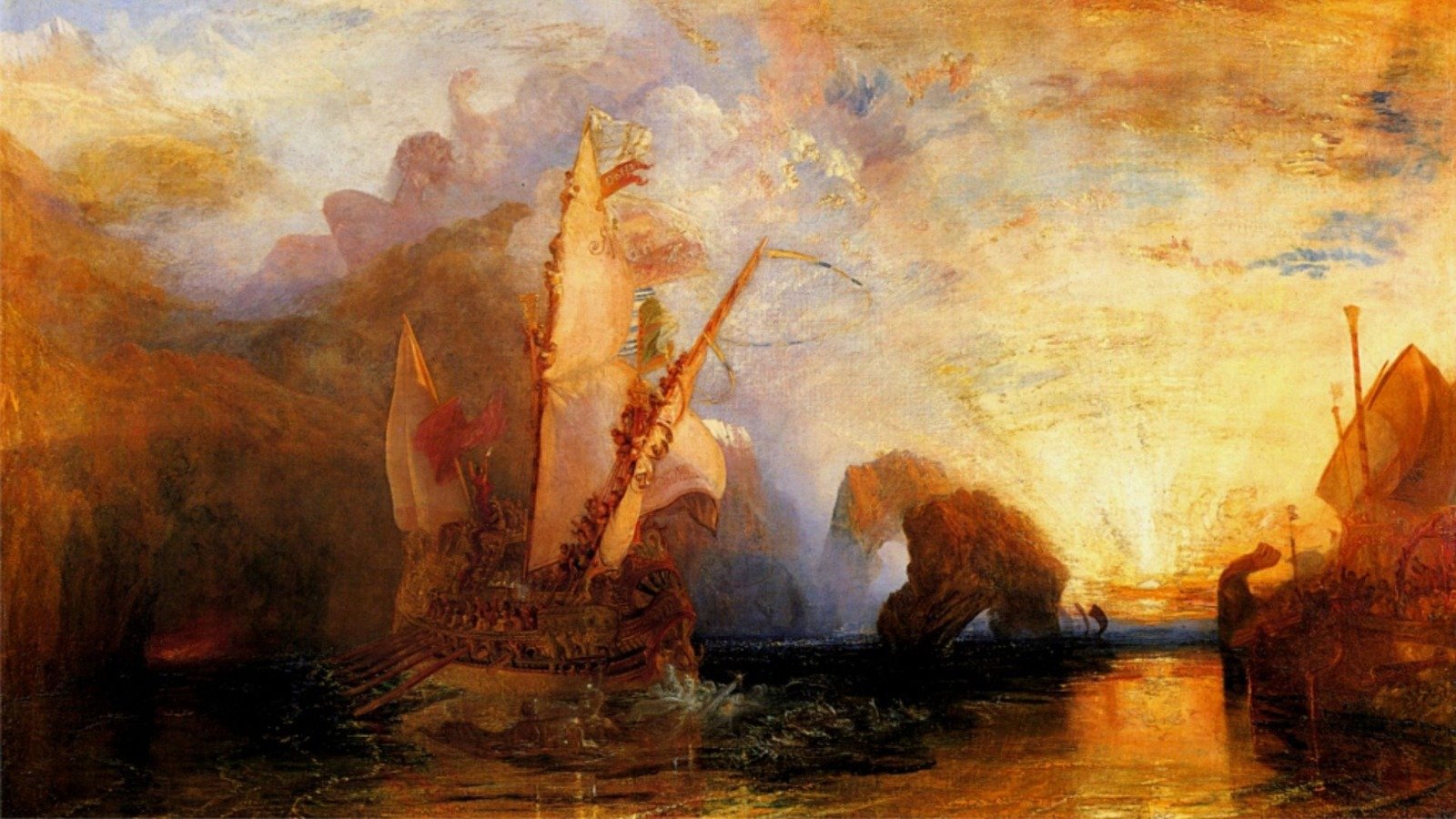La storia del pensiero occidentale porta con sé un numero molto limitato di problemi che ne hanno costituito la trama, le fila, i nodi da sciogliere e che, per loro intima costituzione ed essenza, paiono irresolubili. Tra questi, la filosofia si è occupata del problema della libertà.
La libertà nella filosofia antica
La filosofia, ma non solo lei, si può dire nasca per rispondere a tale quesito, illuminarlo, o almeno darne una definizione. Se l’essere umano è pensato come il tassello di dimensioni infinitesimali all’interno di un cosmo ordinato, che tende nel suo movimento ad uniformarsi al ritmo di ciò che Aristotele chiamava “primo motore”, che spazio c’è per quel bipede implume che è l’uomo? Poco, o nessuno; perlomeno, di fronte a una Natura considerata autonoma, regno della germinazione della vita, egli non è altro che una parte, meno obbediente di altre, sottomessa alle leggi di quest’ultima.
Allora è necessario introdurre il caos, o meglio, una qualche breccia ontologica che fratturi questo ordine cosmico – e cosmico anzitutto perché bello, com’è bello ciò che trova il suo posto naturale, ciò che calza, ciò che sappiamo quadrare ove inserito –: se alla base della realtà, come credevano i seguaci di Epicuro e Democrito, vi sono solo atomi, e gli atomi si aggregano come vortici furiosi che si scontrano e disfano senza alcuna ragione sostanziale, allora l’uomo può dirsi libero, com’è libera è la materia che lo compone.
Ma assoluta libertà non è insieme assoluta necessità? Se non vi è ordine, non è questo non-ordine esso stesso una forma tra tante di costrizione? Gli Stoici pensavano che lo spazio per la libertà fosse quello dell’accettazione della sua assenza: il fato, dicevano, trascina chi vi si oppone, accompagna chi lo asseconda. Non resta che fingere di essere liberi, rendersi teatranti; e danzare.
Quella linea sottile tra libertà e necessità
Baruch Spinoza, grande lettore degli Stoici, chiamò “Natura” questo grande quadro ove ogni causa produce un effetto, ogni effetto a sua volta una causa, e così via all’infinito. L’uomo è come l’ubriaco, che crede di essere libero perché vuole il vino, ma non sa di volere il vino perché è ubriaco, scambiando il fine col mezzo. Dalla prospettiva dell’Intero, del Tutto – di quel Tutto che è Natura, o Essere, o Dio – non vi è posto per qualcosa che non sia determinato da altro; e non regge l’ipotesi leibniziana che qualche grande orologiaio abbia, per somma benevolenza, aggiustato, predisposto, armonizzato le cose affinché questa libertà potesse trovare un suo spazio. Più tardi prenderà nomi diversi, sempre a testimoniare l’incapacità dell’uomo di sopravanzare se stesso, di raggiungersi: Sigmund Freud la chiamerà “Inconscio”, Karl Marx “struttura economica”, Friedrich Nietzsche “volontà di potenza”.
Leggi anche:
Nietzsche: una coscienza critica della vita occidentale
Non solo filosofia: la libertà secondo due grandi romanzieri
Herman Melville, che a lungo – a bordo di mostruose baleniere – dovette riflettere su questi problemi, aveva trovato una via mediana. Libertà e necessità sono indisgiungibili: sono due facce di una sola medaglia.
La trama diritta della necessità, che non si lascia sviare dalla sua finale direzione e anzi con ogni alterna vibrazione tende soltanto a questo; il libero arbitrio, che è ancor libero di manovrare la sua spola tra i fili fissati; e il caso, che sebbene costretto nell’azione tra le linee diritte della necessità e guidato obliquamente nei suoi movimenti dal libero arbitrio, sebbene così comandato dai due, a turno li comanda e dà l’ultimo colpo formatore agli eventi.
Nella stessa direzione sembra andare anche un altro grande romanziere americano, Jonathan Franzen. Egli, nel suo libro Libertà, mostra il legame strettissimo fra l’impulso, strutturale all’essere umano, di svincolarsi da ciò che lo imprigiona, di trovare uno spazio per sé, lasciandosi alle spalle ciò che lo determina (in Franzen, i legami famigliari), e la ricaduta, ogni volta necessaria, in ciò che voleva evitare e che questo stesso movimento di autodeterminazione provoca in lui. È, in fondo, la storia di Edipo: siamo destinati ad uccidere il padre, a violare la madre, dove la strada che conduce alla tragedia è quella che pare affrancarcene.
La libertà come margine: l’uomo di Steinbeck “può”
John Steinbeck aveva un’idea più complessa della questione. Ne La valle dell’Eden, il nerbo della narrazione è costituito dal vincolo che conduce i figli – inevitabilmente, come uno scivolo che si fa sempre più ripido – ad assomigliare ai genitori, dalle colpe che, come una maledizione lanciata dalla vittima, innerva gli eredi dell’assassino. Eppure, Steinbeck disegna un margine tra questi due poli, libertà e necessità, altrimenti schiacciati l’uno sull’altro. Vi è un margine tra ciò che possiamo e ciò che vogliamo fare; tra ciò che il destino ci assegna e ciò che il caso produce; tra la coazione a ripetere che ci mette sulle tracce del Padre («they [i genitori] fuck you up», scriveva Philip Larkin in una poesia bellissima, «they don’t mean to | but they do») e la pista che sembra aprirci ad est dell’Eden. Siamo condannati ad essere figli di Caino, a impugnare il bastone, a uccidere per evitare di farlo? Secondo Steinbeck, no: è questo il margine che si chiama libertà. E questo margine è scritto in caratteri ebraici, suona timshel e significa: “tu puoi”.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!