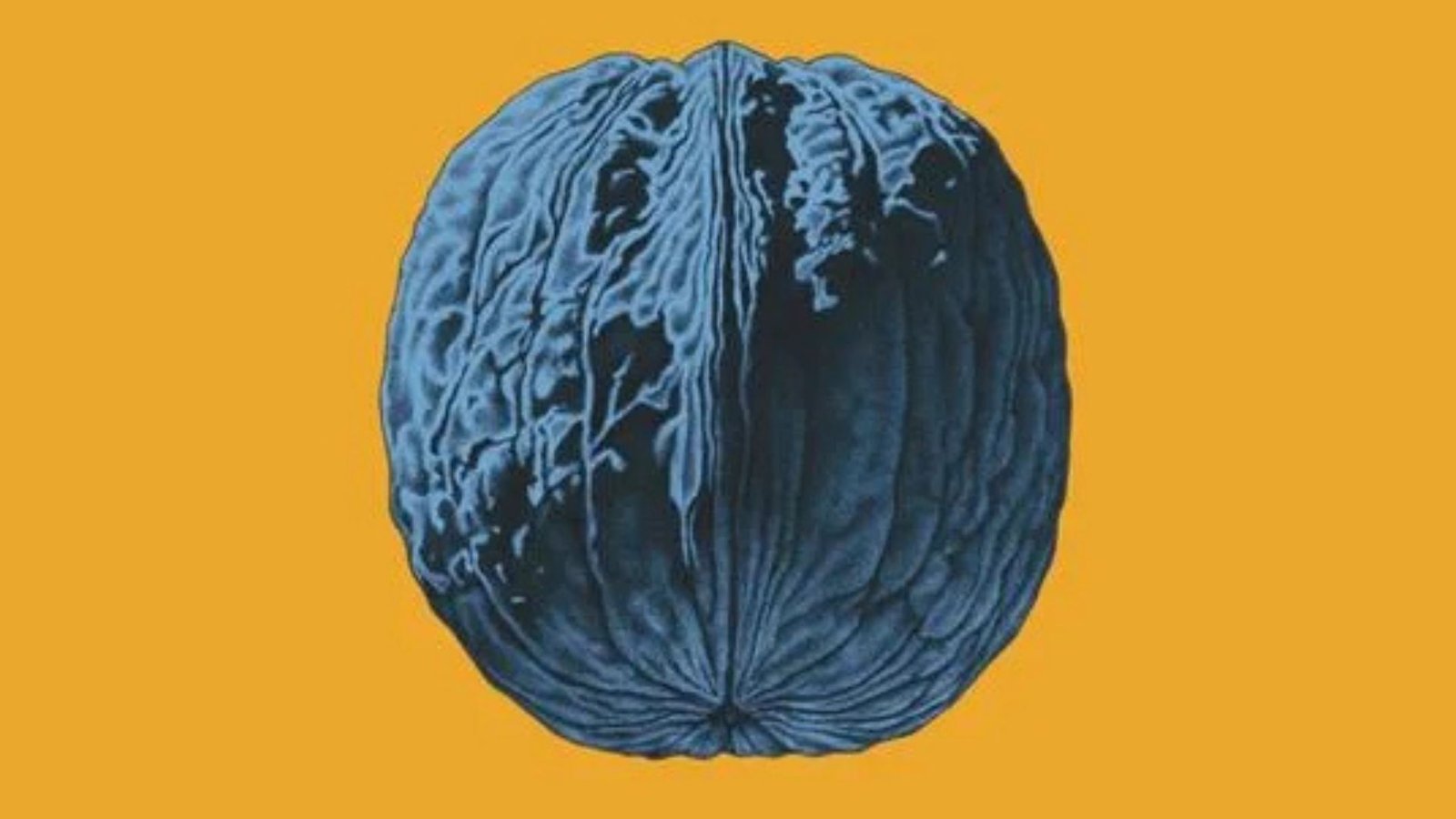A cinque anni di distanza da Cip! – vincitore della Targa Tenco per il miglior album nel 2020 –, lo scorso 14 febbraio Brunori Sas ha pubblicato un nuovo album: L’albero delle noci. La sua uscita è coincisa con la partecipazione del cantautore cosentino al Festival di Sanremo, che l’ha visto aggiudicarsi con il singolo eponimo il terzo posto in classifica e il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo. La partecipazione al Festival, racconta Brunori Sas, è stata fortemente voluta per coronare il lungo lavoro di realizzazione del disco, durato oltre due anni.
Un disco dedicato alla figlia Fiammetta e, soprattutto, un disco in cui il cantautore afferma di aver voluto focalizzarsi su temi non ancora affrontati in passato, per evitare di ripetersi: «Tutto ciò che appariva superfluo, o già detto, è stato messo da parte, per dare spazio e peso agli episodi più sentiti, più ispirati, in qualche misura più urgenti e necessari». Nonostante negli ultimi anni siano nate numerose canzoni, in questo album raffinato, ricco di riferimenti letterari e filosofici, ne sono state inserite solo dieci – che, come sostiene lo stesso Brunori Sas, insieme formano un racconto coerente. Scopriamole insieme.
1. «Per non perdere noi»
Con questo titolo il pensiero corre subito a Per due che come noi, tra i singoli di maggior successo del disco precedente. Non mancano in effetti i riferimenti che ci lasciano immaginare di essere proprio davanti al prosieguo di quella canzone. «Perché ci vuole passione dopo vent’anni a dirsi ancora di sì», cantava Brunori Sas all’epoca. Anche in Per non perdere noi protagonista è una coppia di lunga data, che probabilmente ormai si avvicina alla mezza età e inizia a fare qualche bilancio. Le illusioni della giovinezza sono tramontate ed entrambi sentono, com’è quasi sempre inevitabile, di aver perso qualcosa lungo la strada. Crescere, d’altronde, fa davvero rima con perdere.
Anche l’amore è cambiato e si è evoluto (un tema che tornerà anche in Più acqua che fuoco, l’ottava traccia dell’Albero delle noci). È diventato sinonimo di cura, di parole soppesate con attenzione per non ferire l’altro, ma anche di «ostinazione a tenere in piedi un sogno, un ideale, mentre tutto va a puttane». Perché tenere in vita un sogno quando tutto frana è un vero atto di eroismo. E perché più cose si perdono con il passare degli anni, più importanza assumono quelle che, nonostante tutto, continuano a resistere.
Più di quello che hai perso tu
Più di quello che ho perso io
Siamo stati due eroi
A non perdere noi
2. «L’albero delle noci»
Galeotto fu il 75° Festival di Sanremo, a cui Brunori Sas ha partecipato con questa canzone dedicata alla figlia, le cui sonorità un po’ richiamano Francesco De Gregori. È un pezzo centrale nel disco, e non solo perché gli dà il nome: L’albero delle noci va proprio alle origini dell’arrivo della piccola Fiammetta nella vita del cantautore cosentino, all’incredulità e al senso di smarrimento che accompagnano la notizia della sua imminente paternità. Un frutto tardivo e forse inaspettato che la vita ha donato al protagonista della canzone (Brunori Sas, in effetti, è diventato padre a 44 anni).
Con l’età è subentrato un certo disincanto, ha imparato a navigare «anche in assenza di stella polare» e di una cosa si crede certo: non sarà in grado di sostenere il carico di sentimenti che porterà con sé la nascita della bambina. Una nascita, in fondo, porta con sé una promessa che ogni genitore si ostina a fare pur sapendo di non poterla davvero mantenere: quella di proteggere i figli dal male e dal dolore. Ma è inevitabile che, malgrado quel primo giuramento, un giorno anche i figli soffriranno (talvolta proprio a causa dei genitori).
Come si sostiene tutto questo? Una vera risposta non c’è, e Brunori Sas non vuole nemmeno darcela. Ha però una certezza, ora che vede Fiammetta camminare con la manina in quella della madre: la bambina è diventata la sua nuova stella polare. Così piccola e già artefice di un miracolo: cambiare l’architettura e le proporzioni del cuore di un padre.
E tutta questa felicità forse la posso sostenere
Perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore
E posso navigare sotto una nuova stella polare
3. «La ghigliottina»
Uscito a settembre 2024, il secondo singolo dell’Albero delle noci mandato in rotazione radiofonica fa ritrovare l’anima più ironica e pungente di Brunori Sas, che già avevamo avuto modo di apprezzare in canzoni come Secondo me o Figli della borghesia. La ghigliottina immagina una conversazione tra amici a tavola, magari dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, in cui ci si lancia in una carrellata di discorsi su temi sensibili, oggi divenuti veri e propri campi minati. «Quante cose si dicono a tavola che in pubblico non diresti mai», sostiene il cantautore cosentino. E, in effetti, nell’epoca del politically correct (spesso, ammettiamolo, un po’ ipocrita), non di rado capita di sentire che “non si può più dire niente”. Una frase di solito pronunciata da quello che Brunori Sas elegge a suo interlocutore nella Ghigliottina: il maschio etero bianco.
Ti vedo un po’ stanco, maschio etero bianco,
Tra ricatti morali, colpe ancestrali, monete di scambio
La canzone non risparmia davvero nessuno. Da un lato, troviamo una pungente critica a chi guarda agli altri con chiusura, perché trova «normale che non sia normale la diversità». La ghigliottina del titolo, però, fa al tempo stesso riferimento all’atteggiamento contraddittorio di chi si erge a paladino dell’inclusività ma si rivolge con toni violenti – che di inclusivo hanno ben poco – a chiunque esprima un’opinione diversa. Si tratta di dinamiche senz’altro esacerbate dalla tendenza dei social media a polarizzare i discorsi, e molto simili a ciò su cui, alcuni anni fa, aveva puntato il dito un’altra cantautrice, Paola Turci, nel suo singolo Caramella: «Io sono quella che non impone niente a nessuno, democratica sempre: se non sei convinto, allora stai zitto».
Leggi anche:
Cosa la soundtrack di «A Complete Unknown» può dirci su Bob Dylan (e non solo)
4. «La vita com’è»
Esce a settembre 2023 in concomitanza dell’arrivo nelle sale del film Il più bel secolo della mia vita, di cui è la colonna sonora, e l’anno successivo riceve una candidatura ai David di Donatello come miglior canzone originale. Il primo singolo estratto dall’Albero delle noci preannunciava già diversi temi ricorrenti nell’album, come il tempo che passa, le illusioni che si sgretolano, il dover dire addio a qualcuno che si ama. In un certo senso le varie tracce offrono, ognuna a suo modo, una ricetta per sopravvivere a tutto questo; La vita com’è se la porta già nel titolo. La vita è per sua natura mutevole, e forse il segreto sta tutto nel tentare – per quanto difficile sia – di non cedere alla rabbia e nell’accogliere questi mutamenti non con rassegnazione, ma con consapevolezza.
No, no, no, non è
Che l’amore non ritorna più, no, no
Anche se tornasse indietro
Non ci troverebbe più
Secondo il filosofo greco Eraclito, nessuno entra due volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso e non siamo gli stessi neppure noi. Questa idea ritorna proprio nella Vita com’è, in cui Brunori Sas sembra dirci che troppo spesso ci ostiniamo a rimpiangere le gioie e gli amori passati, idealizzandoli come qualcosa di impareggiabile. Se però tornassero davvero nella nostra vita, così com’erano, forse le persone che siamo oggi non li troverebbero più così magnifici. Perché la vita si muove inesorabile, ma nemmeno noi in realtà stiamo mai fermi.
5. «Pomeriggi catastrofici»
Vero protagonista della canzone è il suono incalzante del pianoforte, che in qualche modo ricorda le melodie di Fred Buscaglione. Pomeriggi catastrofici è un piccolo spaccato dell’infanzia del narratore, con spensierate domeniche pomeriggio trascorse dai parenti, a mangiare pasta al forno e babà, giocare ai soldatini e leggere Topolino e Dylan Dog. Il ritornello («La vita è proprio una vera meraviglia, se stai con la famiglia niente ti può accader») racconta la grande illusione che molti di noi hanno vissuto da bambini: quella della famiglia come un’isola felice, in cui gli adulti sono visti come figure invincibili, che nulla può scalfire.
E spesso la fine dell’infanzia – o l’inizio del disincanto – coincide con l’illusione che si infrange. C’è un evento che ci fa scoprire, in tutta la sua brutalità, che non è vero che i grandi sono invincibili e, soprattutto, non è vero che «se stai sempre in famiglia niente mai ti accadrà». Il cuore della canzone, che giustifica l’aggettivo catastrofici del titolo, è quando il pianoforte per pochi istanti si fa da parte, lasciando il posto agli archi, e viene nominata una cugina, Anna, scomparsa in giovane età. Probabilmente il primo incontro del narratore con la morte di una persona amata.
È Anna la cugina più bella
È volata su una stella e mai più ritornerà
Anna, eri tu la più bella
Sei volata su una stella e mai più ritornerai
Forse, ora che il narratore è diventato padre e ritrova negli occhi della figlia quell’illusione perduta, ne sente più che mai nostalgia. E, al tempo stesso, spera che il momento in cui l’incantesimo si spezzerà arrivi il più tardi possibile.
Leggi anche:
«È finita la pace»: Marracash fa luce sul presente
6. «Il morso di Tyson»
Il titolo della canzone, recentemente proclamata vincitrice del Ballerino Dalla 2025, fa riferimento a un episodio che tutti, appassionati di boxe o meno, tutti bene o male conoscono: il 28 giugno 1997, durante un match a Las Vegas, il pugile statunitense Mike Tyson staccò con un morso un pezzo di cartilagine dell’orecchio destro del suo avversario, Evander Holyfield. Nell’album di Brunori Sas, questo però viene evocato solo in senso metaforico. La canzone, infatti, non c’entra nulla con il pugilato: protagoniste sono due ragazze che in una stazione si scambiano «un bacio che sembra l’ultimo, l’ultimo colpo di scena».
Il narratore stavolta non parla di sé, ma di due vite estranee che gli è capitato per caso di incrociare, e di cui diventa testimone in un momento di fortissima tensione emotiva, quello dell’addio, definito «attimo senza fine». Un’espressione che richiama il concetto di “tempo interiore” del filosofo francese Henri Bergson, che sosteneva l’esistenza di un tempo esteriore, assimilabile a una collana di perle, in cui ogni istante si sussegue ordinatamente all’altro, e di un tempo interiore, simile invece a un gomitolo, i cui fili continuano a riavvolgersi su sé stessi. Impossibile distinguere davvero passato, presente e futuro. È proprio quello che succede con gli eventi cruciali della nostra vita, che nella memoria continueranno a riaffiorare e mescolarsi al presente. Trovarsi a dire addio a qualcuno che si ha molto amato è senz’altro un «attimo senza fine», e Brunori Sas lo sa bene.
E il morso di Tyson del titolo? È l’idea opposta alla vita da vivere così com’è: è l’«ultimo gesto disperato» di chi non vuole arrendersi all’idea di dire addio a chi ha amato e tenta, in modo scomposto e in fin dei conti un po’ inutile, di ribaltare le cose, sperando in un improbabile colpo di scena.
Menomale
che indietro non si può tornare
Anche se sarebbe splendido
Tornare a farsi male così
In un ultimo gesto disperato
Il morso di Tyson
7. «Fin’ara luna»
Si dice che il dialetto sia la lingua delle emozioni più profonde e viscerali, e non a caso in Fin’ara luna Brunori Sas sceglie di cantare in dialetto cosentino. È un pezzo molto intimo, quasi sussurrato, che sembra scritto solo per voce e chitarra. Il protagonista esprime il desiderio di camminare fino alla luna – un simbolo dei sogni perduti che ritornerà anche in Luna nera, la nona traccia dell’Albero delle noci – per raggiungere Maria, la donna amata, morta probabilmente dopo una lunga malattia.
Ascoltando il brano, a metà tra una ninnananna e una serenata, ci resta l’impressione di sbirciare da una fessura il dolore privato di un uomo che, dopo tutta una vita trascorsa con la sua Maria, ora si ritrova in un letto che d’un tratto sembra troppo grande. Gli resta solo una fotografia da stringersi al petto nel buio della notte. Facciamoci allora da parte, lasciamoci emozionare da un dialetto che magari non è nemmeno il nostro e che in un primo momento può sembrarci difficile da capire. Perché qualsiasi barriera linguistica viene meno davanti ai sentimenti di cui le parole si caricano e, soprattutto, davanti alla musica.
Maria, Marì, tesoro mio
‘Ntra ‘stu liettu accussì granne
‘a notte mo’ mi spagnu, m’abbrazzu a ‘na fotografia
E ogni notte priego ‘u Patriterno
Ca si pigliassa puru ‘a vita mia
Leggi anche:
«A casa tutto bene», il tuffo nella realtà di Brunori
8. «Più acqua che fuoco»
L’ottava traccia dell’Albero delle noci si apre con quella che ha tutta l’aria di una sentenza: «la tensione erotica in una coppia di lunga data tende a scemare, è una cosa normale». In questa canzone Brunori Sas prova a scindere il tradizionale binomio passione-amore, accostando a questo sentimento non il fuoco, ma l’elemento opposto: l’acqua. Che qui non è vista come ciò che spegne la passione, ma come un simbolo di vita, in grado di lenire la sofferenza e non far morire l’amore. Malgrado lo scorrere del tempo, malgrado il disincanto che inevitabilmente subentra.
Già ai tempi di Per due che come noi, in effetti, Brunori Sas ci metteva in guardia, dicendoci di «non confondere l’amore e l’innamoramento». Più acqua che fuoco porta avanti quel discorso, ridimensionando la passione a piccola parte di una lunga storia fatta in primis di cura della persona amata – la stessa cura che avevamo trovato in apertura del disco, con Per non perdere noi. E che in qualche modo ci riporta all’albero delle noci che dà il titolo all’album: per crescere rigogliosa, una pianta non ha forse bisogno di nutrimento, cure, e quindi amore?
L’amore, l’amore, l’amore è più acqua che fuoco
Più acqua che fuoco
Il desiderio dura un istante
L’amore, l’amore, l’amore è una cosa più grande
9. «Luna nera»
«Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna?»: con il narratore che si rivolge direttamente alla luna, questa canzone sembra una rivisitazione in chiave attuale del celebre Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Giacomo Leopardi. La luna qui rappresenta i sogni, i giochi e, più in generale, tutta la dimensione mitica dell’infanzia, che crescendo ci lasciamo alle spalle. Ed è così che, presi dalla frenesia e dalle numerose quisquilie del quotidiano, non ci accorgiamo nemmeno più della presenza della luna in cielo. Abbiamo, in poche parole, perso la capacità di stupirci.
Per strada non ti guarda quasi più nessuno
Ormai cercano le stelle con la spunta blu
Non lo sanno che le stelle, anche quelle vere,
Non brillano come brilli tu
Il narratore di Luna nera sembra essere rimasto l’unico con uno sguardo ancora bambino, e proprio per questo riesce a intavolare un discorso con la luna. «Mia figlia sogna l’America, e sulla luna non ci vuole andare più»: nella transizione dall’infanzia all’adolescenza, il baricentro della vita di una persona cambia, spostandosi dalla casa – e tutto ciò che questa rappresenta – all’altrove. In Luna nera Brunori Sas si proietta già nel futuro, immaginando come sarà questo passaggio straniante per un genitore, ma in fondo inevitabile e necessario.
Leggi anche:
L’eros e l’ossessione d’amore secondo Madame
10. «Guardia giurata»
Le note del pianoforte tornano anche all’inizio della decima traccia dell’Albero delle noci, ma non sono più incalzanti come in Pomeriggi catastrofici: la melodia è qui molto più dolce e delicata. La canzone mette in scena la supplica di un uomo a una guardia giurata, che non vuole farlo entrare in sala parto con la moglie. Non mancano le frasi che rimandano alla vicenda autobiografica di Brunori Sas: «immagina l’effetto che fa diventare padre alla mia età», o ancora «lo so, c’è il regolamento, ma mia figlia sta venendo al mondo in questo momento». C’è qui anche un riferimento temporale non esplicito, ma facilmente intuibile: la piccola Fiammetta è nata nel 2021, nel pieno delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, e questo spiegherebbe come mai al padre viene vietato di assistere alla nascita.
La guardia giurata non pronuncia nemmeno una parola. Non sapremo mai se si è mostrata inflessibile o se ha accettato di fare un’eccezione. Dopo la strofa, la scena si sposta con un’ellissi temporale – come se tutto il resto non avesse più importanza – in una stanza d’ospedale, con la bambina già tra le braccia dei genitori, come in una moderna Natività. Guardia giurata è una canzone ricca di parti strumentali, in cui le parole sembrano venire meno davanti al miracolo della nascita. E, con quel «per tutta la vita, con tutto l’amore» che suona quasi come una promessa, rappresenta la perfetta chiusura dell’album che ci racconta cosa ha significato per Brunori Sas diventare padre.
E in una stanza d’ospedale, come la sera di Natale
Io, tu e tua madre, per tutta la vita
Con tutto l’amore
Ascolta il disco su Spotify:
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!