Nel febbraio 2019, la casa editrice Frassinelli pubblica con traduzione di Stefano Bortolussi il romanzo del debuttante Tommy Orange Non qui, non altrove (titolo originale: There, there), un romanzo che ha fatto parlare di sé fin da prima della sua pubblicazione, raccogliendo il consenso della critica e di autori e autrici affermati come Louise Eldrich e Margaret Atwood, al punto da vincere nel 2019 il PEN/Hemingway Award, premio letterario americano assegnato alle opere prime, e arrivare alla finale del Pulitzer per la letteratura assieme ad autori già affermati come Rebecca Makkai e Richard Powers, quest’ultimo vincitore con Il sussurro del mondo dell’edizione di quest’anno del prestigioso premio per la narrativa americana.
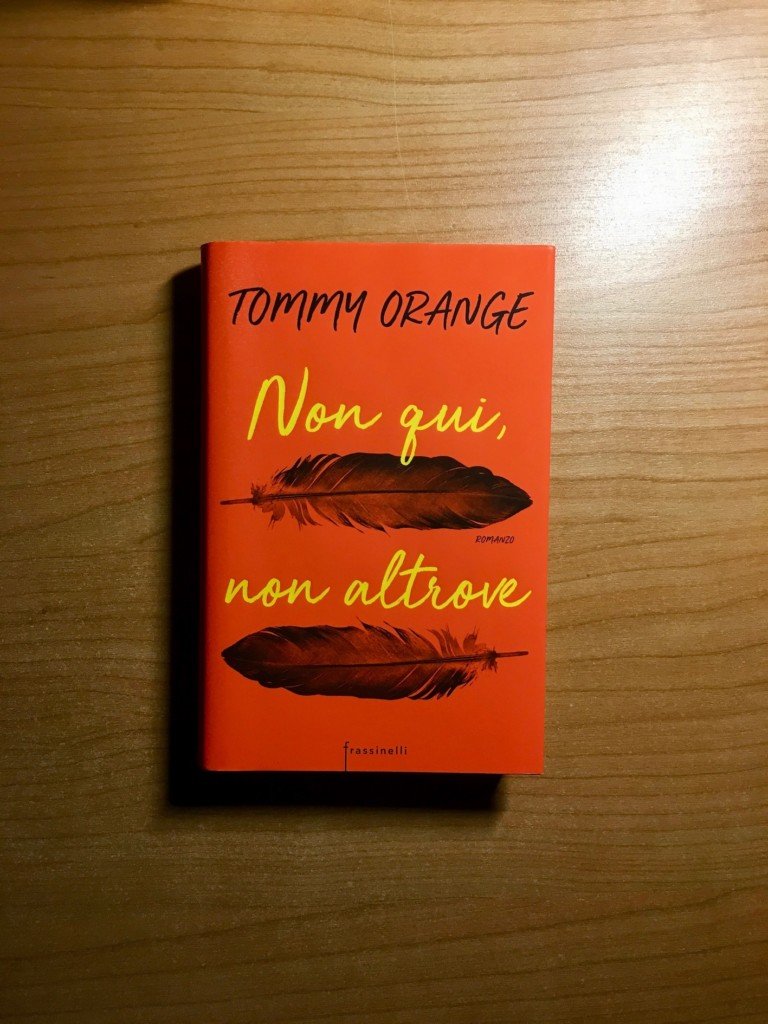
Chi sono gli indiani urbani?
Il trentasettene originario di Oakland, California, figlio di padre di origine cheyenne e arapaho (l’autore è membro della Cheyenne and Arapaho Tribes of Oklahoma) e madre americana, e laureato del programma MFA tenuto dallo scrittore nativo americano Sherman Alexie presso l’Institute of American Indian Arts di Santa Fe, ha scritto un romanzo che affronta il fenomeno degli indiani urbani, generazione di nativi americani ormai urbanizzata di cui lo stesso autore fa parte, definita nel seguente modo nel prologo del libro:
«Siamo in tanti, ormai, a essere inurbati. Se non perché viviamo in città, quanto meno perché viviamo su Internet. In un grattacielo fatto da miriadi di finestre di browser. […] Siamo quello che hanno fatto i nostri antenati. Siamo il modo in cui sono sopravvissuti».
Trama del romanzo
Non qui, non altrove, infatti, segue le vicende di 12 personaggi alla ricerca di un legame autentico con le proprie origini native e che decidono di prendere tutti parte al Grande Powwow dell’Oakland Coliseum. Tra questi: Tony Loneman, affetto da FAS, sindrome feto-alcolica che lui soprannomina Drome, e che spaccia droga assieme a Octavio; Dene Oxendene, documentarista che decide di perseguire il progetto dello zio di raccogliere le storie dei nativi di Oakland; Opal Viola, che assieme alla sorellastra Jacquie ha preso parte all’occupazione dell’isola di Alcatraz; Edwin Black, laureato in letterature comparate e aspirante scrittore che scopre su Internet di essere figlio di Harvey, nativo americano e maestro di cerimonie del powwow; Orvil, nipote di Jacquie e Opal Viola, interessato alle sue origini e disposto a partecipare al powwow come danzatore. Le vicende di questi personaggi sono narrate adottando diversi tipi di narrazione, persino una narrazione in seconda persona singolare, per rappresentare la complessità dell’identità e delle esperienze dei nativi urbani.
Significato del titolo «There, there»
Per spiegare bene Non qui, non altrove, vale la pena concentrarsi sul titolo originale: There, there. L’origine del titolo si può comprendere nella prima parte del romanzo, in particolare nel capitolo dedicato a Dene: da un lato la canzone omonima dei Radiohead, il cui ritornello recita: «Just ‘cause you feel it / Doesn’t mean it’s there» («il solo fatto che lo senti non significa che esista»), e dall’altro una frase da Everybody’s Autobiography (Autobiografia di tutti) di Gertrude Stein («there is no there there»: «qui non c’è nessun qui»), che come afferma Dene si riferisce alla zona dell’Oakland in cui l’autrice era cresciuta, che:
«[…] era cambiata così tanto, si era sviluppata al punto che il “qui”, il luogo della sua infanzia, era scomparso, che non esisteva alcun “qui”».
Quello che nota Dene è un parallelo tra l’esperienza di Gertrude Stein e dei nativi americani:
«[…] per i nativi di questo Paese, di tutte le Americhe, quel “qui” è stato edificato, quella terra ancestrale è stata seppellita da vetro e cemento e cavi e acciaio, una memoria ricoperta e mai più restituita. Quel qui non è qui, non è altrove».
Leggi anche:
Tyll Ulenspiegel, la finzione letteraria contro l’odio
Concetto di pretendian
Questo passo preannuncia il fallimento dei personaggi di riconnettersi con le proprie origini, al punto che il powwow, organizzato proprio per dare un luogo di appartenenza ai protagonisti e agli altri nativi urbani, finisce in un massacro a causa di una rapina, organizzata da Octavio e i suoi uomini, finita male. Se il powwow finisce in questo modo, è proprio per sottolineare il fatto che il tentativo dei personaggi di riconnettersi con un’identità nativa sia in realtà un’imitazione, anche goffa, dell’essere nativo americano oppure un qualcosa di costruito per trarre profitto e visibilità e che di autentico non ha nulla: basti pensare alle osservazioni di Tony sul powwow, il quale afferma che la vera ragione per cui si fa è per i soldi, oppure a Orvil che decide di partecipare al progetto di Dene poiché ha saputo su Facebook che gli avrebbero dato 200 dollari. Ed è proprio Orvil quello che comprende cosa vuol dire veramente essere indiani dopo aver scoperto dell’esistenza del termine pretendian, neologismo nato dalla fusione dei termini inglesi to pretend (fingere) e Indian (termine usato per riferirsi ai nativi americani), e che pertanto significa “finto indiano”:
«È importante che si vesta da indiano, che danzi come un indiano anche se è una recita, anche se si sente un truffatore, perché l’unico modo di essere indiani a questo mondo è comportarsi da indiani. Essere o non essere indiani dipende anche da questo».
Riappropriazione fallita delle proprie origini
L’idea di riappropriarsi delle proprie origini risulta, dunque, fallita fin dall’inizio. Ciò è ben evidenziato dalla struttura del romanzo, che si apre e si chiude con lo stesso personaggio: Tony Loneman, il cui cognome, che si può tradurre come “uomo solo”, indica il tentativo, come spiega l’autore nell’interludio del romanzo, «raffazzonato di traduzione» per dare un cognome ai nativi e per riconoscerli, arrivando persino a dare un’immagine stereotipata dei nativi (il cognome “Loneman” dà l’idea di una rappresentazione stereotipata dei nativi come uomini tristi e solitari che affogano i loro dispiaceri nell’alcol). La sindrome feto-alcolica, che Tony chiama Drome e che rende la sua faccia deformata, rappresenta quella cultura urbana che ha quasi cancellato le sue origini native e che impedisce di recuperarle, nonostante Tony indossi il costume da indiano e si veda davanti al televisore come tale (nella prima pagina del primo capitolo, mentre osserva lo schermo del televisore, Tony dice: «Cercai di riprendermi la faccia che vedevo, ma non ci riuscii»). Nel capitolo finale, la cui ultima parte è affidata proprio al personaggio di Tony, vale la pena dare attenzione al seguente passo:
«Si vede uscire da se stesso e levarsi in volo, poi si guarda dall’alto, osserva il proprio corpo e ricorda che non è mai stato veramente lui. Lui non è mai stato Tony, così come non è mai stato il Drome. Erano solo maschere».
La faccia deforme per via della sindrome, pertanto, può essere interpretata nel seguente modo: il Drome, così come il suo essere Tony, ovvero una persona di origine cheyenne che si veste da indiano per riappropriarsi del suo retaggio e per nascondere il fatto di essere urbanizzato, altro non sono che maschere, identità costruite dalla percezione che l’altro ha di noi e che noi stessi costruiamo per rapportarci agli altri, frutto, in questo caso, dell’azione della cultura urbana che ha plasmato l’identità dei nativi urbani. La morte di Tony a seguito della sparatoria può essere interpretata come il fallimento degli indiani urbani di trovare il “qui” di Gertrude Stein, ovvero di instaurare un legame autentico con il proprio retaggio nativo che è destinato a essere solo un ricordo, così come è un ricordo l’occupazione di Alcatraz vissuta da Opal Victoria, un ricordo sepolto da una cultura contemporanea e tecnologica che, come i colonizzatori europei, con le loro rappresentazioni e stereotipi, si è impossessata della storia e delle origini dei nativi americani, al punto da cancellarle, come nota Tommy Orange nel preludio:
«Chiunque altro da noi ci ha definiti e caratterizzati, e continua a calunniarci, sebbene le verità della nostra storia e delle nostre attuali condizioni in quanto popolo siano facilmente consultabili in rete […] Abbiamo tutti i cliché e le mascottes. […] Le nostre teste campeggiano su bandiere, maglie e monete. In un primo momento erano sul penny, il centesimo indiano, poi sul nichelino del bisonte, ancora prima che il nostro popolo avesse diritto di voto; ma queste monete, come le verità su ciò che è accaduto nella storia del mondo e come tutto il sangue versato nei massacri, sono ormai fuori corso».
Tuttavia, come dice Victoria alla figlia Opal Viola ad Alcatraz e come ricorda Tommy Orange nei ringraziamenti posti alla fine del libro, qualcosa da fare è ancora possibile: continuare a raccontare storie, a impegnarsi per le generazioni che verranno, poiché:
«tutti i racconti che in tutto questo tempo non abbiamo narrato, che non abbiamo ascoltato, fanno semplicemente parte di ciò che dobbiamo guarire».
Per guarire le sofferenze dovute a un’identità negata, bisogna rispondere al seguente imperativo, dato unendo i titoli delle prime tre parti del romanzo: “restare”, “rivendicare”, “tornare”. Restare ad ascoltare le storie che hanno bisogno di essere narrate; rivendicare la propria identità e il proprio passato; tornare in quel “qui”, quell’ “altrove” dove è possibile esistere lontano dalla contaminazione e dalle menzogne del mondo contemporaneo, dove un’altra verità per riscattare il sangue versato nei massacri è ancora possibile.
Immagine di copertina: Immagine dal 34° powwow a Red Cliff, North Winsconsin, luglio 2012
Wikimedia Commons. By Bjoertvedt – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22957733








