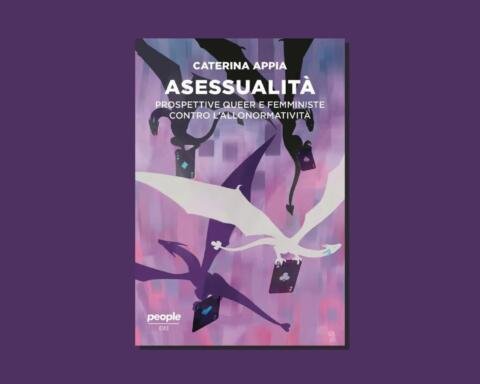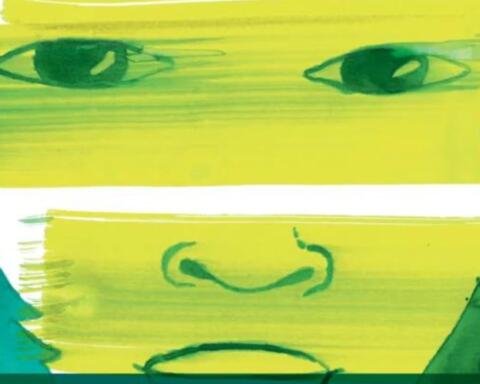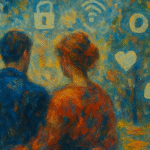Quante volte ci è capitato di guardare un film o una serie tv e sentirci parte della storia di qualcun altro? Che, anche se non ci appartiene, finisce per parlare un po’ di noi. Quante volte ci siamo sentiti rappresentati dai personaggi, ci siamo immedesimati nelle loro vite, entrando nella trama quasi come se a viverla fossimo noi? Racconti felici, inventati o ispirati alla realtà, storie tragiche ed emozionanti. Quante volte siamo riusciti a sentirci parte di un racconto che non era il nostro, ma che in qualche modo riusciva a darci voce?
La cultura contemporanea delle serie tv, oggi, è molto più di un semplice passatempo: è specchio di culture, società, politica e comunità, e contribuisce alla creazione e diffusione di messaggi che diventano parte integrante della realtà collettiva. Messaggi che il pubblico riceve, “decodifica” e interpreta, attribuendo loro significato. Gli spettatori analizzano ciò che vedono: personaggi, relazioni, messaggi impliciti, generando una risposta personale e sociale. Media e società, da sempre interconnessi, alternano adattamento e creazione, influenzando a vicenda il pensiero comune.
Serie tv contemporanee al di là della politica del coming out
In questo processo di raffigurazione e interpretazione, le identità queer sono andate incontro a diversi tipi di narrazioni e, in particolare negli ultimi anni, assistiamo a uno sviluppo che ne ha permesso una rappresentazione più varia e meno stereotipata.
Leggi anche:
Cos’è il Queer? Ce lo racconta un manuale per immagini
Se pensiamo a una serie tv queer, o con un personaggio LGBTQ+, ci verrà probabilmente in mente il classico climax con cui siamo cresciuti: presa di coscienza, coming out seguito dal rifiuto di qualche parente o amico che, nel migliore dei casi, si conclude con una finale accettazione o, in qualche modo, con la liberazione del personaggio che fa pace con la propria sessualità e inizia ad esprimerla attraverso una storia d’amore. Questa è la storia che ci hanno raccontato fin da quando eravamo piccoli: così è come vanno le cose. Tuttavia, questo processo finisce spesso per annullare l’identità queer e rafforzare stereotipi negativi sulla vita delle persone LGBTQ+: la rappresentazione è in parte reale, ma in parte non fa altro che alimentare convinzioni stagnanti che sono, purtroppo, già presenti nella società.
Negli ultimi anni sembra che lo sviluppo narrativo stia cominciando a cambiare, andando oltre il concetto stereotipato che lo spettatore potrebbe avere dell’elemento queer della storia, inserendolo come parte integrata e già esistente nella trama.
Pensiamo, ad esempio, a Heartstopper, la serie adolescenziale disponibile su Netflix. Racconta la storia d’amore tra due ragazzi, esplorando al contempo le relazioni di amicizia e affetto che li circondano. Nessuna presa di coscienza straziante, nessun tormento, nessun rifiuto: solo un personaggio omosessuale che si sveglia al mattino in un mondo di cui fa già parte, senza segreti e senza lotte da affrontare per legittimare la propria esistenza.
È proprio qui, tra le storie che danno vita al binge watching, che prende forma una rappresentazione positiva di sé stessi, che non ruota attorno alla discriminazione o alla vittimizzazione e che non ha bisogno di essere drammatica per risultare autentica. Una rappresentazione che normalizza, che non spiega, che è.
Pensiamo anche a Modern Family, forse tra le serie meno recenti che hanno dato inizio a una maggiore integrazione dei personaggi LGBTQ+ nella trama. Cam e Mitchell sono una coppia omosessuale visibile fin dall’inizio, senza traumi né discriminazioni, e che non occupa l’intera trama ma solo una parte di essa. E ancora: Sex Education, Schitt’s Creek, dove David Rose è apertamente pansessuale. La serie non affronta mai il tema con grandi spiegazioni, perché il focus della storia è un altro: lo svolgimento è naturale, colloquiale e il personaggio si muove all’ interno della trama senza doversi giustificare. Quando a David viene chiesto quali siano le sue preferenze, lui risponde solo: “Mi piace il vino, non l’etichetta”.
Leggi anche:
Tra sessualità e diritti: l’arcobaleno di essere umani
In Olympo, recentissima serie sempre marchiata Netflix vediamo un perfetto equilibrio tra personaggi etero e queer: un intreccio di storie che ci restituiscono più punti di vista. Zoe e le sue tresche bisessuali occupano una parte secondaria nel suo ruolo e nella sua vicenda, e il tema non viene mai esplicitamente affrontato perché la sua non è una scoperta. La validazione del suo personaggio nella storia avviene tramite un susseguirsi di altre vicende, all’interno delle quali il suo orientamento sessuale è solo un dettaglio, non un punto centrale. Per altri protagonisti, invece, la narrazione si che ha come fulcro la scoperta di sé e della propria sessualità. Nella serie si mischiano possibilità di vita reale e consapevolezza di una maggiore normalizzazione nella società, ricordandoci che questa “normalità” non è ancora assoluta e che bisogna proseguire nell’integrazione, nella rappresentazione e nella visibilità.
Una rivoluzione silenziosa
Questi dettagli, all’interno di alcune delle serie tv degli ultimi anni, a volte nascosti, non necessariamente descritti o protagonisti del racconto, contribuiscono alla presa di coscienza collettiva dell’integrazione queer in un mondo eteronormativo, non solo nella realtà fisica ma anche in quella del mondo mainstream.
Questo nuovo modello di rappresentazione, ancora da definire e da intensificare, contribuisce ad influenzare la percezione sociale e personale di realtà ancora troppo spesso emarginate e stereotipate, favorendo una maggiore inclusione. Lo fa con un linguaggio vicino alla realtà, pensato per i giovani, semplice, non necessariamente cinematografico, non necessariamente dichiarato.
Leggi anche:
LGBTQ+: cosa significano le lettere dell’acronimo?
Non serve più un cartello che dica: “questa è una storia queer”. Una storia dovrebbe essere solo una storia, no?
Questi personaggi, queste serie, ci dimostrano che la rappresentazione può essere silenziosa, ma non per questo meno rivoluzionaria.
E se la rappresentazione può accendere un riflettore, non dimentichiamoci dell’impianto circostante, fatto di diritti, ascolto, protezione, cultura. Il silenzio può essere rivoluzionario solo se non è imposto. Solo se è scelto. Solo se è il punto d’arrivo, non l’unica opzione.
In molte realtà la discriminazione persiste, non tutte le storie ci sono. Non tutt* trovano uno spazio, non a tutt* è concesso il lusso di essere raccontat* con la stessa libertà e naturalezza. Lusso.
La strada verso una piena inclusione è ancora lunga, e per arrivarci è necessario che la narrazione continui, è necessario continuare a mostrare e a includere, affinché la normalità queer non sia più un’eccezione, ma diventi una regola.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!