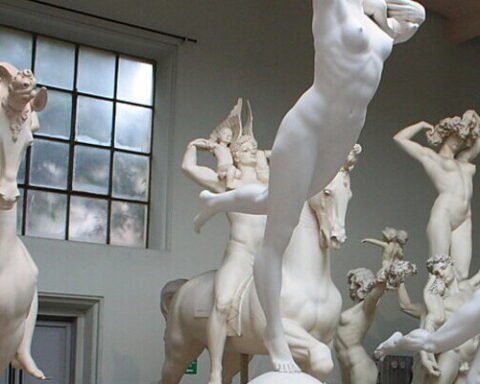Firenze, 1886, Festa dell’Arte e dei Fiori. Alla presenza del re Umberto I e della regina Margherita di Savoia, viene inaugurata a Palazzo Corradi una grande mostra che, con oltre settecento opere di artisti internazionali, offre una panoramica dei principali movimenti artistici dell’Ottocento, dal Simbolismo ai Macchiaioli.
Tra le numerose opere esposte, una suscita particolare scalpore: si tratta del ritratto di una giovane donna bionda, la cui posa rilassata, i capelli leggermente in disordine e lo sguardo fisso rivolto allo spettatore contrastavano con le pose plastiche ed eleganti con cui erano solite essere ritratte le nobildonne.
L’opera in questione, dal titolo evocativo Sogni, è stata realizzata dal pittore livornese Vittorio Matteo Corcos, che assiste divertito alle reazioni di sdegno suscitate dalla sua opera. Nonostante lo scalpore provocato, l’opera fu immediatamente acquisita dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dove continua tuttora a fissare assorta i visitatori.
Leggi anche:
«Boldini e la moda». Sfarzo e modernità in mostra a Ferrara
«Sogni» di Vittorio Matteo Corcos: analisi dell’opera
Realizzato nel 1986, Sogni vede protagonista Elena Vecchi, all’epoca ventitreenne, figlia dello scrittore Augusto Vecchi, noto con lo pseudonimo di Jack La Bolina, amico di lunga data dell’artista autore del dipinto. A colpire i visitatori della mostra fiorentina fu la rappresentazione informale della giovane, seduta su una panchina con le gambe accavallate e la schiena leggermente piegata, la mano sollevata a sorreggere il mento, mentre rivolge allo spettatore uno sguardo penetrante e nello stesso tempo pensieroso. L’atteggiamento rilassato e colloquiale azzera le distanze tra pittore e modella, suggerendo un rapporto di confidenza tra i due, un’amicizia o forse qualcosa di più. A proposito dell’importanza dello sguardo nei soggetti ritratti il pittore aveva dichiarato: «In un ritratto quello che conta sono gli occhi. Se quelli riescono come voglio, con l’espressione giusta, il resto viene da sé».

Accanto alla giovane una serie di oggetti quotidiani appoggiati con noncuranza sulla panchina: un pregiato ombrellino da passeggio, un cappello di paglia e dei libri. Quest’ultimi, topos ricorrente nella rappresentazione delle giovani aristocratiche di fine Ottocento, appaiono chiusi, forse a sottolineare la complessità e l’impenetrabilità del mondo interiore della fanciulla ritratta, che sogna senza che sia possibile immaginare il contenuto del suo fantasticare, forse una riflessione scaturita dalle letture, oppure una fantasia d’amore.
L’opera, oggi considerata il maggior capolavoro dell’artista livornese, ritrae una femminilità emancipata e intellettuale, consapevole e nello stesso tempo sognatrice, emblema del modello femminile colto e indipendente di fin de siécle, celebrato anche nella letteratura di autori del calibro di Gustave Flaubert.
Leggi anche:
Madame Bovary c’est moi, ovvero la vera natura dell’uomo
A proposito dell’autore
Nato a Livorno nel 1859, l’artista si forma all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Nel 1881 si trasferisce a Parigi, epicentro mondiale delle nuove tendenze artistiche, dove frequenta gli ambienti più esclusivi e respira la temperie culturale della Belle Époque, specializzandosi nella ritrattistica dell’alta borghesia parigina.
La sua particolare propensione a ritrarre affascinanti giovani donne in contesti mondani gli valse l’appellativo di «Peintre de Jolies femmes», coniato dal giornalista Henri Blowitz, corrispondente parigino del Times.
Lungi dall’essere un pittore monotematico, Corcos si cimenta anche nella pittura paesaggistica e religiosa, divenendo un punto di riferimento intellettuale al suo ritorno in Italia.
Rientrato a Firenze nel 1887, diventa animatore di salotti letterati frequentati da personalità del calibro di Giosuè Carducci e Gabriele D’Annunzio, conosciuti grazie al matrimonio con Emma Ciabatti, donna colta e raffinata già inserita in prestigiosi circoli letterari.
La sua fortuna prosegue nel Novecento quando si trasferisce in Germania dove realizza alcuni celebri ritratti di corte, tra cui quello dell’imperatore Guglielmo II. Rientrato a Firenze, muore nel 1933 a distanza di pochi giorni dalla moglie.
Completamente dimenticato durante la Seconda Guerra Mondiale e nell’immediato dopoguerra, per via dei temi giudicati frivoli e lontani dalla sensibilità tormentata di quel periodo, Corcos è oggi considerato, insieme al contemporaneo ferrarese Giovanni Boldini, uno dei grandi interpreti del nuovo ideale femminile affermatosi a cavallo tra i due secoli.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!