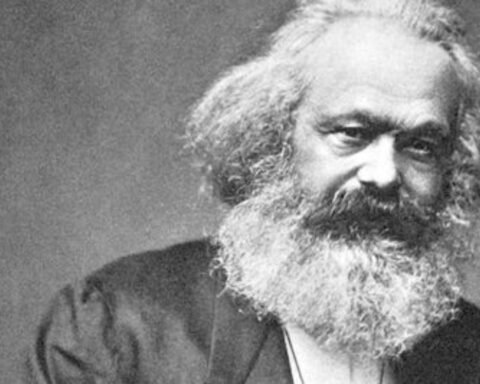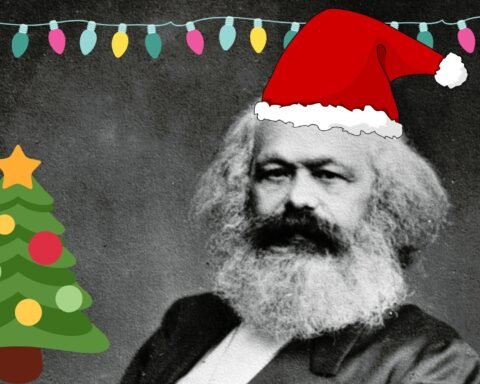Non è, né tantomeno sarebbe potuto cadere nel silenzio, l’appello disperato quanto lucido verso le criticità dell’università, lanciato lo scorso 9 luglio al momento della consegna dei diplomi da Virginia Magnaghi, Valeria Spacciante e Virginia Grossi, studentesse della Scuola Normale Superiore di Pisa. Tre voci ferme, di disarmante puntualità e chiarezza, hanno fatto crepare la bolla di vetro della cerimonia, per restituirci un quadro finemente esposto delle contraddizioni, e preoccupazioni, che affollano oggi la mente di ogni giovane che si trova a vivere l’università in senso attivo e critico.
Perché queste tre studentesse hanno senz’altro un non trascurabile merito, vale a dire quello di aver messo in perfetta forma una matassa aggrovigliata di cui, sfortunatamente, conosciamo molto bene i bandoli di partenza e di arrivo. Ci si riferisce nel caso specifico, come ha lucidamente esposto Virginia Magnaghi, al:
Processo di trasformazione dell’università in senso neoliberale. Con questa espressione intendiamo un’università-azienda, in cui l’indirizzo della ricerca scientifica segue la logica del profitto, in cui la divisione del lavoro scientifico è orientata ad una produzione standardizzata, un’università in cui lo sfruttamento della forza lavoro si esprime attraverso la precarizzazione sistemica e crescente, in cui le diseguaglianze sono inasprite da un sistema concorrenziale che premia i più forti e punisce i più deboli, aumentando i divari sociali e territoriali.
La competitività esasperata nelle università italiana
Vale la pena passare al setaccio quanto sopra riportato. Conosciamo bene sotto quale effigie si combatte l’ingiusta causa a favore dell’università neoliberale, ed è, naturalmente, quella di una deviazione perversa del concetto di meritocrazia, di una fratricida esasperazione di una competitività senza vincitori né vinti. Quando si esalta la cosiddetta retorica del merito, troppo spesso sono date per scontate alcune imprescindibili diseguaglianze di partenza: dal reddito familiare al contesto sociale, passando per l’area di provenienza, fino a sfociare in questioni di genere, nonché di differente resa e capacità di tenuta, da un punto di vista psicologico, in condizioni di stress prolungato – a tal proposito, basta un veloce controllo in rete per rendersi conto dell’esponenziale crescita di richiesta di supporto psicologico da parte della popolazione studentesca, se non dei numeri relativi all’abbandono scolastico, dati quanto mai esasperati all’interno delle cosiddette scuole di eccellenza. Ed ecco come il ventaglio dei meritevoli restringe la sua forbice, ecco come l’esser talentuosi cessa di esser un concetto accogliente e basato sulle sole qualità intellettuali, traducendosi in una definizione tanto angusta da escludere coloro i quali non godono, almeno nella grande maggioranza dei casi, dei requisiti di cui sopra.
Il merito come criterio giudicante
Allora qual è il vero pericolo che tacitamente contribuiamo ad alimentare dietro queste contraddizioni? Per rispondere, si potrebbe portare all’attenzione quello che è possibile definire il binomio identità-merito. Ci si chieda: quando un concetto “fa sistema”? Quando attorno ad un termine il contesto socio-economico e culturale si struttura, si significa? Quando, attraverso tale concetto, ne va della mia identità. Si presti attenzione: è un sogno vano pensare l’identità come una serie di caratteristiche assegnate dal singolo a sé stesso. Umberto Galimberti esprime questa sfumatura con estrema chiarezza nei suoi testi, specificando come l’identità sia sempre conferita all’individuo dall’altro, dall’incontro, dal riconoscimento. Allora il concetto di merito fa sistema nella misura in cui è in base ad esso che io ricevo questa o l’altra identità, subisco questo o l’altro processo di identificazione sociale. Sappiamo molto bene infatti che, in ambito accademico, la persona, la sua essenza e ampiezza risultano spesso appiattite, ridotte, volta per volta, all’esito di un voto di laurea, ad un esame, ad una performance di pochi minuti. Sappiamo molto bene che il processo di identificazione sociale cui va incontro una studentessa che, ad esempio, supera le prove di selezione della facoltà di medicina, o che varca le soglie della Scuola Normale, non sono le stesse della compagna che non è arrivata alla soglia minima richiesta.
Leggi anche:
Verso un nuovo dualismo cartesiano nella scuola? No, per favore no!
Il merito fa sistema dunque nella misura in cui funziona da criterio di assegnazione di giudizi, di caratteristiche, di qualità, di prestigio sociale, e dunque, nel momento in cui è ad esso che risponde la persona che si è. Ad alimentare questo fenomeno, concorrono naturalmente anche i canali mediatici, quando, esaltando le straordinarie prodezze di studentesse e studenti che conseguono il diploma di laurea in un tempo minore rispetto a quello previsto, finiscono per suggerire, indirettamente, una forma di biasimo che pende sulla testa dei cosiddetti fuoricorso, categoria prossima, agli occhi dell’università neoliberale, a quella degli appestati manzoniani. Ed ecco che la popolazione studentesca crea e ricrea “classi” al suo interno; ma è evidente che, ad un occhio critico, la lettura del termine classi appaia quantomai somigliante al termine diseguaglianze, e il peso sociale esercitato da questa spartizione, più o meno netta, grava quotidianamente sulla vivibilità delle nostre università.
La sindrome dell’impostore
Un fenomeno interessante segue da un simile contesto. Apparentemente unitario, quest’ultimo tende poi a biforcarsi in due declinazioni rappresentanti due facce della stessa medaglia. Definiamo tale fenomeno, sindrome dell’impostore. A infoltire le fila di questa categoria, sono principalmente coloro i quali soddisfano i requisiti minimi per esser indicati come meritevoli, talentuosi, eccellenze, nel caso specifico delle tre studentesse della Scuola Normale.
In questo caso di studio – introdotto nel 1978 da, forse non per caso, due psicologhe, Pauline Clance e Suzanne Imes[1] – l’identità, che la retorica del merito ha loro assegnato, non è spesso vissuta e percepita con altrettanta soddisfazione, consapevolezza. Il posto da loro ottenuto, dopo aver dovuto lottare e sgomitare a discapito del fallimento di altri compagni, produce un senso di inadeguatezza verso la posizione occupata, come se altri, meglio, avessero potuto ricoprirla, come impostori, usurpatori di un premio che non spetta loro fino in fondo. È significativo che siano state due scienziate donne a coniare il termine, in quanto ancora maggiormente esposte nel lavoro, nelle università, a scuola, ad un continuo quanto tragico ridimensionamento dei propri successi, delle proprie qualità; caso qui confermato dalle parole delle tre studentesse in merito alle gravi disparità di genere presenti sia tra gli studenti che tra i professori dei nostri atenei. Come sopra accennato, questo fenomeno può tradursi in due varianti opposte: da un lato sfociando in una competitività estrema, volta all’esibizione del proprio merito, delle proprie doti, dall’altro in una chiusura ermetica all’interno per paura del giudizio, della valutazione altrui. Inutile ribadirlo, entrambe le declinazioni hanno ingenti costi in termini di qualità della vita dello studente, con esiti talvolta particolarmente significativi sullo stato psicofisico dello stesso.
Il divario nella scuola italiana
Ad essere principalmente messa in questione è dunque nient’altro che la scarsa vivibilità dei nostri atenei e il conseguente stato di malessere non sufficientemente recepito, discusso, affrontato, anzi, talvolta legittimato. Non è infatti senza colpe la scuola in questo scenario, rettifica Valeria Spacciante; è tra i banchi di scuola prima, e dell’università poi, che va interiorizzandosi quella dinamica che ci vuole efficienti, produttivi, competitivi, meritevoli più degli altri a tutti i costi, e sono queste le sedi che incoraggiano e promuovono il modello neoliberale.
Leggi anche:
È possibile immaginare una scuola diversa?
«Ma quale eccellenza tra queste macerie?» torna a dire retoricamente Virginia Magnaghi. Com’è possibile d’altronde, nonostante la condizione privilegiata in cui le tre studentesse candidamente si riconoscono, non guardare con sconforto ai numeri, alle fratture sociali, alle politiche che impoveriscono i nostri atenei? Sono anche questi ultimi dopotutto i responsabili di un cortocircuito logico che li vuole promotori di utile, prima che di valore, di competizione, prima che di sinergia, di profitto, prima che di qualità. In un simile quadro generale, in cui l’Italia, a fronte dello 0,7% della media europea, investe lo 0,3% del PIL nell’istruzione terziaria, le disparità territoriali tra nord e sud, le disparità di genere e le disparità tra atenei privati o scuole d’eccellenza e gli atenei statali, trovano un terreno fertile in cui tagli alla ricerca, al personale, ai docenti, ai posti per dottorati e assegnisti, si susseguono quasi ininterrottamente da quasi vent’anni. Nefasto esito di questo processo è il divario, quasi abissale, pressoché incolmabile, tra poli d’eccellenza e nuovi, sempre più numerosi, poli di serie B.
L’appello lanciato da queste tre studentesse della Scuola Normale di Pisa rivendica un disperato bisogno di esser raccolto e compreso, ed è evidente che le contraddizioni causate dal modello università-azienda non possano essere sanate. La scuola ha bisogno di un ripensamento collettivo, radicale, capace di slegarsi dalle logiche del profitto, e noi studenti abbiamo bisogno di sentirci, da essa, concretamente rappresentati, valorizzati.
[1] Pauline Rose Clance e Suzanne A. Imes, The imposter phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention, in Psychotherapy: Theory, Research & Practice, vol. 15, n. 3, 1978.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!