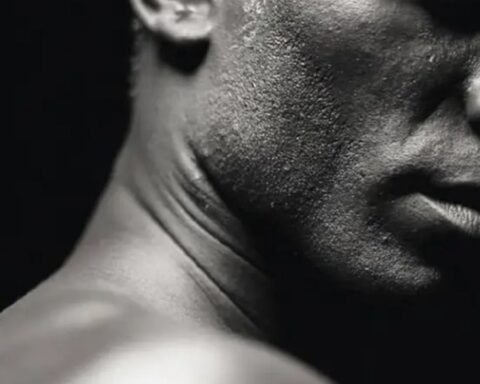Lost Generation, Beat Generation, Millennials, Generazione Z e Generazione Alpha. Nella storia dell’umanità tante sono state le generazioni di ragazze e ragazzi, di uomini e donne in cerca di un punto di riferimento, in cerca di un senso da dare al proprio spaesamento e da qui partire per rifondare la propria esistenza e dare, forse, una stella polare per chi verrà dopo di loro. Tutte queste generazioni hanno saputo e sapranno – chi più e chi meno – a rifondare la cultura dell’umanità
Nel lontano 1991, lo scrittore canadese Douglas Coupland ha pensato bene di scrivere un romanzo che a distanza di anni rappresenta e riesce a rappresentare tutte quelle generazioni in cerca di un senso. Un romanzo che già trent’anni fa ha saputo anticipare l’uso di nuovi linguaggi e che non solo ha saputo interpretare il passato, ma anche anticipare il futuro. Il libro in questione è Generazione X, in italiano pubblicato prima da editori come Interno Giallo e Mondadori e ora riproposto da Accēnto Edizioni nella collana «Accento grave».
Andy, Dag e Claire. Tre ragazzi «membri del jet set dei poveri» all’apparenza normali che hanno una cosa in comune: sono tutti in preda alla crisi dei Venticinque anni, momento cruciale della propria vita in cui «si aggiunge l’improvvisa consapevolezza della propria sostanziale solitudine al mondo». Per risolvere questa crisi, i tre protagonisti decidono di recarsi a Palm Springs, in California, in mezzo al deserto americano lontano da yuppie e famiglie disfunzionali varie. Lontano, insomma, da una peste culturale chiamata «accelerazione culturale» che sta schiacciando la società americana e che minaccia la stabilità dei nostri protagonisti.
Generazione Y, Generazione Z e Generazione Alpha sicuramente non esisterebbero senza Douglas Coupland e la sua Generazione X (acquista). L’autore canadese ha fatto da apripista a tutte quelle generazioni in cerca di una mappa per orientarsi in un mondo bombardato da stimoli che fornisce riferimenti culturali effimeri e frammentati. Douglas Coupland ha dimostrato come dal vuoto si possa generare significato, ma soprattutto come la creazione di storie e di linguaggi riescano ancora una volta a dare un senso e una continuità a ciò che ci stordisce e ci manda alla deriva, a ciò che ci priva di un’identità omologandoci alla massa.
Viviamo vite piccole e di periferia; siamo ai margini, e ci sono molte cose alle quali decidiamo di non partecipare. Volevamo il silenzio, e adesso lo abbiamo. Siamo arrivati qui coperti di piaghe e foruncoli, con il colon talmente aggrovigliato che ci credevamo incapaci di andare di corpo per il resto della vita. Il nostro metabolismo aveva smesso di funzionare, intasato dall’odore delle fotocopiatrici, dal bianchetto, dalla carta extrastrong e dall’incessante stress dei nostri impegni assurdi, svolti di malavoglia e senza riconoscimenti di sorta. Eravamo preda di pulsioni che ci spingevano a confondere lo shopping con la creatività, a prendere tranquillanti e dare per scontato che noleggiare una videocassetta il sabato sera fosse sufficiente. Ma adesso che abitiamo qui nel deserto le cose vanno meglio. Molto meglio.

Questo articolo fa parte della newsletter n. 48 – marzo 2025 di Frammenti Rivista, riservata agli abbonati al FR Club. Leggi gli altri articoli di questo numero:
- Alle origini della Chiesa: San Pietro, il primo papa
- Arte e Chiesa, un rapporto prolifico e conflittuale
- Eros e Chiesa: il complesso rapporto tra sessualità e religione
- Svelare il mistero del potere: la Chiesa cattolica nel cinema di Sorrentino e Bellocchio
- Dall’uso dei piaceri all’etica della rivolta: il cristianesimo in Michel Foucault
- Musica sacra per la cultura pop: «Jesus Christ Superstar»
- Stile libero – Una generazione in bilico fra futuro e medioevo
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!