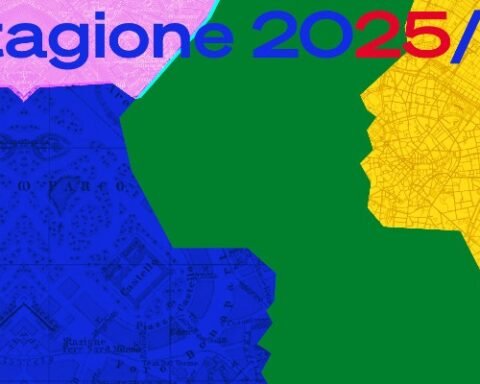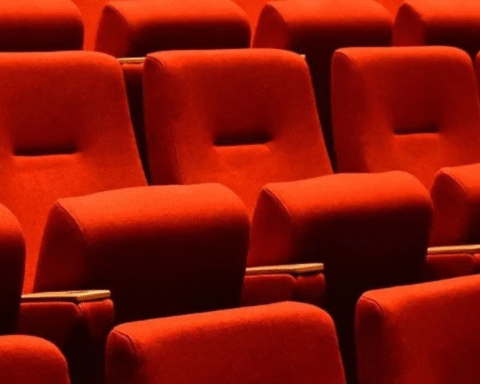Chiesa e Teatro, si sa, non hanno mai avuto un rapporto idilliaco, almeno ufficialmente. Non solo la Chiesa cattolica, ma la maggior parte delle istituzioni religiose occidentali hanno sempre guardato al teatro come un luogo di perdizione. Dal 400 d.C. circa, dopo che il cristianesimo divenne religione di stato, vennero eliminate diverse manifestazioni teatrali a Roma (sede da cui si diffuse maggiormente la fede cattolica).
Tertulliano denunciò il teatro nel suo De spectaculis e dal 300 d.C. in poi i concili della chiesa vietarono ai cristiani di assistere alle rappresentazioni teatrali. Nel 398 d.C. il Concilio di Cartagine decretò la scomunica per chiunque andasse a teatro nei giorni di festa; infine un decreto proibiva agli attori di ricevere i sacramenti se non rinunciavano alla loro professione. Per diversi secoli agli attori era proibito essere sepolti con gli altri cittadini.
Persistenza
Come tutt’oggi vediamo il teatro non è mai scomparso completamente. Una qualche forma di rappresentazione drammatica è sempre sopravvisuta, essendo parte della stessa natura umana. Durante il medioevo ad esempio, periodo in cui il cristianesimo influenzava tutti gli aspetti della vita, erano molto diffuse le sacre rappresentazioni. Dunque pur non essendo coinvolti attori professionisti, il teatro era parte integrante della vita sociale.
Connubio
Jesus Christ Superstar
Il film del 1973 è tratto dal musical omonimo che continua ad essere rappresentato dal 1971. È stato girato in Israele presso le rovine di Avdat e in altre zone del Medio Oriente. Le rovine delle scene di Anna e Caifa sono quelle originali del palazzo dei Sommi Sacerdoti, le impalcature furono trovate sul luogo dalla troupe.
Per la pellicola il regista Norman Jewison ha scelto un inizio metacinematografico. Un gruppo di attori arriva sul sito di Avdat e inizia a scaricare l’attrezzatura per mettere in scena Jesus Christ Superstar. Gli attori indossano abiti contemporanei e agiscono in ambienti pre-esistenti o ricostruiti che richiamano i tempi di Cristo. La contemporaneità si inserisce nell’immaginario filmico anche con l’inserimento di elementi come i carri armati che inseguono Giuda e i jet che passano sopra la sua testa dopo che ha deciso di tradire Gesù.
Le musiche
Il musical è un’opera rock. Le musiche infatti appartengono a quel genere, discostandosi dalle classiche composizioni per il musical. Le sonorità sono varie e spesso catchy per il loro ritmo sostenuto e le melodie non scontate per un dramma musicale. Alcune canzoni sono dei veri e propri classici da ascoltare anche fuori contesto, non sappiamo dire se lo sono diventate per la longevità del musical o è proprio grazie a loro che lo spettacolo viene ancora rappresentato.
Il pezzo più iconico è proprio quello di apertura, cantato da Giuda (Carl Anderson), Heaven on their minds.
Vediamo come in apertura si decide di presentare colui considerato il traditore che si pone domande sull’andamento della predicazione di Gesù. Dal testo della canzone si capisce come Giuda sia preoccupato di andare troppo oltre; si legge tra le righe anche l’impegno politico del discepolo. L’Iscariota infatti era presumibilmente parte degli zeloti, un gruppo di giudei che sostenevano con fervore l’indipendenza politica della Giudea. Cerca dunque di mettere in guardia il Maestro dal fanatismo dei fedeli.
Virtuosismi canori
Due brani che stupiscono sempre chi ascolta il musical sono This Jesus Must Die e Gethsemane (I Only Want To Say) entrambe per la particolarità delle interpretazioni.
Caifa, interpretato da Bob Bingham, riflette sulla risoluzione della «Jesus mania» e lo fa raggiungendo toni gravissimi con la propria voce, creando un perfetto opposto della voce di Ted Neeley.
La preghiera al Getsemani vede Gesù mettere in dubbio il proprio operato e quanto possa servire il proprio sacrificio. Ted Neeley interpreta il brano in uno stile radicato nel rock da un punto di vista di utilizzo della voce e raggiunge l’acuto che chiunque bazzichi l’ambiente conosce.
Ovviamente tutta la colonna sonora del film meriterebbe un’attenta analisi, ma già da questi pochi brani si può comprendere quanto lo spettacolo abbia influenzato il mondo dei musical e il film abbia permesso una fruizione quasi globale del genere.
L’accoglienza del film
Il film uscì durane un periodo di profonda crisi religiosa per tutto il mondo, infatti la sua accoglienza fu diversa da parte dei credi religiosi. Sorprendentemente, stando a un’intervista di Ted Neeley, Papa Paolo VI fu positivamente colpito dalla pellicola dopo che venne sottoposta al vaglio dell’Osservatore Romano. Tuttavia, il quotidiano smentì questa notizia e il Papa non confermò.
Altri enti non furono dello stesso avviso: il New York Times riportò l’opinione della comunità ebraica che ritenne il film antisemita, i cristiani cattolici e protestanti lo avrebbe considerato blasfemo. Il Jewish Council for Public Affairs sostenne che l’opera fosse suggerisse l’idea di «vedere gli ebrei in toto come corresponsabili della morte di Gesù» (Spiegel, Irving; 24 Giugno, 1973. «Jewish Unit Calls Movie ‘Insidious’»).
In un’intervista Tim Rice spiegò che la figura di Gesù, essendo vista attraverso lo sguardo di Giuda, emergeva come quella di un mero uomo. L’affermazione venne interpretata da alcuni cristiani come blasfema. Altri ancora videro la figura dell’Iscariota come troppo positiva e vicina allo spettatore. I biblisti sottolinearono le incongruenze di narrazione: il sogno di Pilato è in realtà della moglie nel racconto evangelico e le parole di Cristo riportate nella scena dell’ultima cena sono di definizione tipicamente protestante.
Il Bel Paese
Da un punto di vista musicale, il film di Norman Jewison venne accolto positivamente anche in Italia, pur essendo il paese della Santa Sede. Mina cantò Everything’s alright con Sammy Barbot e Claudia Mori incise una versione di I Don’t Know How To Love Him, riconoscendo il valore artistico dell’opera.
L’Italia poi ha sicuramente un rapporto particolare con i racconti evangelici e biblici: il cattolicesimo è parte della nostra cultura anche negli aspetti più laici. Le opere artistiche che vediamo sono per la maggior parte legate alla Fede cristiana. Insomma la Chiesa è una presenza significativa all’interno delle nostre attività culturali, e in quanto tale non è strano che il panorama dello spettacolo dal vivo italiano ne sia influenzato.
Superstar
Nel film si va a raccontare una delle storie più famose del genere umano. Gesù è la personalità più conosciuta del mondo: chiunque, di qualsiasi credo religioso o meno, ha sentito parlare di lui. Jesus Christ Superstar aggiunge la grandiosità del musical, ricreando quasi quella stessa fama di cui godeva Gesù Cristo ai suoi tempi.
Se dunque il film ha sicuramente goduto della sua fama grazie al tema trattato, viceversa i fatti del Vangelo hanno indossato vesti contemporanee che gli hanno permesso di entrare nella vita quotidiana e nella cultura popolare del mondo odierno.
Insomma guardando alle fondamenta di tutto possiamo dichiarare che per Teatro e Chiesa l’importante è che ci sia una storia che mostri agli uomini la possibilità di un mondo diverso, migliore.

Questo articolo fa parte della newsletter n. 48 – marzo 2025 di Frammenti Rivista, riservata agli abbonati al FR Club. Leggi gli altri articoli di questo numero:
- Alle origini della Chiesa: San Pietro, il primo papa
- Arte e Chiesa, un rapporto prolifico e conflittuale
- Eros e Chiesa: il complesso rapporto tra sessualità e religione
- Svelare il mistero del potere: la Chiesa cattolica nel cinema di Sorrentino e Bellocchio
- Dall’uso dei piaceri all’etica della rivolta: il cristianesimo in Michel Foucault
- Musica sacra per la cultura pop: «Jesus Christ Superstar»
- Stile libero – Una generazione in bilico fra futuro e medioevo
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!