L’isola è il luogo per eccellenza della letteratura. Basti pensare alle utopie fondative di Utopia di Tommaso Moro e di Robinson Crusoe di Daniel Defoe, alla fantascienza de L’isola di Dottor Moreau di H. G. Wells e L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares, ma anche all’isola di Procida de L’isola di Arturo di Elsa Morante, dove l’isola è espressione dell’infanzia e dell’innocenza del suo protagonista. E poi c’è Ortigia, isola che costituisce la parte più antica della città siciliana di Siracusa, che grazie a Veronica Galletta e al suo primo romanzo Le isole di Norman – edito lo scorso maggio dalla casa editrice romana Italo Svevo Editore, finalista alla XXVIII edizione del Premio Italo Calvino e vincitore del Premio Campiello Opera Prima di quest’anno – si appresta a farsi letteratura e ad arricchire il nostro immaginario letterario insulare.
La trama de «Le isole di Norman»
Elena, ventenne studentessa di geologia, vive sull’isola di Ortigia assieme al padre Michele, professore di matematica ed ex militante del partito comunista, e alla madre Clara, che passa il tempo chiusa nella sua camera impilando i libri secondo un ordine a lei noto e che la figlia decide di mappare per capire il suo comportamento misterioso.
Un giorno, però, la madre decide di lasciare la casa, lasciando anche i libri, tra cui la copia de La montagna incantata di Thomas Mann a cui tanto tiene. Elena, dunque, attraverserà tutta l’isola di Ortigia per elaborare la scomparsa di quella madre che forse non tornerà più, ma allo stesso tempo alla ricerca dei ricordi del suo passato. Ben presto, però, la nostra protagonista scoprirà quanto segue:
«Camminare sulle impronte del passato non è mai una buona idea. Si finisce per scoprire che il passato non esiste, non in quella forma in cui lo abbiamo sempre pensato.»
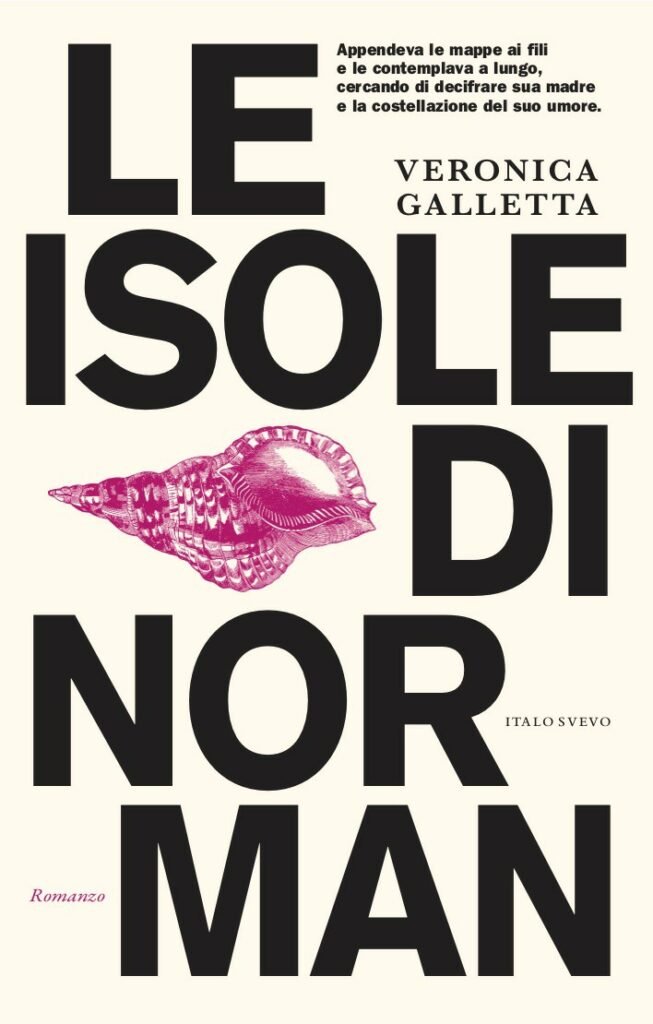
Analisi del testo
La narrazione de Le isole di Norman si svolge prevalentemente al presente con dei flashback al passato – dai toni sfumati e incerti – della protagonista, come a indicare una memoria e un’identità in continuo divenire. Alcuni titoli contengono le coordinate delle mappe che Elena disegna tenendo a mente la collocazione dei libri nella stanza di sua madre, come se il lettore, assieme alla protagonista, stia giocando a battaglia navale, dove per ogni sommergibile che si colpisce e affonda si aggiunge un tassello al passato della protagonista.
Ciò che è fondamentale da tenere a mente è l’influenza de L’isola del tesoro di R. L. Stevenson, come si evince dal titolo del romanzo. Le isole di Norman, infatti, allude a Norman Island, isola dell’arcipelago delle Isole Vergini Britanniche che molto probabilmente ha ispirato la creazione dell’omonima isola del tesoro del romanzo dell’autore scozzese.
Elena, come il capitano Jim, si mette in viaggio verso il tesoro – rappresentato qui sia dalla figura della madre che dai ricordi perduti – e come il capitano trova nel padre Michele il suo Long John Silver, una figura paterna, rassicurante, ma allo stesso tempo traditrice e menzognera, recalcitrante all’idea di rispondere alle domande della figlia sul suo passato e sulla fuga della madre.
Parlando di isole dei ricordi e delle menzogne, Ortigia qui ricorda molto l’isola di W in W o il ricordo d’infanzia, romanzo del 1975 di Georges Perec, in cui l’autore dell’OuLiPo inventa sulla base dei disegni dell’infanzia l’esistenza di quest’isola al largo della Terra del Fuoco per ricostruire il ricordo rimosso della sua infanzia partendo dall’assenza dei genitori, in particolare di sua madre, morta ad Auschwitz per le sue origini ebraiche. Così anche Elena cerca di ricordare – o reinventare – il suo passato a partire dall’assenza di sua madre.
Ortigia, l’isola del rimosso
Il contesto in cui Elena cerca di mappare i suoi ricordi è quello dell’isola di Ortigia, così descritta nel romanzo:
«Ortigia non è sempre stata un’isola. La collegava alla terraferma un istmo sottile, che ormai non c’è più. Adesso solo qualche centinaio di metri la separano dalla terraferma, alla quale si arriva e si esce attraverso due ponti, che non bastano comunque per ignorare il confine. La condizione di isolani marca la differenza fra un dentro e un fuori, e chi ci abita si allontana malvolentieri per andare in Città, e quando lo fa, lo mette in chiaro anche lessicalmente. È per questo che andare in Città si dice passare i ponti. Finché gli è possibile, chi vive sull’Isola ci rimane. Perché Ortigia è prima di tutto una scelta. Spopolata dagli entusiasmi del boom economico, quando le sue abitazioni anguste e dalle distribuzioni poco razionali non potevano far fronte alle richieste di riscatto sociale, il doppio salone, il riscaldamento, il bagno con la vasca, l’ascensore, l’Isola ha avuto periodi di sorte alterna. Adesso sono i poverissimi a essere rimasti, insieme ai nostalgici, agli artisti, ai bastian contrario per vocazione. E alcuni stranieri, che hanno trovato in questa estraneità alla terraferma un equilibrio felice per stare dentro le cose.»
L’isola di Ortigia – con i suoi vicoli, il suo mercato del pesce, i suoi giardini, il Tempio di Apollo, il Castello Maniace, il Largo della Giudecca e gli scorci sul mare – costituisce il rifugio di Elena e della sua famiglia dalla città e da un passato poco chiaro. L’isola, però, sembra intrappolare i protagonisti, al punto che più che trovare equilibrio, essi trovano una prigione da cui sembra impossibile uscire.
Leggi anche:
Ricordi di Sicilia: terra e mare e colore del vino
Non è un caso, ad esempio, che il faro del tetto del carcere illumina la loro casa, e neanche il fatto che il narratore menzioni i «dedali di puntelli arrugginiti, ricordi di terremoti lontani ma mai superati». L’isola come dedalo, come prigione da cui difficilmente si scappa, così come difficilmente si scappa dal proprio passato.
Ortigia, di cui il narratore descrive le forme tonde e accoglienti e il colore bronzeo e lucido, nasconde, però, una natura più «luciferina». È un’isola-sepolcro, che ti condanna all’oblio seppellendoti vivo. Ha inghiottito la madre di Elena e si appresta a inghiottire quest’ultima. Dell’isola si dice anche che:
«[…] a vivere ovattati dentro a un’Isola, soffocati dai propri pensieri, si finisce per non afferrare più niente degli altri. Servirebbe un ordinatore di parole. Un sistema che le prende, le mette in ordine e le classifica. Per genere, per lunghezza, per iniziale, per frequenza, per funzione.»
Mappare la madre e i ricordi rimossi
Nonostante tutto, Elena sa che non può vivere sommersa dall’assenza della madre e dai detti e non detti sul suo passato, in particolare su quell’incidente che le ha provocato i cheloidi sulle gambe e la cicatrice sulla schiena quando era bambina. Nell’uscire dalla sua prigionia, dunque, decide di elaborare l’assenza della madre lasciando i suoi libri in determinati punti dell’Isola per:
«Mummificare la madre. Espellere la madre. Liberare la madre. Da questo doveva partire. Questo doveva fare. Solo così si sarebbe potuta liberare anche lei.»
Da ricordare che il nome della madre di Elena è Clara, che rimanda alla luce, alla rivelazione, in questo caso, delle verità nascoste, come quel quaderno delle elementari che lascia alla figlia. Andando avanti nel romanzo a disseminare libri per l’isola di Ortigia, infatti, Elena si sente sempre più soffocare, poiché «le cose si complicano, non si sciolgono, anzi si annodano». Ogni incontro e ogni luogo di Ortigia non fanno che peggiorare le cose. Più va avanti, e più la memoria del suo passato si fa più incerta e inafferrabile.
Leggi anche:
Elsa Morante, “l’isola di Arturo” e il linguaggio delle passioni
Tuttavia, vi sono anche dei momenti epifanici, rivelatori, come l’incontro con Pietro, che le parla della tela del Seppellimento di Santa Lucia di Caravaggio in questi termini:
«È il nero il segreto. Il nero è la chiave di tutto. Tu guardi e vedi la Santa a terra, i due becchini, il vescovo e la donna inginocchiata. Ma non è questo, quel dipinto non è questo. Quella tela è tutta nel nero, quel nero fondo che sta alle spalle, dietro. Dentro quel nero denso e appiccicoso c’è tutto. C’è tutto il resto. C’è l’artista che fugge, c’è il segreto di chi parte, il dolore di chi resta.»
Oppure la metafora della brioche con il gelato usata dalla vicina di casa, la signorina Lidia:
« È importante guardare le cose per quello che sono, e non per quello che sembrano. Per esempio questo panino costa cinquanta lire. Lo riempi di gelato, ed ecco una brioche, buona come quella del bar. Che però costa ottocento lire». […] «E usare anche un po’ di fantasia», prosegue. «Prima guardare le cose per quello che sono, e poi usare la fantasia. Ma ognuno ci deve mettere la propria, mica quella di un altro.»
«Le isole di Norman»: la memoria come invenzione
Questi momenti epifanici, dunque, rivelano come la memoria sia costruzione, invenzione, per dimenticare il dolore del passato e proseguire nel presente. Una costruzione che nel caso di Elena ruota attorno a un personaggio misterioso: Lucia Ria, una bambina di cui Elena racconta nel suo quaderno di quando era piccola, quello stesso quaderno lasciato dalla madre per far sì che Elena possa scoprire la verità sul suo passato, vale a dire quello dell’incidente con l’acqua bollente.
Di questa bambina Elena ha dei ricordi molto sfumati. Sul quaderno trova scritto che il padre l’ha fatta riconciliare con lei perché «non è giusto raccontare cose non vere», ma Elena ne ricorda gli occhi marroni che la osservavano mentre le cadeva addosso la pentola d’acqua bollente a casa di Margherita. La ragazza ricorda addirittura che il padre le diceva di non menzionare una «lei» nel parlare dell’incidente con i compagni di scuola, forse riferito a Lucia Ria, forse a Margherita, l’amica di famiglia presente al momento dell’incidente.
Infine, una Lucia – forse la stessa Lucia Ria, forse no – viene menzionata dalla madre Clara parlando delle gemelle dell’amica Maria, ovvero Adele e Lucia, vittime di un incidente analogo a quello di Elena. Come quest’ultima, una delle due è stata ricoverata in ospedale, mentre l’altra è stata portata dalla Signora – più volte menzionata nei flashback dell’infanzia di Elena – a guarire le ustioni, ma senza sapere a chi è toccato cosa.
Leggi anche:
Passato nel presente
Il mistero si infittisce quando il padre, intento a cucinare le sue parmigiane di melanzane, non sa dare una risposta agli interrogativi della figlia su questa figura. E allora il lettore si chiede come possa essere accaduto l’incidente, se è veramente stato causato dalla stessa Elena oppure questa è una versione inventata per proteggere qualcuno che può averlo causato, magari Margherita, verso cui Michele, il padre di Elena, è molto protettivo (forse perché l’amava), oppure Lucia, e quindi bisogna pensare che Elena sia in realtà Adele e Lucia sua sorella gemella. E se Elena e Lucia fossero due facce della stessa medaglia come i gemelli Lucas e Klaus di Trilogia della città di K dell’ungherese Ágota Kristóf? Ovvero se Lucia fosse stata inventata da Elena una volta diventata grande per superare il suo trauma?
Tanti gli interrogativi, e tante le possibilità, ma Elena non riesce comunque ad afferrare i propri ricordi e a impossessarsi di un passato a lungo rimosso. Quello che le resta è inventarsi una propria verità per sopravvivere e superare il dolore:
«Non è rimasto niente di una famiglia senza passato che ha cercato di costruire qualcosa, anche solo un ricordo finto, una foto posticcia di una vita, come un fotomontaggio. Ma non è forse questo quello che fanno tutti? Selezionare immagini, scegliere fotogrammi, costruirci attorno il resto, giorno dopo giorno, anno dopo anno. No, non sono così diversi dagli altri. Una famiglia come tutte le altre. Una disturbante normalità. Un’orrenda normalità. […] un mondo misterioso e non perfetto, inafferrabile, per il quale bisognava approssimare, fare a pezzi, investigare, sperimentare.»
Conclusione
Con Le isole di Norman, Veronica Galletta scrive un debutto che non lascia indifferenti, in cui la protagonista, inseguendo un’assenza, insegue se stessa e il suo passato, arrivando alla conclusione che per superare il perturbamento della memoria scegliamo frammenti di essa per trasformarli in ricordo, creando una versione dei fatti che ci consola, che ci evita un confronto diretto con i traumi dolorosi del passato.
L’unica certezza de Le isole di Norman è l’isola di Ortigia, un luogo reale che si fa letteratura, eletto a «santuario della memoria», come recita la motivazione del conferimento del Premio Campiello Opera Prima. Un luogo simile alla Procida di Elsa Morante, alla Norman Island di Robert Louis Stevenson o all’isola della Polinesia de L’invenzione di Morel di Adolfo Bioy Casares: un luogo affascinante che crea illusioni consolatorie difficili da lasciare, poiché rifugio dal dolore.
«Questa è l’Isola, che sorprende e poi abbandona, che provoca e blandisce, che conquista e poi scompare, nella perfezione di una colonna, nello scintillio dell’alluminio degli infissi, nell’eternità di un gatto che dorme, nel tanfo del sacchetto di rifiuti che ha appena sventrato. Solo abitandola quotidianamente, accettandone le contraddizioni e affidandoti a lei, Ortigia si rivela, come una cura.»
Immagine in evidenza: dettaglio della copertina.
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook, Instagram e Spotify, e iscriviti alla nostra Newsletter
Sì, lo sappiamo. Te lo chiedono già tutti. Però è vero: anche se tu lo leggi gratis, fare un giornale online ha dei costi. Frammenti Rivista è edita da una piccola associazione culturale no profit, Il fascino degli intellettuali. Non abbiamo grandi editori alle spalle. Non abbiamo pubblicità. Per questo te lo chiediamo: se ti piace quello che facciamo, puoi iscriverti al FR Club o sostenerci con una donazione. Libera, a tua scelta. Anche solo 1 euro per noi è molto importante, per poter continuare a essere indipendenti, con la sola forza dei nostri lettori alle spalle.









