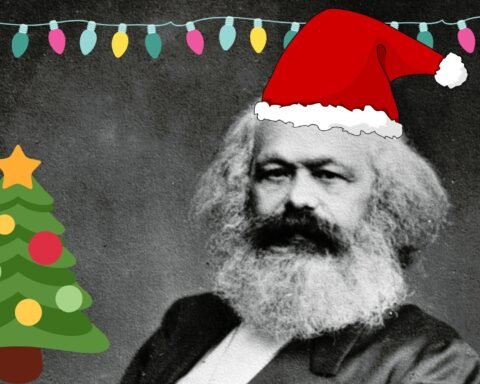Il dolore si è ormai trasformato nel nostro pane quotidiano. Non passa giorno senza che una qualunque famiglia nel mondo, riunita attorno alla tavola, accenda la tv e assista a scene di inaudibile violenza sullo schermo continuando, nonostante ciò, a consumare il proprio pasto. Scene di guerra e profughi non sopravvissuti, notizie di pandemie e crisi ambientali sono diventate di ordinaria amministrazione e continuano a turbarci senza però sconvolgerci irrimediabilmente. È come se ci fossimo abituati a masticare il dolore e a metabolizzarlo in fretta per essere pronti ad abbuffarci di quello del giorno successivo.
Eppure, se questo è possibile, è solo grazie al fatto che tra noi e il dolore altrui, messo in scena dai vati notiziari, c’è una distanza così consistente, uno schermo così spesso che ci permette di provare una sorta di pietà “a breve conservazione”. Una pietà di quelle che rende di certo il boccone un po’ più amaro o, in alcuni casi, immangiabile, che ci fa trasalire sulla sedia o ci scombussola ma solo il tempo di aspettare la pubblicità o di cambiare stanza. Nessuna pietà, insomma, in grado di penetrarci tanto radicalmente da provocare un reale cambiamento, come accade nel momento in cui la sofferenza ci colpisce personalmente.
Leggi anche:
Dalla cronaca alla memoria della guerra in Ucraina
Essere fisicamente distanti dalla sofferenza altrui rende lo spettatore vittima di una sensazione di impotenza che, nella maggior parte dei casi, comporta l’abbandono delle proprie responsabilità e rende insostenibile la possibilità di intervento in contesti così lontani e diversi (“non possiamo farci nulla” è la frase più emblematica dell’atteggiamento preso in questione). Il dilemma dell’azione più adeguata da dover intraprendere appare così insormontabile da venire immediatamente abbandonato e ciò porta alla crisi dell’intervento umanitario da parte dei cittadini nella nostra epoca.
Quanto detto finora trova sicuramente nelle parole dello studioso Luc Boltanski una risonanza maggiore soprattutto quando, tra le pagine del suo lavoro Lo spettacolo del dolore. Morale umanitaria, media e politica, leggiamo:
Lo spettacolo della sofferenza, incongrua quando è contemplata a distanza da persone che non soffrono, e il malessere che questo spettacolo non manca di generare (così evidente oggi quando ognuno, durante il pranzo serale, vede sfilare sotto i suoi occhi, a casa sua, corpi affamati o di massacrati) non è, tuttavia, la conseguenza tecnica degli odierni mezzi di comunicazione, anche se la moltiplicazione dei media e della loro potenza permette di far penetrare la miseria nell’intimità dei focolari felici con un’efficacia mai eguagliata in passato.
In particolare, in un altro suo saggio, La sofferenza a distanza, il sociologo francese individua proprio nella categoria della distanza la causa principale della mancanza di responsabilità dell’essere umano di fronte alla sofferenza dei suoi simili dal momento che, essere fisicamente lontani e distanti, impedisce di vedere e, dunque, di intraprendere un’azione umanitaria.
A questo punto, però, se la distanza rappresenta davvero un deterrente al fine di agire, è lecito chiedersi se esiste un modo per non diventare spettatori passivi talmente abituati alla messa in scena quotidiana del male da essere anestetizzati rispetto alla sofferenza di individui lontani ed estranei in quanto.
Leggi anche:
Della circolarità, etimologica e non, tra senso e dolore
La proposta di Boltanski, rifacendosi ad un’espressione di Hannah Arendt, è quella di dar vita ad una sorta di “politica della pietà” concependo quest’ultima come un sentimento che orbita attorno alla sfera della razionalità e che, dunque, consente di generare una riflessione di carattere generale in grado di stimolare l’impegno collettivo.
Affinché lo spettatore, infatti, avverta dentro di sé la necessità di fare qualcosa è fondamentale partire da un meccanismo di coinvolgimento emotivo che gli permetta di mettersi nei panni dell’infelice per poi passare, in un secondo momento, a strutturare il sentimento della pietà sotto forma di politica che si basa sul riconoscimento di una conoscenza comune di fatti e, dunque, di una collettività informata. Lo spettacolo della sofferenza a distanza trova un senso solo se genera forme di responsabilità sociali che sfociano in un impegno adeguato.
Infatti, la formazione di “comunità responsabili”, costituita da una rete di spettatori attivi e informati (ovvero attivi proprio perché informati), fa venir meno la categoria della responsabilità individuale che corre il rischio dell’abbandono degli obblighi morali ed è la sfida che Boltanski lancia all’epoca globale per curarla dal senso di indifferenza e impotenza.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!