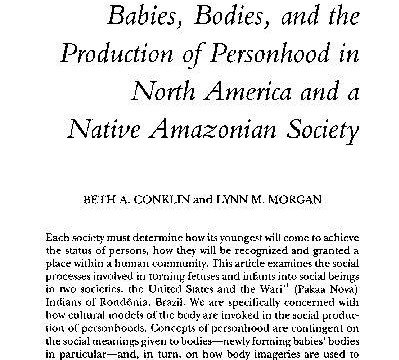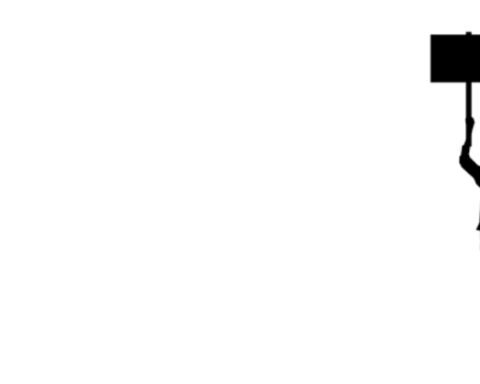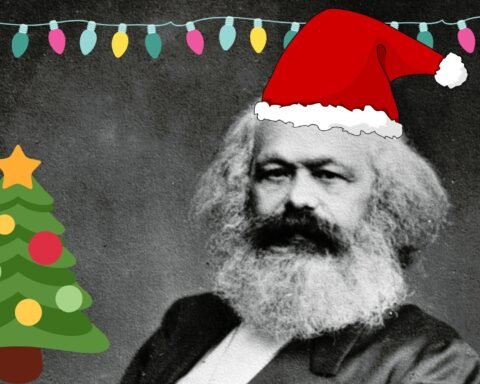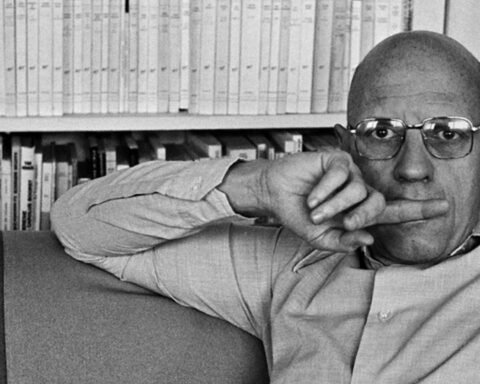Nel 1996 due antropologhe, Beth Conklin e Lynn Morgan, pubblicarono un interessante articolo intitolato Babies, Bodies and the Production of Personhood in North America and a Native Amazonian Society sul concetto di corpo dei Wari’, una minuscola etnia dell’Amazzonia brasiliana che nel 2006 contava poco meno di 3000 individui, connettendolo con il concetto di corpo delle società occidentali, in particolare di quella statunitense. L’intento del paper era di mostrare come, contrariamente a un pregiudizio profondo dell’antropologia (perlomeno implicita) degli occidentali, la dicotomia (noi) individualisti \ (altri) collettivisti non funzionasse.
Nel tentativo di infrangere questa dicotomia, Conklin e Morgan portarono dati etnografici rilevanti per illuminare i problemi di inizio vita e fine vita che la nostra cultura tuttora affronta. Ha senso la coincidenza fra nascita biologica e nascita sociale che la nostra cultura postula in virtù della pratica medica? E la nostra convinzione del corpo come individuo essenzialmente autonomo? Dove finisce il corpo della madre e dove inizia quello del bambino? Ha senso ragionare in termini di proprietà quando si tratta dell’uso della placenta, del cordone ombelicale, degli organi del cadavere e di altro materiale biologico potenzialmente utile a fini medici? Perché usiamo seppellire i bambini nati morti mentre non attuiamo delle simili pratiche funebri per i feti deceduti a causa di aborto spontaneo?
Leggi anche:
L’invenzione della natura (ovvero breve introduzione a Philippe Descola)
I dibattiti bioetici circa la fine vita e l’inizio vita restano rappresi in strutture discorsive consolidate quando non fuoriescono dai limiti della cultura in cui si dibattono: l’intrusione di un elemento estraneo, di un dato etnografico relativamente sconvolgente come la fisiologia Wari’, può gettare nuove prospettive e nuove problematizzazioni in una diatriba che non accenna a soluzioni definitive. Ciò che la connessione fra il dato etnografico e la nostra cultura genera è un disorientamento seguito da ciò che Francesco Remotti definisce «il senso delle possibilità» [1]. Ciò che viene innanzitutto a infrangersi è la presupposizione della naturalità e universalità dei nostri costumi, i quali, alla luce delle variegate forme di umanità, gettati nel mucchio dei costumi, perdono la loro presa e aprono il soggetto al disorientamento e alla possibilità di pensare altro.
Corpo e persona secondo i Wari’
I Wari’ considerano il corpo come «una creazione sociale che è costruita e mantenuta attraverso scambi di sostanze fra corpi individuali» [2], donde il corpo umano sarebbe costituito da sostanze condivise all’interno di una comunità. «Per i Wari’, la carne, il sangue, le ossa, così come certe funzioni biologiche, sono “prodotti sociali” dovuti allo scambio con altri individui» [3]: il corpo dei Wari’ è un affare comune, costituito dalle relazioni della comunità intera. Non solo il corpo è di per sé individuale e relazionale, essenzialmente «poroso e permeabile» [4], ma esso è anche un oggetto costituito da pratiche sociali e culturali.

Foto: O. Cruzeiro (1962)
Fonte: Povos Indígenas no Brasil
Per comprendere questa nozione di corpo distante dalla nostra fisiologia, l’idea di concepimento dei Wari’ può essere illuminante: essi ritengono che il feto sia prodotto dall’incontro fra sangue materno, costituente il sangue del feto, e seme paterno, costituente il corpo, e che un solo amplesso non sia sufficiente alla fecondazione, ma che questa vada ricercata con più atti sessuali, attraverso i quali il corpo del feto si sviluppa e rafforza. Ogni partner sessuale della madre, qualora siano più di uno, vanterà il titolo di padre biologico sul nascituro e avrà diritti e doveri correlati al bambino. Un bambino frutto di un solo rapporto sessuale non è, secondo i Wari’, un bambino sano, e anzi, non avendo avuto il nutrimento, è certamente malato. Sulle pratiche che succedono alla nascita di un bambino frutto di incesto o di un solo rapporto sessuale torneremo più tardi; per ora evidenziamo ciò che Conklin e Morgan individuano: «il feto dei Wari’ incapsula le relazioni fra la madre e il padre e, per estensione, fra i rispettivi gruppi parentali» [5]. Il feto nel modello fisiologico Wari’ è un individuo dotato di un incredibile percezione e autocoscienza, capace di provare amore e individuare i genitori anche quando è ai primi stadi di formazione.
Leggi anche:
Sul corpo
Quest’idea di corpo è ciò su cui si innesta la nozione di persona propria dei Wari’. Per noi lo statuto di persona è qualcosa che si acquisisce con la nascita una volta per tutte: ad esso sono annessi dei diritti inalienabili, ed è a sua volta inalienabile in quanto costitutivo dell’essenza umana. Per i Wari’ la personhood è invece il frutto di relazioni in divenire, che i membri della comunità, e in primo luogo i genitori, devono intessere perché l’individuo divenga tale. Ciò che fa innanzitutto un individuo Wari’ è la condivisione delle sostanze corporee con il gruppo Wari’, l’essere cioè figlio di un Wari’, nella fattispecie di un uomo Wari’: una donna non Wari’ può difatti divenire parte del gruppo se è fecondata da un uomo Wari’; viceversa se un uomo straniero feconda una donna Wari’ non solo il bambino non sarà persona, ma anche la donna perderà gradi di personalità [6]. Risulta chiaro che per i Wari’ vi sia una coincidenza fra l’essere persona e l’essere Wari’ (“Wari'”, in effetti, significa “noi”, “noi persone”), e ciò in virtù della porosità del corpo, della sua permeabilità: sono le sostanze corporee, la loro originaria appartenenza ad altri Wari’, a costituire l’identità d’un corpo e la sua personalità.

Foto: Aparecida Vilaça (1986)
Fonte: Povos Indígenas no Brasil
L’essere figlio di un uomo Wari’ è però più una condizione necessaria piuttosto che sufficiente per essere una persona: altra condizione indispensabile è l’allattamento di una donna Wari’. Quest’atto costituisce la prima relazione del neonato col mondo, relazione che introduce sostanze Wari’ nel corpo del bambino e che lo fa persona.
Leggi anche:
Aborto, donne e maternità: la libertà è solo libertà di scegliere
Per spiegare adeguatamente questa concezione, Conklin e Morgan espongono un avvenimento accaduto nella società Wari’ prima del contatto. Tradizionalmente i Wari’ praticavano l’infanticidio: questa pratica era messa in atto quando il feto non era nutrito sufficientemente, ossia quando nessun maschio si prendeva la briga di continuare a nutrire il feto tramite rapporti con la donna e di provvedere economicamente al bambino nato. Il secondo caso in cui questa pratica s’esercitava era quando il bambino era frutto di un incesto.
Wem Tao, una ragazza di dodici anni non sposata, era coinvolta in una tresca col cugino maschio. Secondo la definizione Wari’, la loro relazione era incestuosa e il matrimonio era fuori questione. Quando Wem Tao rimase incinta, la sua famiglia s’indignò e i parenti anziani discussero se il nascituro dovesse essere lasciato in vita [7].
Fra i più strenui oppositori della vita del nascituro c’era lo zio materno di Wem Tao, Aram, secondo il quale il bambino doveva senz’ombra di dubbio essere ucciso. Gli altri famigliari erano indecisi. Si dà il caso che quando Aram andò a caccia, Wem Tao diede alla luce la piccola e la sua famiglia decise di lasciarla vivere. «Le donne lavarono la neonata, la spalmarono con pittura rossa e la misero fra le braccia di Wem Tao» [8]. La bambina poppò e divenne Wari’. Al ritorno, lo zio s’infuriò e uccise la neonata sbattendo la sua testa contro un ceppo. La famiglia si indignò: quest’atto non era un infanticidio lecito ma un omicidio, perché la bambina era ormai nata socialmente, era una persona, una Wari’.
Conklin e Morgan traggono da questo avvenimento tre conclusioni che riportiamo per intero e che ci saranno utili fra poco:
Questo incidente illumina diversi aspetti su come i Wari’ costruiscono la personalità [personhood]. In primo luogo, rivela la sua contingenza sociale: gli individui non diventano automaticamente persone per il semplice fatto d’essere nati ma devono essere incorporati in una rete sociale. In secondo luogo, mostra come i Wari’ utilizzino scambi (e rotture) di sostanze corporee […] non soltanto per rappresentare le relazioni ma anche per costruire e separare relazioni. Infine, dimostra come un particolare modello etnofisiologico autorizza un particolare gruppo di persone a prendere decisioni sulla vita, la morte e la personalità [9].
Disorientamento fra noi e i Wari’
Il disorientamento è ciò che colpisce quando ci si addentra negli angoli di mondo abitati dagli altri. In un certo senso, il disorientamento è terapeutico: evita la solidificazione del giudizio, fluidifica l’esperienza, chiarifica il vuoto dei nostri significati. Dopo averci gettato nell’incertezza del «giro lungo» e averci invaso col dubbio, fortifica grazie alla vertigine delle possibilità che lascia intravvedere il senso di revocabilità dei nostri discorsi e dei nostri costumi. In breve, allenta la presa della nostra cultura e delle nostre pratiche.

Fonte: Povos Indígenas no Brasil
L’infanticidio Wari’ è per noi certamente abominevole: come possono non riconoscere la personalità di un bambino, ucciderlo? Per certi aspetti, però, anche «i Wari’ non sono consumatori passivi dell’ideologia dominante della loro società» [10] e l’esempio sopra lo mostra. Rimane in ogni caso questo scandalo, questo disorientamento etnografico che noi, in quanto noi occidentali, noi diversi dai Wari’, sperimentiamo. Da dove proviene questo disorientamento? Quali sono le nostre pratiche così consolidate da costituire una separazione netta fra noi e i Wari’ tale da percepire abominevoli le loro pratiche? Si potrebbe porre la questione secondo le coordinate che le tre conclusioni di Conklin e Morgan illustrano: qual è la nostra «contingenza sociale», la contingenza etnografica che ci pone in una prospettiva determinata riguardo alle questioni di inizio vita e di fine vita? Qual è la nostra etnofisiologia, la nostra idea di corpo, e quale nozione di persona ne deriva? Infine, chi, dalla nostra etnofisiologia e della nostre pratiche, viene incaricato di determinare (se non le decisioni) almeno i parametri entro i quali le decisioni circa la personalità, l’inizio vita e il fine vita possono essere prese?
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook e Instagram, e iscriviti alla nostra newsletter!
Innanzitutto noi consideriamo la nascita sociale coincidente con la nascita biologica: una volta nati, si acquisiscono diritti giuridici e morali che vengono presupposti prima e oltre la rete sociale d’appartenenza. Non c’è, in linea teorica, nessuna differenza fra la nascita in un certo luogo o le differenze fisiche e mentali: essere umani significa, per noi, essere persone, e nessun atto o crimine può mettere in questione quest’identità.
Questa nozione di persona s’innesta su un’idea di corpo particolare: il corpo è per noi un ente autonomo, essenzialmente individuale, donde la persona assume i caratteri dell’individualità metafisica e dell’autonomia morale. Anima e corpo si scambiano reciprocamente le caratteristiche e le prerogative, sicché l’inviolabilità dell’uno pone l’inviolabilità dell’altro. Essere persona, infatti, implica l’inviolabilità del proprio corpo: di qui le problematiche circa il fine vita, circa, ad esempio, l’utilizzo degli organi o dei tessuti a scopo medico; individuare la non-personalità in una caratteristica biologica che si perde o si produce, come il sopraggiungere della cosiddetta morte cerebrale, apre alla possibilità dell’utilizzo medico del corpo senza la compromissione della violenza corporea o morale.
Leggi anche:
Corpo e mente: due piani incidenti
Da quest’ultimo problema emerge già chiaramente chi effettivamente instaura i parametri entro i quali prendere decisioni bioetiche, ossia la medicina come pratica e il medico come locutore. Vi è, in effetti, una lotta intestina fra famigliari (o individuo) e medicina nel momento in cui si tenta di introdurre o di vietare l’aborto, l’eutanasia, il testamento biologico o altro. Inoltre la comunità medica non è percorsa da una sola posizione, né il discorso medico appare l’unico criterio, nelle nostre società, di normare la bioetica, giacché si necessita d’un edificio giuridico che convalidi i limiti effettivi delle operazioni mediche. Resta però il fatto che il discorso medico definisce i problemi e le soluzioni circa il corpo, benché sia percorso da tensioni e non detenga l’esclusività della decisione.
Inizio vita, fine vita e persona per i Wari’
Lungi dall’avere un chiaro e univoco quadro, anche la nostra cultura, similmente a quella dei Wari’, non consuma acriticamente una Weltanschauung bioetica e fisiologica, bensì rielabora costantemente le proprie posizioni, i propri limiti, le proprie soluzioni. Tratta di volta in volta in modo diverso l’umanità e trasforma la nozione di persona insieme al corpo sul quale quest’ultima s’innesta. Aborto, eutanasia, trapianto e morte celebrale sono forse i luoghi dove con più intensità si lavora a riformare le nozioni di persona, umanità e corpo.
Umanizzazione e deumanizzazione del feto
Il feto non è soltanto un corpo poroso su cui si tentano di innestare differenti gradi di personalità, ma è anche un oggetto complesso su cui si tracciano diverse linee di potere e sapere. Il feto concentra «costruzioni concorrenti» a seconda della pratica in cui è incapsulato,
come organo della madre, come ente autonomo, come oggetto di lavoro, come proprietà sociale fra, ad esempio, ostetriche, perinatologi, chirurghi fetali, madre incinta e famigliari, attivisti anti-abortisti [11].
Personalità e corpo del feto sono oggetto di dibattito e d’operazione nelle quali viene disegnata, espressa e alimentata una certa forma di umanità. Dove s’innesti l’esser persona del feto è un fatto essenzialmente culturale, che nessuna scienza può con certezza postulare. Resta la problematica di questa dispersione dell’oggetto-feto, che avvicina la nozione di persona occidentale alla concezione dei Wari’, secondo cui il corpo e la persona sono costruzioni processual-relazionali, un affare sociale. In tempi piuttosto recenti, la legislazione italiana ha introdotto la possibilità di tumulare feti e embrioni, enti che un tempo erano trattati come rifiuti sanitari speciali e inceneriti in impianti di termodistruzione (per una disamina più dettagliata si legga qui). Ciò che è in gioco in queste delicate battaglie è la priorità della personalità e umanità della donna rispetto al feto o viceversa.

Foto: M. Fortes (1934)
In generale, anti-abortisti e pro-scelta attuano processi di deumanizzazione e depersonalizzazione rispettivamente della donna e del feto, senza che tuttavia si possa rinvenire un terreno solido sul quale costruire l’universalità della persona. L’idea della personalità del feto già nei primi momenti dopo il concepimento riduce la donna (e in particolare la donna che sceglie di abortire) non solo a una persona di inferiore rilievo rispetto al feto, i cui diritti sono da subordinare a quelli dell’ente che porta in grembo, ma anche a una macchina semi-umana o quasi-umana il cui fine è innanzitutto quello procreativo; si consegna la donna a una supposta naturalità biologica che è al contempo rilevata come morale. Viceversa gli attivisti pro-scelta de-umanizzano il feto individuando in caratteri biologici (ad esempio nello sviluppo della corteccia cerebrale o nella possibile sopravvivenza fuori dal corpo materno) i segni della sopraggiunta umanità e della conseguente acquisizione dello statuto di persona.
Leggi anche:
«L’Atlante delle donne» racconta la condizione femminile nel mondo
Per comprendere l’arbitrarietà, a suo modo necessaria, dell’individuazione della persona, può essere utile un brevissimo excursus etnografico tratto dagli studi di Meyer Fortes sui Tallensi del Ghana settentrionale. I Tallensi considerano nit, cioè persona, loro stessi e dei coccodrilli che vivono in uno stagno nei pressi del loro villaggio. Questi coccodrilli, e non altri, sono considerati persone in quanto «incarnazioni di importanti antenati clanici» [12]. Ciò mostra come la nozione di persona non debba necessariamente coincidere col concetto di umanità, ma che le due idee possano essere separate, mischiate, rese contigue o divergenti a seconda della forma d’umanità e personalità che la cultura intende produrre.
Fine vita: oltrecoma e morte cerebrale
Paradossalmente una cultura che ha formulato un’ideologia fortemente individualista e autonoma della persona e del corpo stenta a riconoscere trasversalmente il basilare diritto all’eutanasia. Anche in questo caso, il motivo è da ricercarsi in una varietà di convinzioni circa la personalità, l’umanità e il corpo, in particolare circa il momento in cui la persona cessa d’essere tale. Il concetto di coma dépassé (oltrecoma o coma irreversibile) può fornirci un ottimo materiale per indagare le mutevoli formazioni della persona nel fine vita.
Leggi anche:
Fine vita: la vittoria di Marco Cappato e la figuraccia della politica
Nel 1959, due neurofisiologi francesi, Pierre Mollaret e Maurice Goulon, proposero di introdurre una quarta figura, la più estrema, nella fenomenologia del coma che in quegli anni individuava, accanto al coma classico (in cui le funzioni della vita relazionali erano abolite, mentre quelle vegetative continuavano), il coma vigile (in cui le facoltà relazionali non erano totalmente assenti) e il coma carus (in cui le funzioni vegetative erano gravemente perturbate). Il coma dépassé è «uno stadio della vita al di là delle cessazioni di tutte le funzioni» [13], nel quale all’abolizione totale delle facoltà relazionali corrisponde l’abolizione totale delle funzioni vegetative. L’oltrecoma andava a riempire uno spazio pratico-teorico situato fra la vita e la morte; una sorta di zona grigia, d’indiscernibilità, in cui, grazie alle nuove pratiche di rianimazione, si poteva dilatare la vita senza che essa presentasse alcuna autonomia: «la sopravvivenza dell’oltrecomatoso cessava, infatti, automaticamente, non appena i trattamenti di rianimazione venivano interrotti» [14]. In questo senso, oltre a interrogare le pratiche tecnico-scientifiche della rianimazione, il coma dépassé problematizzava e ridefiniva la nozione di morte, spostando altrove il limite tradizionalmente individuato nella cessazione del battito cardiaco e della respirazione. Contemporaneamente all’elaborazione teorica dell’oltrecoma, s’andavano a raffinare le tecnologie per il trapianto:
Lo stato dell’oltrecomatoso era la condizione ideale per il prelievo degli organi, ma ciò implicava che fosse definito con certezza il momento della morte affinché il chirurgo che effettuava il trapianto non potesse essere accusato di omicidio [15].
È nel 1968 che il The Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School fissò i nuovi criteri del decesso e introdusse il concetto di death brain (morte cerebrale) per fissare il campo d’operazione di questa pratica. Essa individua la morte nel momento in cui il cervello muore, nonostante il corpo, grazie alle tecniche di rianimazione, continui a respirare e ad avere circolazione cardio-vascolare.

Si comprende subito la paradossalità di tale nozione, a primo acchito ridondante, nella quale alla morte succede la morte. Non entrando nel merito del dibattito scientifico, è interessante articolare i problemi che questo concetto comporta in relazione alla nozione di persona. Singolarmente, la pratica bio-medica sembra situare la personalità nel cervello: la sua morte permette di utilizzare il corpo come materiale organico per il recupero e il riutilizzo di organi e tessuti. Il corpo rimane un corpo umano, ma esso non è più da considerarsi persona, in quanto morto, in quanto semplice corpo organico tenuto in vita dalla pratica medica e senza più funzioni legate della personalità.
Questa circoscrizione della personalità in un elemento biologico permette il pieno accesso al corpo senza particolari remore morali: situare in un organo definito la persona rende la personalità un affare bio-medico, demandando la formazione e il disfacimento sociale della persona ad una pratica scientifica e programmatica. Nancy Scheper-Hughes individua magistralmente il problema di questa riduzione:
Il corpo può essere definito come cerebralmente morto per un motivo (il recupero degli organi) pur essendo percepito come vivo per altri, compresi i legami famigliari, gli affetti, le credenze religiose, o le nozioni di dignità individuale [16].
La persona nel traffico d’organi globale
Il settembre del 1995, a Bellagio, nella provincia di Como, lo storico sociale David Rothman organizzò un piccolo gruppo internazionale di trapiantologi, specialisti in approvvigionamento d’organi, scienziati sociali, attivisti per i diritti umani al fine di formare la Bellagio Task Force on Organ Transplantation, Bodily Integrity, and the International Traffic in Organs. La task force mirava ad esaminare le implicazioni etiche, sociali e mediche della commercializzazione degli organi e a documentare gli abusi riguardanti l’approvvigionamento e la distribuzioni di organi nel mercato globale.

Fonte: Pacific Standard
Il traffico d’organi ricopre uno sterminato campo che dalla donazione dettata da fattori socioeconomici, passando per l’utilizzo di organi dei carcerati deceduti, giunge fino al rapimento dei bambini e al furto di cadaveri. Esso collega «gli strati più alti della pratica biomedica ai ranghi più bassi del mondo criminale» [17], coinvolgendo polizia, lavoratori mortuari, medici, politici locali, banche di organi. Secondo Nancy Scheper-Hughes, il flusso degli organi è lo stesso del capitale: «dal Sud al Nord, dai poveri ai ricchi, dai neri ai bianchi, dalle femmine ai maschi» [18].
Il commercio degli organi è l’effetto della totalizzante mercificazione che il capitalismo mette in atto; materialmente si fonda sulle diseguaglianze sociali, proponendosi come soluzione economicamente vantaggiosa e altruista a situazioni socio-economiche devastanti. Per esempio, le donne povere di Chennai, in India, donano i loro organi come forma di sostentamento famigliare, per ripagare i debiti o quando il marito è disoccupato [19]. A questa pratica soggiace «la logica della reciprocità di genere: il marito “dona” il suo corpo in lavori spesso servili e massacranti mentre la moglie “dona” il suo corpo in una procedura medica» [20].

La donazione d’organi ridefinisce il concetto di corpo e di persona sia negli sperduti (per noi) angoli di mondo, trasformando i significati indigeni precedenti, sia nella nostra società, dove modifica a un tempo l’interpretazione del corpo dei pazienti e dei donatori, e di conseguenza la nozione di persona che su questo s’innesta. Per comprendere il mutamento della nozione di persona e di integrità corporea che investe questi lontani angoli di mondo, è significativo un caso etnografico riportato da Nancy Scheper-Hughes riguardante la provincia brasiliana Pernambuco. Una maestra di scuola, Rosalva, fu persuasa da un lontano cugino a scambiare il suo rene per una piccola somma di denaro:
Nonostante il pagamento Rosalva insisté che si trattasse d’una donazione “fatta col cuore” e per pietà verso il cugino. “Inoltre,” aggiunse, “non ti sentiresti obbligata a donare un organo di cui tu ne possiedi due mentre l’altro nessuno?” [21]
Eppure, prosegue l’antropologa, qualche anno prima, in quella regione, era usanza celebrare riti funebri per le parti del corpo amputate. L’ideologia del dono con cui il traffico d’organi si presenta e giustifica sostituisce le interpretazioni tradizionali del corpo e della sua frammentazione.

Foto: © Pat Roque/AP/Press Association Images
In generale l’idea di corpo che sorge è quella di un corpo fluido, composto di parti interscambiabili, essenzialmente poroso, aperto alle sostanze corporee estranee; un corpo non così dissimile, nella struttura, da quello dei Wari’. È nel corpo del donatore che, in particolare, si introduce una novità: la convinzione del possesso d’un surplus biologico che costituisce una merce rara e perciò stesso economicamente proficua. In questa prospettiva, gli organi doppi, come per esempio i reni, sono considerati una ridondanza, pezzi di ricambio. Su questo corpo periferico della biopolitica contemporanea la nozione di persona autonoma e autodeterminantesi, premessa della bioetica occidentale, non ha presa.
Quale personalità s’innesta sul corpo fluido dei donatori del Terzo Mondo secondo i pazienti del Primo Mondo? In un certo senso, la personalità metafisicamente intesa con la quale si definisce l’individuo occidentale viene surrettiziamente posta anche nell’altro. Senonché l’altro non è considerato nella piena dignità: il suo corpo è innanzitutto un’utilità biomedica che la nozione occidentale di persona maschera con l’autonomia del giudizio e dell’azione.
Cura e pietà: un esercizio antropologico
Vi sono, come abbiamo visto, molteplici modi di trattare l’umanità e di formulare la persona: anche la nostra cultura, che pretende un’autonomia morale e metafisica dell’individuo, ridefinisce socialmente le nozioni di corpo, umanità e persona, nozioni invischiate in un complesso campo di dispositivi di potere-sapere che disperdono l’oggetto in questione a seconda delle prospettive e delle pratiche.
Leggi anche:
I geni sono i veri agenti evolutivi?
Non è certamente lo scopo dell’articolo risolvere i delicati problemi relativi all’inizio vita e al fine vita; il suo scopo è piuttosto la problematizzazione ulteriore di questi temi attraverso la connessione antropologica. Connettere noi ai Wari’, ad esempio, permette di squarciare nell’abitudine definitoria con cui spesso s’affrontano le questioni bioetiche uno spiraglio da cui lasciar penetrare la cura e la pietà.
Marcel Mauss, padre dell’antropologia della persona, in una conferenza svoltasi a Londra e intitolata Une Catégorie de L’Esprit Humain: La Notion de Personne Celle de “Moi”, affermava che la persona, lungi dall’essere naturale e completa, fosse invece «fluttuante, delicata, preziosa,» bisognosa «di un’ulteriore elaborazione» [22]. Era il 29 novembre 1938 e Mauss aveva in mente i terribili eventi che scossero la Germania quell’anno: l’Anschluss, l’occupazione della Cecoslovacchia, la notte dei cristalli. Alla crudeltà disumanizzante, l’antropologia tenta di opporre la cura verso la persona, sia essa la nozione o l’individuo del quale si predica. La connessione etnografica non apre soltanto alla vertigine delle possibilità, ma esercita a coltivare e a comprendere quella delicata, fragile e precaria figura che è la persona.
Segui Frammenti Rivista anche su Facebook, Instagram e Spotify, e iscriviti alla nostra Newsletter
Sì, lo sappiamo. Te lo chiedono già tutti. Però è vero: anche se tu lo leggi gratis, fare un giornale online ha dei costi. Frammenti Rivista è edita da una piccola associazione culturale no profit, Il fascino degli intellettuali. Non abbiamo grandi editori alle spalle. Non abbiamo pubblicità. Per questo te lo chiediamo: se ti piace quello che facciamo, puoi iscriverti al FR Club o sostenerci con una donazione. Libera, a tua scelta. Anche solo 1 euro per noi è molto importante, per poter continuare a essere indipendenti, con la sola forza dei nostri lettori alle spalle.
Note
[1] Remotti, F., Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia (1990), Bollati Boringhieri, Torino 2009, p. 212.
[2] Conklin, B., Morgan, L., “Babies, Bodies and the Production of Personhood in North America and a Native Amazonian Society” in Ethos, 24, 1996, p. 669
[3] Remotti, F., Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia, cit., p. 319
[4] Conklin, B., Morgan, L., “Babies, Bodies and the Production of Personhood in North America and a Native Amazonian Society” in Ethos, cit., p. 669
[5] Ivi, p. 671
[6] Ivi, pp. 676-677
[7] Ivi, p. 680
[8] Ibidem
[9] Ivi, p. 681
[10] Ivi, p. 683
[11] Sharp, L., “The Commodification of the Body and Its Parts”, in Annual Review of Anthropology, 29, 2000, p. 301
[12] Remotti, F., Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia, cit., p. 307. A questo testo si rimanda per una esposizione dettagliata
[13] Agamben, G., Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita (1995), in Homo sacer. Edizione integrale 1995-2015, Quodlibet, Macerata 2018, p. 145
[14] Ibidem
[15] Ivi, p. 146
[16] Scheper-Hughes, N., “The Global Traffic in Human Organs”, in Current Anthropology, 41, 2000, p. 200
[17] Ivi, p. 192
[18] Ivi, p. 193
[19] Cfr. Cohen, L., “Where It Hurts: Indian Material for an Ethics of Organ Transplantation”, in Daedalus, 128, 1999, pp. 147-149
[20] Scheper-Hughes, N., “The Global Traffic in Human Organs”, in Current Anthropology, 41, 2000, p. 195
[21] Ibidem
[22] Mauss, M., “Une Catégorie de L’Esprit Humain: La Notion de Personne Celle de ‘Moi'”, in The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 68, 1938, p. 263
Bibliografia
Agamben, G., Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita (1995), in Homo sacer. Edizione integrale 1995-2015, Quodlibet, Macerata 2018
Cohen, L., “Where It Hurts: Indian Material for an Ethics of Organ Transplantation”, in Daedalus, 128, 1999, pp. 135-165
Conklin, B., “‘Thus Are Our Bodies, Thus Was Our Custom’: Mortuary Cannibalism in an Amazonian Society”, in American Ethnologist, 22, 1995, pp. 75-101
Conklin, B., Morgan, L., “Babies, Bodies and the Production of Personhood in North America and a Native Amazonian Society” in Ethos, 24, 1996, pp. 657-694
Eccles, J., “Evolution of consciousness”, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89, 1992, pp. 7320-7324
Mauss, M., “Une Catégorie de L’Esprit Humain: La Notion de Personne Celle de ‘Moi'”, in The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 68, 1938, pp. 263-281
Remotti, F., Noi, primitivi. Lo specchio dell’antropologia (1990), Bollati Boringhieri, Torino 2009
Scheper-Hughes, N., “Keeping an eye on the global traffic in human organs”, in The Lancet, 361, 2003, pp. 1645-1648
Scheper-Hughes, N., “The Global Traffic in Human Organs”, in Current Anthropology, 41, 2000, pp. 191-224
Sharp, L., “The Commodification of the Body and Its Parts”, in Annual Review of Anthropology, 29, 2000, p. 301